|
|
| |
OGGETTO E SOGGETTI DELLE POLITICHE PER L'AMBIENTE
Ambiente sistema di sistemi, non è statico; diviso in:
biotico = mondo vivente biosfera: suolo, acqua, atmosfera bassa
antroposfera: spazio di vita dell'uomo
abiotico = mondo inanimato solido: litosfera
liquido: idrosfera
gassoso: atmosfera
Ambiente naturale ambiente antropico = cambia lo stato di naturalità e si passa ad una più elevata antropizzazione.
Habitat ambiente particolare in cui vive un determinato individuo; origine: '700 Linneo; non è immutabile.
Nicchia ecologica complesso delle relazioni ambientali in cui l'organismo si riproduce e sopravvive.
ECOSISTEMA insieme degli organismi viventi e dei fattori abiotici presenti in un dato ambiente e delle relazioni che legano fra loro tali elementi; origine anni '30.
M bius = biocenosi.
ECOLOGIA inizio '900, scienza che studia gli ecosistemi, animale
vegetale
Malcevschi modello transdisciplinare:
ambiente vissuto = modalità con cui gli individui percepiscono l'ambiente esterno;
ecosistema = rete di relazioni che NON presuppone un centro, attenzione sui flussi di energia e materia che legano i componenti;
paesaggio = modo in cui un ambiente riconoscibile 929b19j viene percepito da un soggetto culturale;
habitat = posizione di una specie all'interno di un contesto ambientale in cui vive e si riproduce, attenzione ai fattori esterni;
territorio = sistema ambientale governato da un dato soggetto che ne rappresenta il centro;
natura = modo in cui il mondo esterno all'uomo viene percepito da un soggetto culturale.
POLITICHE AMBIENTALI i problemi ambientali agiscono su scala locale e planetaria.
Soggetti:
Organizzazioni Internazionali = effetto serra, deforestazione; difficoltà di intervento in ambiti di patrimonio comune e indivisibile della comunità mondiale;
ECODIPLOMAZIA = dimensione multilaterale degli accordi e degli impegni ambientali.
Conferenza Stoccolma UNEP programma
ambientale ONU
Ostacoli incertezza esiti inquinamento, sostenimento di costi elevati per antinquinamento, osservanza norme e sanzioni.
UE = '73, poi '87 con l'AUE specifica sezione per l'ambiente con 4 obiettivi:
a) salvaguardia, tutela, miglioramento ambiente
b) protezione salute umana
c) razionalizzazione uso risorse naturali
d) promozione misure per risolvere il problema
Normativa comunitaria con 4 strumenti giuridici:
a) regolamenti: subito esecutivi
b) direttive: per applicazione serve promulgazione statale
c) decisioni: destinatario specifico, subito esecutive
d) raccomandazioni o pareri: non vincolanti, per stati o operatori
Programmi d'azione:
'76 = politica ambientale per miglioramento qualità vita:
equilibrio ecologico
riduzione inquinamento
uso razionale risorse
uso di provvedimenti specifici attraverso 3 programmi d'azione statali:
a) riduzione e prevenzione
b) miglioramento qualità vita
c) azioni degli stati negli organismi internazionali
'81 = politiche ambientali per prevenzione con strumenti di analisi adeguati, numerose leggi, regolamenti e direttive
'86 = ha carattere fortemente preventivo, politiche ambientali come politiche strutturali, incentivazione per tecnologie pulite, risparmi energetici, riduzione rifiuti.
'92 = preoccupazione ambientale, sviluppo per qualità ambientali, si pensa alle generazioni future.
'00 = innovazione politica comunitaria per sviluppo sostenibile, riorganizzazione produzione, strategia d'integrazione delle politiche ambientali, interrelazioni fra categorie.
Stati, Regioni, Enti in Italia = tutela paesaggio, arte, salute, suolo, urbanistica, viabilità, foreste, caccia, pesca.
1^ legge 1966 inquinamento atmosferico per riscaldamento, industrie, legge antismog.
tutela acque
istituzione del Ministero per l'Ambiente: obbligo risarcimento per danni, programma triennale per tutela con regioni accordi di programma = strumento politiche ambientali; funzioni:
iniziativa legislativa
normativa efficiente
valido sistema di controllo.
Regioni attività normative e di controllo, smaltimento rifiuti, uso acque, parchi, aree protette
Comuni attività urbanistica
Comunità Montane tutela territorio e ambiente montano.
Agenzie = svolgono funzioni a diverse scale territoriali:
EPA Usa, 1970, federale, funzioni ispettive, emanazione regolamenti, rilascio autorizzazioni, inquinamento aria, energia, rifiuti.
AEA Europa, 1990, gestione sistema d'informazioni europeo per il coordinamento del monitoraggio e dell'informazione.
ADEME Francia
UBA Germania
EPA Danimarca
SNV Svezia
ANPA Italia, ricerca, monitoraggio, informazione, supporto per pianificazione ambientale.
ARPA Regioni, controllo, prevenzioni danni, raccolta e gestione informazioni
Associazioni di cittadini = presa di coscienza, singoli e soggetti organizzati, azioni di protesta, 1986: 12 riconosciute + 5 poi, ora sono centinaia con funzione di sensibilizzazione ambientale.
pressione
politica con le lobby
DIFESA
TRASFOR-MAZIONE
distribuzione del potere politico
codici culturali
Imprese = anni '70: trasformazione tecnologie e ristrutturazione cicli produttivi
Industrie = anni '60 si cambia, prime norme ambientali in Europa e in USA
Scontri = sottovalutazione del problema, lavoratori, gruppi ambientalisti
Riconoscimento = ragioni dell'ambiente miglior efficienza economica
Tecnologia = connubio fra sviluppo ed ecologia
Interventi ambientali:
preventivi ecodesign = nella progettazione si pensano già le conseguenze ambientali del prodotto
attivi riutilizzo dei rifiuti
1991= prima codificazione internazionale CARTA DELLE IMPRESE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE soprattutto nel settore chimico
Obiettivo = impresa ecocompatibile, ecoefficiente con massimi profitti per minimi rifiuti
ECOLABEL
- industrie verdi = operano in campo ambientale e ne costituiscono il BUSINESS.
CAP 2 - QUESTIONE AMBIENTALE: UNA LETTURA IN CHIAVE ECOSISTEMICA
ECOSISTEMA sistema ecologico = insieme di componenti e loro relazioni; unità funzionale di base dell'ecologia composta da:
comunità biotica
comunità abiotica
flussi di energia
retroazione = feedback, un elemento influenza sé stesso.
ECOSISTEMA = Ambiente di Entrata + Sistema + Ambiente di Uscita
Fig. 1 - Schema funzionale di un ecosistema
Energia solare
Decompositori Consumatori (animali - uomini)
Suolo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Minerali
Humus
Detriti
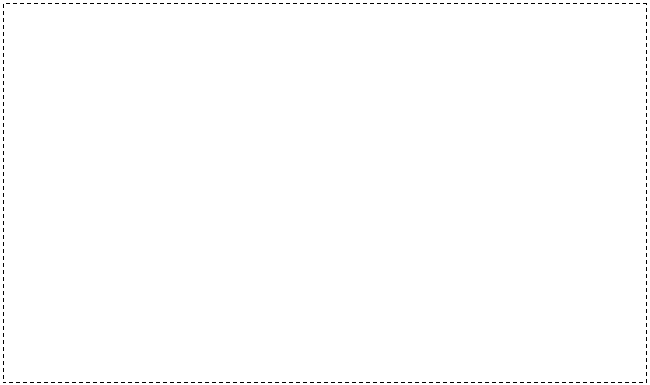
Produttori primari (piante verdi)
Confini ecosistema
Fig. 2 - Ciclo del carbonio
Carbonio in atmosfera Energia solare
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Fotosintesi Materia organica Calore
Fotosintesi Materia organica Calore
![]() Erbivori
Erbivori
![]()
![]()
![]() Consumatori Carnivori
Consumatori Carnivori
Onnivori
Decompositori
![]()
Carbonio in acqua, aria, suolo
TERMODINAMICA = scienza che studia le trasformazioni dell'energia, 3 leggi:
l'energia non si crea né si distrugge, si trasforma
l'energia non può trasformarsi liberamente, l'energia termica può passare da una sorgente calda ad una fredda, NON viceversa.
Sistemi termodinamici:
a) isolati = no scambio energia e/o materia
b) chiusi = scambio di energia ma non di materia
c) aperti = scambio di energia e di materia
ENTROPIA = tendenza spontanea dell'energia verso una forma di calore degradazione a dispersione nell'ambiente 1865 Clausius.
Massima entropia = energia completamente degradata non fornisce più lavoro: equilibrio del sistema.
Sistema aperto = città = struttura dissipativa
" chiuso = Terra
Freccia nel tempo tempo entropico = più velocemente si consumano le risorse e l'energia minore è il tempo di sopravvivenza
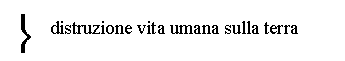
Entropia = inquinamento
Progresso = più cose e più velocemente
Qualità degli ecosistemi elementi:
I. RARITÀ = scarsa disponibilità di un dato elemento, è una relazione alla scala del territorio, non è stabile nel tempo.
II. DIVERSITÀ = totalità dei patrimoni genetici, specie ed ecosistemi, misura: n° specie identificabili in un campione rappresentante una comunità. Indici di diversità = distribuzione specie da scala regionale a biotipo. Governa i cicli che avvengono nell'ecosistema; il n° delle specie è incerto. Rio de Janeiro '92 convenzione sulla biodiversità per assicurarla.
III. STABILITÀ = proprietà dell'ecosistema di resistere alle situazioni di tensione mantenendo l'equilibrio. Prede e predatori.
a) di resistenza statica, l'ecosistema conserva tutte le strutture
passiva = fattori esterni entrano senza provocare risposte negative
attiva = il sistema si attiva per mantenere lo stato iniziale = OMEOSTASI = capacità di un organismo di conservare la propria condizione rispetto alle condizioni esterne.
b) di resilienza = risponde alle pressioni esterne tornando allo stato iniziale = macchia mediterranea, modifica breve con tempi di recupero lunghi. Malleabilità di un sistema = ampiezza dell'intervallo entro cui esso può ristabilirsi dopo aver subito una pressione.
IV. SENSIBILITÀ = dimensioni della risposta ad impatti di origine esterna, diversi livelli; aree sensibili = oggetto di particolari strumenti di tutela.
V. DEGRADO = cambiamento negativo delle caratteristiche sostitutive o funzionali di una realtà ambientale o di una sua componente. Stabilire cos'è la normalità.
VI. INQUINAMENTO = presenza di sostanze estranee che eccedono le capacità ricettive dell'ambiente, prodotto da cause naturali (vulcano) o artificiali (uomo). Misura verso soglie convenzionali per definire il livello di gravità tenendo conto di spazio - tempo.
VII. FRAGILITÀ = facilità con cui un sistema può subire modifiche irreversibili che se rapide mandano al COLLASSO.
VIII. VULNERABILITÀ = complesso di condizioni che concorrono alla perdita della realtà iniziale.
IX. CAPACITÀ DI CARICO = n° organismi o individui di una specie che possono essere indefinitamente mantenuti da un ecosistema o da un'area di ecosistemi.
ECOSISTEMI NATURALI = 1ª classificazione = indicatori:
natura del terreno
risposta biotica ad un ambiente abiotico
indicatore di potenziali impieghi produttivi di un'area ai fini dell'insediamento umano.
climavegetazione
risposta biotica ad un ambiente abiotico
indicatore dei potenziali impieghi produttivi di un'area ai fini
Misura = indice di produttività di Paterson (IP) si basa su:
clima
relazione fra maggiore produttività (potenziale) e:
durata stagionale di crescita
temperatura media mese più caldo
precipitazioni annuali
quantità di radiazione solare
Le variazioni di IP sono:
a) IP > 50 = produttività elevata, zone equatoriali: Amazzonia, Congo, Indonesia
b) IP 10,01 50 = produzione elevata, zona tropicale: Sud America
c) IP 3,01 50 = produzione media, aree più popolate: Est USA, Ovest Europa, India, Sud Cina, Africa savana
d) IP 1,01 3 = bassa produzione: Centro Est Europa, Nord America
e) IP 0,26 1 = scarsa produzione: Nord America, Asia, ex URSS
f) IP < 0,25 = non produzione: Poli, tundra, deserti.
2ª classificazione = concetto di:
BIOMA: principali zone della Terra caratterizzate da particolare vegetazione, fondamentale è l'aspetto associato al tipo di clima.
Unità ecosistemiche: tessere di un ECOMOSAICO.
ECOSISTEMI UMANI = l'ambiente naturale e artificiale sono sovente l'uno nell'altro, a volte la distinzione è difficile.
Moscovici =
stato di natura organico l'elemento essenziale è l'abilità manuale dell'uomo per trasformare l'ambiente circostante;
stato di natura meccanico attività manuali sostituite dalla macchina consumante più energia;
stato di natura cibernetico creazione di cose che non esistono in natura per cui servono molte risorse NON rinnovabili e rifiuti.
ECOSISTEMA AGRICOLO = condizionato da:
conformazione terreni
qualità studi
clima
Agricoltura = processo produttivo che usa e trasforma risorse naturali e antropiche in prodotti, materie prime e servizi.
AGROECOSISTEMA = unità di studio, elementi:
a) risorse naturali: suolo, clima, organismi
b) colture e animali
c) gestione agraria
d) attrezzature, edifici, materiali per processo produttivo.
E' controllato dall'uomo per struttura e funzionalità, fortemente instabili, continua energia flussi energetici:
naturale = energia solare illimitata
ausiliario = combustibili fossili limitati
Odum = differenze fra agroecosistemi ed ecosistemi naturali:
energia ausiliaria = controllata dall'uomo
diversità organismi = ridotta per massimizzare il raccolto
piante e animali = controllati con selezione artificiale
Principio fondamentale = conservazione della sostanza organica del suolo attraverso la ROTAZIONE delle colture
Antichità = ogni area climatica aveva diversi sistemi colturali con associazione di 2 o più vegetali
Meccanicizzazione = la specializzazione colturale, l'accorpamento terreni, la fine rotazione.
![]()
![]()
![]() Modernità = agroecosistemi in difficoltà per
equilibrio fra componenti introdotti e nativi
Modernità = agroecosistemi in difficoltà per
equilibrio fra componenti introdotti e nativi
Instabilità = fisica: erosione
chimica: carenze nutrizionali
biotica: parassiti
![]() Impresa agroindustriale = integrazione fra
agricoltura e industria alimentare
Impresa agroindustriale = integrazione fra
agricoltura e industria alimentare
Agricoltura alternativa:
agricoltura biologica = produzione agricola e zootecnica senza uso di mezzi chimici; obiettivi minimo uso di energia fossile, fertilità con concimazione naturale e compostaggio, uso di strumenti diversificati contro i parassiti, mantenimento della diversità genetica dell'agroecosistema;
produzione agricola integrata = uso combinato di mezzi genetici, agronomici, chimici e biotecnologici per qualità del prodotto e salvaguardia ambiente;
agricoltura biodinamica = movimento antroposofico di Steiner, pratiche colturali in base ad influenze cosmiche.
ECOSISTEMA INDUSTRIALE = 1ª classificazione: industria - ambiente
È più evidente l'intrusione nella natura da parte dell'uomo, colpevole del degrado ambientale; approccio difensivo, problemi minimizzati, ridimensionamento responsabilità attribuendole anche a livello di micro comportamenti umani. Mondo industriale ambiente = costo inevitabile, evoluzione verso MANAGEMENT AMBIENTALE in 3 fasi:
ecologia passiva ambiente = vincolo da rispettare per non avere sanzioni;
ecologia attiva si vedono i vantaggi del vincolo ambientale = nuovi mercati;
ecologia integrata ambiente = è una variabile strategica, fattore chiave.
2ª classificazione: ecologia industriale
Per stabilire un'analogia tra sistemi naturali e industriali e osservare come nell'ecologia industriale ogni processo e rete di processi è interrelata con un insieme più vasto. Analogia per capire i cambiamenti effettuabili, riorientamento dei processi produttivi; ecosistema sostenibile completa ciclicità con scala temporale sufficientemente lunga.
ECOSISTEMA CIRCOLARE = concezione del sistema produttivo in senso allargato, l'ambiente è
fattore di produzione e consumo, si devono ottimizzare le caratteristiche dell'ambiente, uso dei rifiuti come nuove materie prime.
ECONOMIA LINEARE = modo tradizionale di produrre: dalle risorse naturali alle discariche con doppio impatto sull'ambiente.
DEMATERIALIZZAZIONE = dello sviluppo economico: riduzione del contenuto di materia e di energia per unità di prodotto,
aumenta l'informazione e sviluppa servizi immateriali o a basso consumo di risorse. Fenomeno di lunga durata legato a cambiamenti di lungo periodo nella natura della tecnologia, dell'economia e della società. Agisce a tutto campo. Non è corrisposto un miglioramento della qualità ambientale perché:
a) la miglior efficienza ambientale non copre la crescita dei consumi di materie prime industriali
b) la crescita consumi in altri settori è in funzione della valorizzazione del prodotto industriale.
AMBIENTE INTERNO = sotto il diretto controllo dell'impresa
AMBIENTE ESTERNO =
spazi differenziati rispetto alla scala degli impatti:
a piccola scala: planetari, gas - serra;
a media scala: continenti e oceani;
a grande scala: regioni;
a grandissima scala: ecosistemi locali.
spazi differenziati rispetto alla vulnerabilità del processo produttivo, articolato in:
INPUT di energia, materie prime e componenti = combinazione di materiali:
vergini
riciclati all'interno del processo produttivo
riciclati all'esterno del processo produttivo
processo di produzione/trasformazione = INPUT trasformati in
OUTPUT = che consistono in:
prodotti di output prefissati
rifiuti o emissioni, inevitabili conseguenze del processo produttivo
sottoprodotti.
FONDAMENTALI ASPETTI PROBLEMATICI
inquinamento da produzione = concentrato, rilascio di sostanze dannose nell'ambiente da
parte dei processi produttivi;
inquinamento da consumo = a forte diffusione, rilascio di sostanze inquinanti nella
fase di consumo e di post - consumo da parte dei
consumatori, considerati un fondamentale impulso
di cambiamento dato che possono condizionare il
comportamento dei politici e del sistema produttivo;
distinzione fra risorse rinnovabili e non rinnovabili
tecnologie pulite = interventi da parte dell'impresa al fine di ridurre l'impatto dell'industria, considerando la diminuzione dei rifiuti in rapporto a quantità invariata di prodotti e/o input.
LIVELLI DI INTERVENTO PER RIDURRE L'IMPATTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ognuno ha diversi input di materie prime, emissioni e produzione rifiuti:
interventi sul processo produttivo:
a) trattamento a valle = conversione dell'output indesiderato in output più smaltibile; sono interventi aggiunti alla fine del ciclo produttivo per trasformare l'emissione in forme più gestibili; cambiamenti che non offrono nessun ritorno del capitale investito, si aggiungono al costo di smaltimento, breve periodo;
b) recuperi a valle = sono interventi al termine del processo produttivo, realizzati riutilizzando le emissioni invece di smaltirle subito;
c) riduzione rifiuti/emissioni = ottimizzazione del processo di produzione, riduzione energia, aumento efficienza trasformazione da materia prima a prodotto, riduzione output utilizzati;
d) sostituzione materiali utilizzati nel processo produttivo = riduzione del potenziale impatto
ambientale di un'emissione, invece di ridurne la quantità prodotta; es. decarbonizzazione = riduzione dell'impiego del carbonio per la produzione di una certa quantità di energia;
e) radicale ridisegno del processo produttivo = modifica introducendo nuovi processi o sostituendo particolari fasi della produzione.
cambiamenti nei prodotti:
a) mutamento materiali senza mutazione disegno;
b) ridisegno prodotto per riduzione impatto ambientale associato al processo produttivo;
c) ridisegno prodotto per riduzione impatto ambientale nell'uso dello stesso;
d) ridisegno prodotto per aumentare la ricuperabilità e diminuire le conseguenze di impatti negativi;
e) ridisegno durabilità di un prodotto.
ridisegno radicale dell'insieme produzione - consumo: dei processi e dei prodotti, cambiamenti
radicali con ristrutturazione dell'industria: es. auto = riduzione impatto gas e combustione, oppure auto elettrica.
ECOSISTEMA URBANO = continuum di ecosistemi a diverso grado di naturalità - artificialità massima in ecosistemi industriali e urbani.
Odum ecosistema eterotrofo, incompleto, dipendente da ampie aree limitrofe per energia, cibo, fibre, acqua. Motivi per cui la città è diversa da un ecosistema naturale eterotrofo:
metabolismo più intenso per unità di area richiedente flusso di entrata più consistente di energia concentrata,
grande richiesta di entrata dei materiali;
uscita più forte di sostanze di rifiuto velenose.
Città moderna = parassita dell'ambiente rurale perché produce poco o niente cibo, non purifica l'aria e non ricicla l'acqua o materiali inorganici.
Wolman metabolismo urbano = insieme di materiali e beni per abitanti nel lavoro, a casa, nel tempo libero, materiali di ricostruzione della città, prodotti di scarto con la cui rimozione si chiude il ciclo metabolico: identificazione delle relazioni quantitative (domanda risorse) e qualitative (gestione risorse) tra stato dell'ambiente e livello di pressione delle attività.
3ª definizione città = macrosistemi = mosaico di ecosistemi abiotici urbano - industriali mescolati a sistemi biotici. Senza l'apporto di cibo, carburanti, energia dall'esterno, la città non potrebbe vivere.
Urban ecological footprint misura totale dell'area produttiva richiesta per supportare la popolazione di un'area urbana (per misurare l'impatto della città sull'ambiente globale).
L'ecosistema urbano è in costante squilibrio energetico nei confronti di un ambiente esterno sempre più esteso.
4ª definizione città self - reliant = fondata su sé stessa, valorizza le risorse locali utilizzandole in modo integrato, diminuendo gli scarti e aumentando la produzione di sottoprodotti e materie riutilizzabili, alta densità di lavoro ed equilibrio fra città e campagna.
FENOMENI DI DEGRADAZIONE ECOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI
INQUINAMENTO = è l'alterazione di una data realtà ambientale in conseguenza all'immissione di energia o di sostanze estranee che eccedono le capacità ricettive di tale ambiente.
Degrado ambientale = situazione che si allontana dallo stato ottimale.
Provocato da fenomeni naturali (vulcani, incendi) o da attività umane (più importante).
Sistematizzazione delle forme di inquinamento nella categoria STRESS ANTROPOGENICI come fattori limitanti per le società industriali:
stress acuto = insorgere improvviso della perturbazione, breve durata, forte intensità;
stress cronico = perturbazioni di lunga durata o ricorrenti frequentemente.
Tipi di inquinamento:
a) del suolo intaccamento della qualità che permette la vita animale e vegetale, cause:
fisiche = erosione del suolo, escavazioni, estrazioni minerarie;
chimiche diffuse = sedimentazioni di acque superficiali contaminate, dispersione fertilizzanti dannosi;
chimiche puntiformi = discariche, depositi di sostanze pericolose.
b) idrico acque dolci = modificazione corpi idrici in grado di alterare il funzionamento dei cicli chimici e biologici, cause:
scarichi organici eccedenti;
scarichi di nitrati e fosfati agricoli;
scarichi di sostanze tossiche industriali, urbane, agricole;
inquinamento termico tramite deflussi a temperature elevate da centrali termoelettriche
marino = modificazioni ecosistema causate da attività umane in:
modo diretto = scarichi urbani e navi;
modo indiretto = fiumi.
c) atmosferico alterazione composizione chimica dell'aria, origini naturali e antropiche, provocato da:
inquinanti primari = immessi direttamente nell'atmosfera;
inquinanti secondari = si producono per trasformazione dei primari.
Smog fotochimico = prodotto dall'azione della luce del sole sullo smog da auto, industrie, combustione.
Esiste anche l'inquinamento acustico.
Fonti inquinamento atmosferico:
attività industriali;
fonti di produzione energetica;
impianti di riscaldamento urbano;
traffico auto.
Odum = l'inquinamento dell'aria favorisce il feed - back negativo che potrebbe salvare la società industrializzata dall'estinzione perché:
è un chiaro segnale d'allarme percepito da tutti;
ognuno vi contribuisce e ne subisce le conseguenze.
DEFORESTAZIONE = taglio di essenze legnose che superi il loro tasso di rigenerazione a scopi energetici o per ampliare la superficie delle terre coltivate, o per costruire navi e abitazioni.
Foreste pluviali, monsoniche ed equatoriali, legname duro da opera (ebano, tek)
taglia e brucia tecnica per cui si coltiva un certo tipo di prodotto.
Conseguenze:
a) impoverimento genetico = distruzione di specie animali e vegetali a ritmo elevato, molte specie scompaiono, impoverimento diversità genetica, conseguenze irreversibili per colture ed allevamenti;
b) diminuzione della regolazione dei flussi idrici = manca la copertura forestale,
piene dei fiumi, esondazione, erosione, magra, prosciugamento. Città = brown out = oscuramento parziale dovuto ai sedimenti trasportati dall'acqua sin dentro le centrali elettriche;
c) effetti sul clima = incendio foreste anidride carbonica effetto serra riscaldamento globale effetti catastrofici;
d) diminuzione assorbimento radiazioni solari = aumento della luminosità della
terraferma massima riflessione energia solare nello spazio (effetto albedo) alterazione della circolazione correnti atmosferiche e precipitazioni. Paesi più industrializzati vogliono la fine della deforestazione, i Paesi meno industrializzati rivendicano il loro diritto di sovranità.
EROSIONE DEL SUOLO = asportazione porzione superficiale della terra ad opera dell'acqua e del vento, impoverimento humus foreste tropicali, savane, steppe, deserto. Cause molteplici, tutte attività umane:
agricoltura = deforestazione;
sovrapascolamento = eccessivo sfruttamento dei pascoli che incide sulla cotica erbosa
compattazione suolo
aumento superficie urbanizzata
Valori più elevati:
a) montagne della zona tropicale e subtropicale umida
b) rilievi della zona semiarida
c) grandi pianure deserte asciutte in questo caso è DESERTIFICAZIONE = espansione o intensificazione di
caratteri di tipo desertico in ecosistemi che non sono deserti naturali.
Cause = eccessiva coltivazione, sovrapascolamento, disboscamento, irrigazione impropria.
PROBLEMA DEMOGRAFICO = l'aumento della popolazione umana è la principale causa del problema ecologico, la crescita è dovuta a:
aumento del tasso di natalità
diminuzione del tasso di mortalità
variazione tassi a velocità diverse.
Metà XVIII secolo rivoluzione demografica: basso aumento demografico con alta mortalità basso aumento demografico con bassa mortalità e natalità.
Transizione demografica = periodo di mezzo con alta crescita della popolazione perché la natalità si abbassa meno velocemente della mortalità.
Natalità fattori economici e culturali
Mortalità fattori igienico - sanitari
Dumont sulla sicurezza alimentare mondiale gravano 4 minacce:
a) mutamento climatico
b) diminuzione acqua e combustibili fossili
c) degrado sei suoli
d) liberalismo economico
L'ampliamento delle aree urbane è l'effetto di:
conurbazione = è l'espansione della città verso le zone agricole e formazione di un'area urbana continua contenente più città prima separate;
agglomerazione = è l'espansione del centro urbano che ingloba i comuni limitrofi.
Anni '80:
controurbanizzazione = deconcentrazione urbana cui corrisponde una ripresa demografica di aree urbane piccole e medie. Enorme richiesta di energia da parte di aree urbano - industriali densamente popolate.
1994, Il Cairo Conferenza dell'ONU sulla popolazione e lo sviluppo. Punto centrale = rovesciare i tradizionali poli della contraddizione esistenti tra la sovrappopolazione e lo sviluppo.
Sovrappopolazione = conseguenza della difficoltà di raggiungere uno sviluppo sostenibile, lo sviluppo contiene la crescita demografica.
CAP 3 - EVOLUZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTE - SVILUPPO
Ambiente - sviluppo questione recente, sottende il rapporto uomo - natura e la sua evoluzione. La natura non esiste all'infuori dell'uomo ma esiste solo perché è possibile riconoscervi qualcosa, che non è l'uomo, a cui dare significato. Il dibattito interessa scienze sociali e naturali.
SVILUPPO CONCEZIONE OCCIDENTALE DEL XVII SECOLO:
analogia biologica = processo attraverso cui vengono rilasciate potenzialità di un oggetto o di un organismo fino al pieno raggiungimento della sua forma naturale e completa;
progresso
fine
1700 = dalla biologia alle scienze sociali
![]() evoluzione
evoluzione
sviluppo
![]() crescita
crescita
IDEOLOGIA DELLA MODERNIZZAZIONE
Modello di Rostow (5 stadi, da società tradizionale a quella dei consumi di massa). Caratteri:
fede nell'evoluzionismo sociale e culturale;
illimitatezza risorse naturali;
razionalità economica regola il sociale e i rapporti con la natura;
crescita industriale necessaria per lo sviluppo.
Produttivismo sostituzione del fine (benessere dell'uomo) con il mezzo (crescita economica). Legame con evoluzionismo sociale, caratterizzato da TRIPLICE RIDUZIONISMO:
un solo modello di sviluppo
fine: crescita economica
benessere: consumo e accumulo di merci
Sviluppo economico = paesi sottosviluppati, trasformazioni qualitative
Crescita = paesi sviluppati, trasformazioni quantitative
Sviluppo = 2 tipi:
a) TOP DOWN sviluppo dall'alto, monolitico ed uniforme, sistemi di valori e soddisfazioni umane che si diffondono al mondo intero.
b) BOTTOM UP sviluppo dal basso, si ha la necessità di massima valorizzazione delle risorse regionali, attivazione e controllo locale dei meccanismi endogeni di generazione e di sviluppo.
Concezioni di sviluppo:
positivo - normativa = distinzione tra studio dello sviluppo così com'è e come dovrebbe essere
formale - sostanziale = distinzione fra crescita e sviluppo;
formale è lo sviluppo in termini universali con indicatori quantificabili
sostanziale è lo sviluppo comportante cambiamenti sociali più quantitativi e meno prevedibili.
ETICHE AMBIENTALI
Antropocentriche valore strumentale natura;
approccio tecnocentrico = razionalista rispetto al rapporto con l'ambiente.
Conservazionisti = conservazione risorse e ambiti di vita vivibile.
Preservazionisti = presume intatto almeno parte del mondo naturale, difesa della wilderness.
Ecocentriche valore intrinseco natura: sensibilità, vita e capacità protettiva;
approccio ecocentrico = posizioni più radicali e utopistiche, visione conservativa della relazione società - natura.
Immagini paradigmatiche estreme al cui interno si è sviluppato questo dibattito negli ultimi 30 anni sono:
FRONTIER ECONOMICS antropocentrica, la natura è sorgente inesauribile di risorse fisiche, deposito illimitato di sottoprodotti (inquinamento e degrado ecologico). Economia separata dalla natura.
Base = fiducia nel progresso tecnologico, concezione riduzionistica della natura al servizio dell'uomo.
sviluppo = crescita economica illimitata
credo incondizionato in un'ampia disponibilità di risorse
soluzioni altamente tecnologiche
consumismo
sistema socioeconomico centralizzato.
DEEP ECOLOGY ecocentrica, ampio ventaglio di posizioni, enfasi sugli elementi etici, sociali, spirituali, invoca la fusione di alcuni punti di vista dell'ecologia dei sistemi con una visione armoniosa e biocentrica delle relazioni tra uomo e natura.
Base = ideologia dello sviluppo economico fondato su modelli alternativi, ipotizzando percorsi di sviluppo in armonia con la natura.
Aspetti principali:
eguaglianza della biospecie
riduzione della popolazione mondiale
bioregionalismo
promozione della diversità biologica e culturale
pianificazione decentrata
economie non orientate alla crescita
tecnologie appropriate.
Ipotesi GAIA la Terra costituisce nel suo insieme un sistema vivente in grado di autoorganizzarsi e di autorinnovarsi per continuare a vivere indefinitamente. (J. Lovelock).
3 diversi approcci:
PROTEZIONE AMBIENTALE anni '60, inquinamento per acque interne, patrimonio artistico, ambiente marino, reazione al diffondersi degli effetti negativi sull'ambiente, lotta contro i rifiuti indesiderati.
Logica = interventi a valle, dispersione degli inquinanti, protezione ambiti circoscritti e specie in via di estinzione.
Approccio regolativo = politica del comando e del controllo, con istituzione di agenzie o ministeri.
GESTIONE RISORSE anni '70, internazionalizzazione del dibattito fra le Conferenze di Stoccolma '72 e Rio de Janeiro '92.
Fulcro = ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per incrementare la conservazione delle risorse e l'efficienza energetica.
Problema = economizzare l'ecologia, ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse naturali.
Obiettivo = internazionalizzazione dei costi ambientali
Anni '80 = l'industria non è più solo difensiva.
1ª definizione
SVILUPPO SOSTENIBILE obiettivo politico, paradigma politico nelle mani degli attori umani![]() Brundtland:
Brundtland:
sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità dei posteri di soddisfare i propri. Implica 2 concezioni chiave:
a) bisogni dei poveri che hanno la priorità nella scelta delle politiche;
b) riconoscimento delle limitazioni imposte dalla tecnologia e dall'organizzazione sociale alla capacità ambientale di soddisfare esigenze presenti o future.
Crescita = concetto quantitativo misurabile con reddito pro capite
![]() Sistema di
obiettivi:
Sistema di
obiettivi:
integrità ecosistema = bisogna evitare trasformazioni irreversibili
efficienza economica = perseguimento in senso ecologico, più è alta meno uso di risorse non rinnovabili, più uso di risorse rinnovabili
principio di equità sociale =
intragenerazionale: singola comunità
![]() Sostenibilità debole
= possibilità di sostituibilità fra capitale naturale e ricchezza prodotta
dall'uomo: ogni generazione può degradare l'ambiente rimpiazzandolo con
capitale prodotto dall'uomo.
Sostenibilità debole
= possibilità di sostituibilità fra capitale naturale e ricchezza prodotta
dall'uomo: ogni generazione può degradare l'ambiente rimpiazzandolo con
capitale prodotto dall'uomo.
2ª definizione
Sostenibilità forte = bisogna lasciare ai posteri lo stesso stock di capitale naturale, che non può essere rimpiazzato da quello artificiale.![]() Sostenibile è uno sviluppo la cui domanda di risorse
e la cui pressione esercitata attraverso l'emissione di sostanze inquinanti non
superi le capacità di assorbimento e di riproduzione dell'ambiente, ne derivano
3 principi guida:
Sostenibile è uno sviluppo la cui domanda di risorse
e la cui pressione esercitata attraverso l'emissione di sostanze inquinanti non
superi le capacità di assorbimento e di riproduzione dell'ambiente, ne derivano
3 principi guida:
un uso sostenibile non deve superare la capacità e i tempi di ripristino ambientale delle risorse naturali rinnovabili;
l'uso di risorse non rinnovabili deve avvenire entro i limiti definiti dal tasso di rinvenimento delle risorse stesse, estendendo il ciclo di vita dei materiali e sostituendo con risorse rinnovabili;
![]() Dagli anni '70 - '80 si ha una progressiva
globalizzazione della questione ambientale.
Dagli anni '70 - '80 si ha una progressiva
globalizzazione della questione ambientale.
![]() Rapporto locale/globale = problema in prospettive
diverse a seconda di come viene inteso il rapporto stesso.
Rapporto locale/globale = problema in prospettive
diverse a seconda di come viene inteso il rapporto stesso.
4 prospettive:
a) globale = nega autonomia al locale che è sorgente circoscritta di pressioni ambientali; esistono situazioni di:
insostenibilità locale = impresa che degrada risorse locali;
insostenibilità in altri paesi = nell'area considerata si consumano risorse provenienti da paesi terzi o si producono sostanze che si riversano su di essi;
insostenibilità globale = il consumo eccessivo di risorse naturali provoca danni all'ecosistema terrestre.
Economia aperta, 2 aspetti centrali:
l'uso di risorse umane e naturali è sostenibile?
quanta sostenibilità è importata dal Resto del Mondo?
b) analitico-operativo = più attenzione al locale perchè è lì che bisognerà implementare le strategie di sviluppo sostenibile. Affrontare il problema a livello locale per esigenze operative.
Teorema della località quanto più è locale un problema tanto più:
cresce l'identità fra inquinatore e vittima;
"chi inquina paga" è applicato;
molti inquinatori = più omogeneità sociale = obiettivi e bisogni più condivisi.
c) politico-normativo = sviluppo endogeno dal basso, concetto di ecosviluppo per esplicitare il locale.
d)
epistemologico
= il locale è un livello intermedio con capacità organizzative e di identità
introdotto a fini analitici e per la comprensione dei fenomeni reali.
Approccio territoriale
![]() Concetto in rapporto ad un dato contesto geografico;
la territorializzazione si ha per 2 ragioni:
Concetto in rapporto ad un dato contesto geografico;
la territorializzazione si ha per 2 ragioni:
impatto ambientale, capacità di carico, criticità ambientale devono essere tutti riferiti ad un
determinato ecosistema e ad un contesto locale definito;
Città oggetto privilegiato di attenzione, ecosistema con grado di artificialità molto alto, le pressioni ambientali raggiungono livelli critici e la loro densità è massima. Per definizione è insostenibile in senso stretto, in costante squilibrio energetico con l'ambiente esterno, ecosistema eterotrofo.
Sviluppo urbano sostenibile minimizzazione delle importazioni di risorse naturali ed esportazione rifiuti massimizzazione della protezione del capitale ambientale e del costruito locale.
Lettura dell'ambiente urbano a 3 livelli:
qualità ambientale città = dimensione più visibile, ambiente naturale, socio-economico, estetico e culturale;
metabolismo urbano = sistema di funzionamento urbano: flusso di risorse sostentanti, processo di trasformazione, consumo beni e servizi, rifiuti per l'ambiente;
struttura urbana = insieme di relazioni spaziali in città e tra città e territorio, dettate da forma e funzioni urbane, regola il metabolismo urbano e ne è influenzata.
Breve periodo = sostituzioni fra input del processo produttivo senza mutare la struttura del processo stesso.
Lungo periodo = cambiamenti tecnologici in forma urbana e nei modelli culturali che presiedono stili di vita e organizzazione della città.
Città sostenibile = interazione dinamica fra ambiente costruito, antropico e naturale.
P 4 - CONCETTI E STRUMENTI DELLE POLITICHE AMBIENTALI
Definizione = vasto insieme di interventi volti a gestire in modo razionale le risorse dell'ambiente.
Obiettivi = controllo forme di inquinamento
![]() tutela aree e ecosistemi
tutela aree e ecosistemi
riparazione e prevenzione danni ambientali
incentivazione all'utilizzo di energie pulite
Non sempre sono un corpus organico di leggi, norme ed interventi.
Nascita = anni '60; Italia = "inquinamento" nel '65 per pesca marittima
Breve periodo = recupero azioni per riportare le condizioni ambientali entro il livello di tolleranza massima;
ripristino di equilibri preesistenti o di un nuovo equilibrio.
Lungo periodo = ricercano situazioni di equilibrio dinamico, innescamento di meccanismi coerenti con gli obiettivi di sostenibilità adottati dalla Comunità Internazionale.
Interventi di:
mantenimento delle condizioni ambientali la di sopra delle soglie di tolleranza delle alterazioni;
miglioramento per equilibri ambientali consoni ai modelli della Comunità;
prevenzione per diminuire la necessità e le dimensioni della politica ambientale stessa.
Disinquinamento = interventi a valle dei processi di inquinamento: 1ª generazione.
Prevenzione = interventi a monte dei processi di inquinamento: 2ª e 3ª generazione
Italia = forte contrapposizione
POLITICHE DI RISANAMENTO l'obiettivo è riportare e mantenere l'inquinamento entro soglie di tolleranza. La fissazione dei livelli dipende dagli ecosistemi e dalle conseguenze.
Teoria limite: la capacità di carico non è definibile in termini operativi.
3 strategie:
a valle = intervento a valle del processo produttivo trattando gli scarti indesiderati per renderli più assorbibili; c'è cumulabilità di effetti avversi, indispensabile per breve periodo;
recupero = riciclo, a valle dei processi di consumo degli scarti per minimizzare le emissioni nocive e lo spreco di risorse; medio grado; difficoltà: dipende da tecnologie disponibili in relazione al grado di ricuperabilità del prodotto, dalla sua convenienza, dall'esistenza di un mercato per materie prime secondarie;
modifica prodotti/prezzi = lungo periodo, legata a tecnologie adeguate, convenienza economica, rapidità di sostituzione degli impianti, riprogettazione del processo produttivo, radicale ridisegno produzione-consumo.
Strumenti:
REGOLATIVI = "chi inquina paga", base delle politiche ambientali nelle economie industriali di tipo misto.
Logica = COMANDO-CONTROLLO = fissazione di norme per definizione comportamenti la cui esplicazione è sottoposta ad un'azione di accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione.
4 tipi di norme COMANDO-CONTROLLO con fissazione di altrettanti standard:
a) norme di emissione = fissati i livelli massimi inquinanti si impone al produttore la depurazione dei propri scarichi entro i limiti fissati dagli standard, sono le principali leggi ambientali;
b) norme di qualità = si regolamenta la qualità ambientale di un determinato corpo ricettore a seguito di un'emissione, trattamento differenziato per aree geografiche ed attività economica;
c) norme di prezzo = si richiede che il processo produttivo sia svolto rispettando determinati requisiti, strumento per incentivare l'utilizzo di energie e tecnologie pulite; EPA: impone il principio della BAT = Best Available Technology, viene prescritto per legge il ricorso alle migliori produzioni con limiti solo per fattibilità tecnica o costi elevati;
d) norme di prodotto = disciplinano le caratteristiche di determinati prodotti o beni, con obiettivo di favorire la produzione di prodotti più puliti, di maggior durata e minor consumo energetico: automobili catalitiche e benzina senza piombo.
Limiti - richiedono efficiente operato di controllo, costoso
gli standard differenziati sono usati in modo indiscriminato
gli strumenti regolativi non sono un incentivo per cercare tecnologie più pulite
difficile regolazione degli standard
esclusione del livello locale delle decisioni
Sono comunque prerequisiti irrinunciabili per qualsiasi politica ambientale, con efficacia per inquinamenti inaccettabili ed effetti irreversibili.
ECONOMICI = volti a modificare i prezzi di mercato delle risorse, dei beni e dei servizi per mezzo di azioni governative che riguardano i costi di produzione e/o di consumo. Italia: tassa sui sacchetti di plastica, prevede l'intervento dell'operatore pubblico. Tasse = strumento preferito dagli economisti, ma con uso limitato e scarsi favori. Regolamentazione indiretta attraverso la modifica del sistema delle convenienze di mercato.
Strumenti 3 gruppi:
a) incentivi, sovvenzioni e sussidi applicato nelle prime fasi di utilizzazione di una nuova norma ambientale, l'inquinatore riceve sovvenzioni per ridurre le proprie emissioni al di sotto di certi livelli di inquinamento;
b) tasse ambientali livello di ottimo inquinamento, eguagliare costi di depurazione a costi di ripristino del danno ambientale, ma l'individuazione dell'aliquota ottima è irrealistica per cui si sceglie la tassazione:
efficiente = aliquota sufficientemente elevata con obiettivo di riduzione sensibile dell'inquinamento
redistributiva = aliquota più bassa, riduzione scarsa dell'inquinamento ma finanziamento degli impianti di depurazione.
Scopo delle tasse provocare un aggravo di costi che provochi la contrazione della domanda di risorse ambientali e dell'inquinamento CHI INQUINA PAGA.
4 tipologie di tasse ambientali:
tasse sulle emissioni = si pagano in base alla quantità ed alla qualità delle emissioni o degli scarichi, tassa per l'inquinamento versato. Fra diverse industrie con costi diversi di depurazione, si fa depurare chi ha i costi più bassi;
tasse sui prodotti = applicate per disincentivare i prodotti che generano inquinamento producendoli o consumandoli, sostituibili con altri prodotti. Obiettivo è segnalare al consumatore un prodotto dannoso fornendogli un incentivo per cambiare o ridurre il consumo di quel prodotto;
tasse per servizio reso = tariffe per il ritiro e il trattamento degli scarichi e dei rifiuti in strutture collettive, pubbliche e private. Sono incitative e proporzionali alla quantità e alla qualità;
tasse con deposito a rendere = obbligatorie per legge, imposte su imballaggi o prodotti che si desidera far restituire dopo l'uso.
Italia = applicate alcune tariffe ambientali e alcune tasse sui prodotti.
Rispetto alle tasse ci sono 3 alternative:
compensazione entrate tasse ambientali con riduzione di entrate di un'altra imposta;
le entrate sono usate per finanziare interventi o sussidi per l'ambiente;
le entrate aumentano quelle globali del sistema tributario.
|
TASSE |
STANDARD |
|
si paga comunque |
propongono una rendita: fino al livello consentito NON si paga |
|
preferite dalla collettività |
preferiti dagli imprenditori |
|
incentivano il progresso tecnico |
si può sfuggire ai controlli |
|
preferite dagli ambientalisti |
4. sono preferiti dal mondo politico- amministrativo perché più vicini alla logica burocratica |
|
spostano la domanda da un prodotto ad un altro meno inquinante |
|
REALTÀ = si usa un sistema misto con politiche ambientali incentrate su norme e standard.
c) creazione di mercati artificiali su cui poter scambiare diritti di emissione, ne esistono di 3 tipi:
A. mercato dei diritti di emissione negoziabili = capacità di smaltimento di un ambiente in un periodo senza subire danni: risorsa per cui viene creato un mercato. Si fissa una capacità di carico da cui si desume il numero massimo di emissioni, suddivisi in titoli divisi fra aria, acqua e suolo. Mercato dei titoli acquistati dal pubblico e dagli ambientalisti.
Obiettivo: chi può depurare a costi bassi deve vendere titoli a chi non può farlo.
Limiti: sono necessari molti controlli, è difficile stabilire la capacità di carico, è il più elegante metodo di correzione davanti al fallimento di un mercato.
B. borse per materie prime secondarie = i rifiuti sono materiali potenzialmente utili per cui si crea un mercato con contributi ai ricuperatori, modifica dei prezzi delle materie prime e di quelle di recupero.
C. assicurazioni di responsabilità = per prevenire i danni e minimizzarne la portata; principio della responsabilità degli inquinatori per danni ambientali causati. Si abbassa il premio assicurativo adottando maggiori sicurezze.
Responsabilità
colposa: si obbliga la persona che danneggia a dare un indennizzo alla vittima solo se non ha esplicato il normale livello di diligenza per evitare il danno;
oggettiva: senza colpa; indennizzo anche se il livello di diligenza è stato rispettato.
VOLONTARI = fine anni '80, prevenzione del danno ambientale con riferimento nel V Programma d'Azione Ambientale dell'UE:
crescente integrazione fra politica ambientale e altre politiche;
passaggio da politiche per l'ambiente a politiche integrate e centrate sull'intero ciclo produttivo;
aumento della responsabilizzazione dei produttori e dei consumatori;
regolamentazione della gestione ambientale delle imprese.
L'industria diventa parte attiva del processo di ecoristrutturazione dell'economia, carattere volontario dell'adesione, impostazione basata su concorrenza e pressioni dell'opinione pubblica per stimolare il ruolo autonomo dell'impresa.
Bilanci ecologici = principi del metabolismo industriale, insieme integrato di processi fisici che trasformano materie prime, energia e lavoro in prodotti finiti e rifiuti. Anni '60: concetto di ciclo di vita, sviluppo dei primi bilanci di energia e di massa. Anni '70: estensione analisi agli impatti ambientali.
Ecoefficienza = capacità di rendere disponibili a prezzi competitivi beni e servizi che soddisfano i bisogni umani e di qualità della vita, riducendo gli impatti ecologici e l'uso delle risorse.
Ambiente = variabile strategica che necessita di un proprio sistema gestionale.
3 ordini di fattori per bilanci ecologici:
a) crescente consapevolezza dell'interdipendenza dei problemi ambientali;
b) politiche di prodotto = componente importante delle politiche ambientali attraverso strumenti economici, fiscali, normativi;
c) crescente pressione dell'opinione pubblica per avere informazioni ambientali da imprese e autorità pubbliche.
3 campi d'impiego:
a) gestione ambientale d'impresa e design (green design);
b) comunicazione ai consumatori, base per procedure di ecolabelling;
c) politiche ambientali pubbliche = sono strumento di selezione e valutazione delle politiche di pianificazione.
Distinzione fondamentale fra:
ECOBILANCIO = oggetto: analisi dell'intero ciclo di vita di un prodotto, dall'estrazione ai rifiuti.
Life - cycle analysis = processo oggettivo di valutazione dei carichi ambientali connesso ad un prodotto, un processo o un'attività, attraverso identificazione e quantificazione dell'energia dei materiali usati e dei rifiuti, per migliorare la qualità ambientale. Strumento rilevante di politica industriale. Riprogettazione dei prodotti o dell'intero sistema di gestione. Complessità elevata degli strumenti.
Ecolabel = ambito d'applicazione, strumento di mercato volto ad incentivare la fabbricazione di prodotti meno nocivi per l'ambiente, orientandovi la scelta dei consumatori, averlo o no è un fattore di competizione.
BILANCIO AMBIENTALE = concerne un singolo stabilimento contabilizzazione entrate e uscite di materie prime rispettando le norme ambientali. sottoinsieme del life - cycle analysis.
Entrano materie prime, energia. Escono prodotti, rifiuti, emissioni, scarichi.
Ecoaudit = certificazione volontaria delle imprese della propria conformità alle normative ambientali. Check up ambientale preliminare fatto dalle imprese. Problematico e oneroso per le piccole imprese; si ha un migliore rapporto con l'ente pubblico.
ACCORDI VOLONTARI = contratti fra una compagnia, un gruppo o un settore industriale, con l'autorità pubblica. Le imprese si impegnano a raggiungere in tempo predefinito obiettivi ambientali qualitativi e l'Amministrazione si astiene dalla regolamentazione. Europa e Nord America.
Vantaggi:
maggior efficienza allocativa per minimizzazione costi totali dell'impresa;
maggior flessibilità;
pianificazione facilitata;
cooperazione con autorità pubblica.
Svantaggi:
inesistenza sanzioni;
collusione fra privato e pubblico;
effetti distorsivi della concorrenza.
POLITICHE TERRITORIALI tutela delle risorse naturali, territoriali e storico-artistiche; si pone al centro dell'azione il territorio. Gli interventi a valle non sono sempre possibili o sono molto costosi e modificanti la risorsa.
Interventi = carattere di forte irreversibilità.
3 modalità generali:
AREE PROTETTE = protezione delle aree territoriali e degli ecosistemi specifici a diverso grado di naturalità.
Cause:
tutela vera e propria;
studio dei processi evolutivi degli ecosistemi e specie animali e vegetali;
forme di compatibilità fra tutela ambiente e usi antropici;
finalità didattiche e formative per l'educazione ambientale.
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE = area vasta, paesistica, urbanistica, bacini idrografici. Nel '900 esistevano 2 logiche: uso del suolo e conservazione degli elementi specifici dell'ambiente naturale e storico.
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE = stima degli effetti complessivi di un progetto d'intervento a forte rilevanza territoriale o ambientale.
Territorializzazione delle politiche ambientali contenimento delle pressioni sull'ambiente con interventi per la minimizzazione degli impatti, esplicita azione preventiva.
POLITICA AMBIENTALE ITALIANA 3 fasi:
a) Anni '60-'70 = la questione ambientale è importante per il pubblico, interventi occasionali;
b) Anni '70-86 = c'è grande produzione normativa, nascono 2 problemi:
energetico, nucleare
sicurezza degli impianti industriali
c) Ministero dell'Ambiente
1970 = Commissione Speciale del Senato per i primi provvedimenti
1974 = Primo ministero dell'Ambiente, senza portafoglio, breve durata
1983 = Ministero per l'Ecologia, scarsa autonomia e poche iniziative
1986 = Ministero dell'Ambiente vero e proprio
Sistema di pianificazione finanziaria con 2 programmi:
'88-'91 = impostazione settoriale, ripartizione delle risorse
'93- '96 = struttura più articolata interviene su:
aree programmate d'intervento
settori d'intervento
azioni regionali e nazionali
livello di programmazione regionale e nazionale
rete di procedure per attuazione, verifica, controllo.
CAP 5 - GLI INDICATORI AMBIENTALI
INFORMAZIONE AMBIENTALE la prima politica per lo sviluppo sostenibile è quella di definire gli indicatori delle trasformazioni in corso nell'ambiente naturale, antropico, costruito; misura efficace del progresso verso lo sviluppo sostenibile.
PIL = indicatore di benessere con omissioni di carattere sociale e ambientale.
Spese difensive = per protezione ambientale e disinquinamento, uscite monetarie sostenute per riparare agli effetti negativi della produzione e del consumo nei confronti dell'ambiente e della salute; incrementano il PIL.
PIL VERDE = PIL - (spese difensive + costi per i danni ambientali + perdita del patrimonio naturale).
RACCOLTA INFORMAZIONI dal '70, tentativi in 2 direzioni:
raccolta delle informazioni quantitative sull'ambiente, confluenti in specifici rapporti di stato;
stima e applicazione sperimentale di metodologie e modelli d'integrazione nei conti economici nazionali; obiettivi di breve, medio e lungo termine.
EUROSTAT = sede a Copenaghen, periodiche statistiche sull'ambiente con indicatori di base, statistiche su risorse naturali, conservazione e tutela del patrimonio ambientale.
ITALIA = il Ministero dell'Ambiente cura le relazioni sullo stato;
Istat: 3ª edizione "Statistiche ambientali".
Reporting ambientale = composto dall'analisi dei problemi ambientali, dal monitoraggio delle politiche ambientali e responsabilizzazione dei soggetti.
3 parti principali:
contabilità ambientale = quantità e qualità risorse;
ecobilancio flussi = input/output cicli ecologici;
valutazione efficienza ed efficacia politiche ambientali.
![]() Strumento fondamentale di conoscenza da parte
dell'uomo della natura e dei suoi mutamenti.
Strumento fondamentale di conoscenza da parte
dell'uomo della natura e dei suoi mutamenti.
Entità I usata al posto di un'altra, A, nell'ambito di qualche determinata operazione quando A non è misurabile in modo agevole.
Modello empirico della realtà, legame fra osservazione, dato statistico grezzo, insieme degli enunciati teorici.
Per essere rappresentativi devono rispettare l'accessibilità e la comunicabilità.
Tipologie di indicatori in base al rapporto intercorrente fra I e A:
|
Per appartenenza |
L'indicatore I è un segno caratteristico di A |
La concentrazione di un dato inquinante nell'aria è indicatore di inquinamento atmosferico |
|
In quanto effetto |
I è prodotto di A |
Moria di pesci è indicatore di inquinamento idrico (accettabilità per riscontro empirico) |
|
In quanto causa |
I produce A |
Scarico nocivo non depurato a monte di un corso d'acqua fa presumere un inquinamento idrico a valle (accettabilità per riscontro empirico) |
|
In quanto sintomo |
Esiste una causa comune per I e A |
Inquinamento organico di un fiume fa sconsigliare di farvi il bagno perché è probabile che esista un inquinamento microbiologico prodotto dalla stessa fonte |
|
Per co-occorrenza statistica |
La presenza di I si accompagna a quella di A |
Se l'incremento del grado di scolarità di una popolazione si accompagna all'incremento del livello di reddito medio pro-capite, il livello di istruzione può essere assunto come indicatore del livello di reddito medio pro-capite di una data popolazione |
METODOLOGIE DI INDICAZIONE:
ricerca dell'indicatore perfetto che presenta corrispondenza biunivoca con l'entità di riferimento;
definizione gamma di indicatori che non hanno corrispondenza biunivoca con l'entità di riferimento; problema = combinazione dei valori assunti dai singoli indicatori con algoritmi diversi.
TIPOLOGIE GENERALI DI INDICATORI:
elementari = livello di disaggregazione elementare della realtà studiata;
aggregati = livello di disaggregazione maggiore di quello elementare;
di stato = condizioni dell'ambiente;
biologici = effetto delle condizioni ambientali sulla popolazione;
di causa = fenomeni capaci di deteriorare o proteggere l'ambiente;
di effetto = azione dell'ambiente modificato sull'agente modificante;
diretti = attributi intrinseci del fenomeno esaminato;
indiretti = aspetti collegati al fenomeno per via diretta.
TIPOLOGIE DI INDICATORI CON OBIETTIVO DI INDAGINE (Malcevschi):
indicatori di stato = descrivono lo stato dell'ambiente e la sua evoluzione;
" di trasformazione = mutamenti in atto;
" di valore = quantificazione dei valori;
" diagnostici = alterazioni rispetto al funzionamento fisiologico;
" gestionali = definizione di standard di riferimento;
" di successo = stima dell'avvicinamento agli obiettivi.
FUNZIONI DEGLI INDICATORI:
funzione di pianificazione = indicatori usati per aiutare i decisori sulla situazione attuale, la sua evoluzione, la sua efficacia e la sua efficienza;
" di comunicazione = indicatori per informare l'opinione pubblica, sensibilizzandola rispetto ai problemi da affrontare.
MODELLO OCSE livello internazionale, nazionale e locale.
Struttura pressione - stato - risposta che permette di cogliere fondamentali relazioni fra sistema ambientale e sistema antropico con 3 domande:
a) cosa sta avvenendo allo stato delle risorse naturali e dell'ambiente nel suo complesso?
b) perché sta avvenendo?
c) che cosa si sta facendo per farvi fronte?
INDICATORI DI PRESSIONE = descrivono le pressioni esercitate dalle attività umane sull'ambiente e sulla qualità e quantità delle risorse naturali. Vengono rappresentati i fattori di pressione causa dei problemi ambientali. Efficacia per le politiche ambientali. Funzione descrittiva e riscontri diretti per raggiungimento obiettivi. Usati in analisi prospettiche per valutare l'impatto ambientale di diversi scenari socio-economici o di proposte di politiche ambientali.
INDICATORI DI STATO = descrivono le trasformazioni qualitative e quantitative indotte nell'ambiente dai fattori di pressione. Si confondono con gli indicatori di pressione.
INDICATORI DI RISPOSTA = descrivono gli sforzi della società o delle istituzioni per rispondere ai problemi ambientali. Azioni individuali e collettive.
Sulla base di questo modello si hanno una pluralità di indicatori considerati singolarmente o a più livelli di aggregazione che devono essere contestualizzati nelle fasi di costruzione e di interpretazione.
LIMITI problemi operativi legati alla disponibilità di dati;
disaggregazione dei dati;
qualità dei dati;
comparabilità dei dati;
credibilità dei dati;
incapacità di sfruttare i dati ricavandone informazioni.
PROBLEMI metodologici: sviluppo degli indicatori
selezione delle variabili
istituzionali: definizione degli organismi
gestione dei dati
politici: anticipazione dei problemi
informazione riguardo il processo di elaborazione.
CAP 6 - MECCANISMI DELL'INTEGRAZIONE AMBIENTALE
Rapporto fra politiche ambientali e altre politiche
Offerta di maggiori informazioni ambientali alle amministrazioni non ambientali:
sottosegretari "verdi" nei Ministeri che agiscono come risorsa - custode - coscienza ambientale;
pianificazione ambientale strategica;
schede di valutazione ambientale delle proposte di legge;
valutazioni ambientali annuali di ogni settore governativo.
Mobilitazione dell'opinione pubblica:
rapporti sullo stato dell'ambiente;
pubblicazioni di rapporti ambientali di altri Ministeri;
controllo parlamentare.
Apertura esplicita delle nuove politiche all'influenza ambientale:
piani o strategie nazionali per lo sviluppo durevole;
comitati interministeriali;
comitati a livello governativo;
comitati a livello di funzionari;
analisi e commento del Ministero dell'Ambiente ad ogni politica con implicazioni ecologiche;
comitati consultivi con altri interessi.
Maggiore influenza e diritto di veto del Ministero dell'Ambiente:
codice di gestione ambientale da applicare nei Ministeri non ambientali;
vaglio delle valutazioni strategiche ambientali;
fissazione di limiti vincolanti di sostenibilità (paragonabili a "tetti" per la spesa pubblica).
La valutazione di impatto ambientale serve per valutare anticipatamente l'impatto della costruzione di grandi impianti, considerando tutte le implicazioni ambientali in tutte le fasi.
Ci sono 2 modi di condurre questa valutazione:
tecnico = soluzione ecologica con inserimento dei dati nel computer, valutazione tecnologica, ingenua rispetto al processo politico;
meno ingenuo = per chiarire certi problemi anche se la risposta è di tipo politico.
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025