|
|
| |
Per politica fiscale intendiamo la capacità del governo di utilizzare i flussi di spesa ed il gettito fiscale per influenzare il livello del reddito nazionale[1].
Per quanto riguarda i flussi di spesa, si deve distinguere tra la spesa pubblica per beni e servizi ed i pagamenti per trasferimenti pubblici. La prima è destinata principalmente all'acquisto di beni di consumo e di beni di investimento, nonché al pagamento di stipendi e salari dei dipendenti pubblici, ed è parte integrante della domanda aggregata. I trasferimenti sono rappresentati da pagamenti alle famiglie ed alle imprese senza contropartita: pensioni sociali, sussidi di disoccupazione, contributi, sussidi ed incentivi a fondo perduto; essi influenzano il reddito disponibile e quindi solo indirettamente la domanda aggregata.
Per quanto riguarda il gettito fiscale, esso può derivare da un complesso di imposte e tasse; le principali sono le imposte dirette, che famiglie ed i 555j93f mprese pagano in base al reddito, e le imposte indirette, che famiglie ed i 555j93f mprese pagano in base ai propri acquisti.
In questo capitolo analizziamo il ruolo e l'efficacia degli interventi da parte dei responsabili di politica economica volti ad influenzare il livello del reddito nazionale. La presentazione rifletterà prevalentemente l'analisi degli economisti keynesiani. Secondo questa impostazione, il sistema economico può trovarsi in una condizione in cui il livello di reddito di equilibrio è inferiore a quello di piena occupazione; in tal caso, il policy maker può riportare il sistema economico alla piena occupazione innalzando il livello della domanda aggregata attraverso interventi di politica fiscale.
Pertanto, con "politica fiscale" intendiamo il complesso degli interventi del responsabile di politica economica (il Ministro dell'Economia) che riguardano la spesa pubblica e le imposte, realizzati al fine di influenzare il livello della domanda aggregata. Una politica fiscale espansiva è tesa ad innalzare il livello di equilibrio del reddito, mentre una politica fiscale restrittiva è normalmente tesa a contenere un eccessivo disavanzo del bilancio dello Stato od a contenere l'inflazione provocata da un eccesso di domanda aggregata. La teoria keynesiana sostiene che gli effetti macroeconomici della politica fiscale dipendono crucialmente sia dal modo in cui essa viene condotta (variazione della spesa o variazione delle imposte), sia dal modo in cui il fabbisogno pubblico (eccesso della spesa sulle entrate fiscali) viene finanziato. La teoria neoclassica-monetarista, invece,
Nel prossimo paragrafo considereremo, all'interno di un semplice modello keynesiano reddito-spesa con diverse forme di imposizione fiscale, gli effetti di una politica fiscale espansiva, nonché il caso particolare di un aumento della spesa pubblica finanziata attraverso un corrispondente aumento delle imposte.
Nel terzo paragrafo analizzeremo gli effetti dei diversi strumenti di politica fiscale sul saldo del bilancio dello Stato. Chiaramente, gli interventi di politica fiscale modificano il saldo del bilancio pubblico, definito come differenza tra le entrate fiscali e le uscite per trasferimenti e spesa pubblica. Il bilancio pubblico è in deficit quando le uscite complessive superano le entrate; viceversa, esso risulta in surplus. Quando i due flussi si eguagliano, il bilancio pubblico è in pareggio. In caso di politica fiscale espansiva il saldo del bilancio pubblico peggiora, per l'aumento dei flussi di spesa o per la riduzione dei flussi di entrata, ma l'entità del peggioramento dipende dal tipo di intervento effettuato.
Nel paragrafo successivo, infine, distingueremo, considereremo gli effetti della politica fiscale all'interno del modello IS-LM, distinguendo gli effetti di una politica fiscale pura, in cui il finanziamento avviene attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico, da quelli di una politica fiscale in cui il finanziamento avviene (almeno in parte) attraverso un'emissione di base monetaria. Il primo caso consente di separare gli effetti della politica fiscale da quelli della politica monetaria, anche se vedremo che, in generale, interventi di politica fiscale possono avere implicazioni sull'offerta di moneta.
- La politica fiscale nel modello keynesiano reddito-spesa
2.1 -Il modello con imposizione autonoma
In un modello che analizza soltanto le condizioni di equilibrio sul mercato dei beni e servizi, le politiche pubbliche di spesa e di imposizione fiscale influenzano il reddito nazionale di equilibrio in due modi: in primo luogo, la spesa pubblica è parte della domanda autonoma, in secondo luogo, nel calcolo del reddito disponibile, le imposte devono essere sottratte, mentre i pagamenti per i trasferimenti pubblici devono essere aggiunti.
Richiamiamo il modello reddito-spesa, nel caso semplificato di assenza di trasferimenti dal settore pubblico alle famiglie ed alle imprese e di imposte autonome[2]:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
L'equazione [2.1] definisce
l'equilibrio sul mercato dei beni. I consumi sono funzione del reddito
disponibile in base alla propensione marginale al consumo ![]() ; la tassazione, la spesa pubblica per beni e servizi e gli
investimenti sono esogeni. Sostituendo la [2.4] nella [2.3] ed il risultato
nella [2.2] si ottiene:
; la tassazione, la spesa pubblica per beni e servizi e gli
investimenti sono esogeni. Sostituendo la [2.4] nella [2.3] ed il risultato
nella [2.2] si ottiene:
![]()
che, sostituita nella condizione di equilibrio sul mercato dei beni insieme alla [2.5] e [2.6], determina il livello di equilibrio del reddito:
![]()
Una politica fiscale espansiva condotta attraverso un aumento della spesa pubblica finanziata in deficit[3] conduce ad un aumento del reddito misurato in base al moltiplicatore applicato alla variazione della spesa stessa:
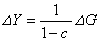
Il moltiplicatore, in
sostanza, misura l'effetto sul prodotto di equilibrio di una variazione della
spesa pubblica: ![]() ; in questo senso si parla di moltiplicatore della spesa pubblica.
; in questo senso si parla di moltiplicatore della spesa pubblica.
Una politica fiscale
espansiva condotta attraverso una riduzione dell'imposizione autonoma (![]() ) conduce ad un aumento del reddito misurato in base al
moltiplicatore applicato alla variazione dell'imposizione stessa:
) conduce ad un aumento del reddito misurato in base al
moltiplicatore applicato alla variazione dell'imposizione stessa:
![]()
In questo caso il moltiplicatore delle imposte autonome, ![]() , misura l'effetto sul prodotto di equilibrio di una
variazione della tassazione autonoma.
, misura l'effetto sul prodotto di equilibrio di una
variazione della tassazione autonoma.
Il moltiplicatore
delle imposte risulta inferiore, in valore assoluto, al moltiplicatore della
spesa pubblica, come appare evidente confrontando i due moltiplicatori delle
equazioni [2.8] e [2.9], in quanto ![]() . In termini economici, la variazione della spesa pubblica
agisce direttamente sulla domanda aggregata e quindi ha un effetto
moltiplicatore analogo a quello di una variazione degli investimenti, mentre la
variazione dell'imposizione agisce indirettamente sulla domanda aggregata,
attraverso la variazione del reddito disponibile e quindi dei consumi, che
fanno variare la domanda aggregata in proporzione alla propensione marginale al
consumo, c.
. In termini economici, la variazione della spesa pubblica
agisce direttamente sulla domanda aggregata e quindi ha un effetto
moltiplicatore analogo a quello di una variazione degli investimenti, mentre la
variazione dell'imposizione agisce indirettamente sulla domanda aggregata,
attraverso la variazione del reddito disponibile e quindi dei consumi, che
fanno variare la domanda aggregata in proporzione alla propensione marginale al
consumo, c.
2.2 - Il modello con imposizione legata al reddito
Consideriamo ora il caso più realistico in cui la tassazione è in parte
autonoma ed in parte dipendente dal reddito, con una imposizione di tipo
proporzionale, in base ad un'aliquota marginale (uguale a quella media) pari a ![]() :
:
![]()
Sostituendo questa espressione nella [2.3] ed il risultato nella [2.2], si ottiene la seguente funzione del consumo:
![]()
che concorre a determinare il livello di equilibrio del reddito:
![]()
Conducendo un esercizio di statica comparata analogo a quello svolto nel caso di tassazione totalmente autonoma, possiamo misurare gli effetti di una politica fiscale espansiva condotta attraverso un aumento della spesa pubblica finanziata in deficit:
![]()
oppure attraverso una riduzione dell'imposizione
autonoma (![]() ):
):
![]()
Anche con la tassazione dipendente dal reddito il moltiplicatore delle imposte risulta inferiore, in valore assoluto, al moltiplicatore della spesa pubblica, come appare evidente confrontando i due moltiplicatori delle equazioni [2.13] e [2.14]. Il ragionamento economico è analogo a quello svolto in precedenza.
Nel caso in
esame, una politica fiscale espansiva può essere realizzata anche mediante una
riduzione della pressione tributaria attuata attraverso una diminuzione
dell'aliquota fiscale da ![]() a
a ![]() , con
, con ![]() . Poiché in tal modo aumenta la propensione marginale "netta"
al consumo rispetto al reddito nazionale,
. Poiché in tal modo aumenta la propensione marginale "netta"
al consumo rispetto al reddito nazionale, ![]() , il valore del moltiplicatore risulta aumentato, a parità
delle componenti autonome della domanda aggregata, per cui il reddito di
equilibrio risulta maggiore. L'effetto di una politica fiscale espansiva
condotta attraverso una diminuzione dell'aliquota
di imposizione fiscale è misurato calcolando la differenza tra i livelli di
reddito di equilibrio relativi alle due diverse aliquote di imposizione:
, il valore del moltiplicatore risulta aumentato, a parità
delle componenti autonome della domanda aggregata, per cui il reddito di
equilibrio risulta maggiore. L'effetto di una politica fiscale espansiva
condotta attraverso una diminuzione dell'aliquota
di imposizione fiscale è misurato calcolando la differenza tra i livelli di
reddito di equilibrio relativi alle due diverse aliquote di imposizione: ![]() . Ponendo
. Ponendo ![]() , si ha:
, si ha:
![]()
Graficamente,
nella figura 1.1, il reddito di
equilibrio è determinato dal punto di intersezione della retta crescente della
domanda aggregata ![]() con la retta a 45° che
soddisfa la condizione di equilibrio
con la retta a 45° che
soddisfa la condizione di equilibrio ![]() . Si noti che il coefficiente angolare della retta è la
propensione marginale al consumo rispetto al reddito nazionale,
. Si noti che il coefficiente angolare della retta è la
propensione marginale al consumo rispetto al reddito nazionale, ![]() , che tiene conto della pressione tributaria sul reddito.
, che tiene conto della pressione tributaria sul reddito.
Per riepilogare,
dato un reddito di equilibrio iniziale pari a ![]() , un maggiore reddito di equilibrio,
, un maggiore reddito di equilibrio, ![]() , può essere raggiunto[5]:
, può essere raggiunto[5]:
attraverso un aumento della spesa pubblica in beni e servizi, che fa traslare proporzionalmente e parallelamente verso l'alto la retta della domanda aggregata, aumentando il valore dell'intercetta sull'asse delle ordinate:
![]() dove
dove ![]()
attraverso una diminuzione della tassazione autonoma, che fa traslare parallelamente verso l'alto la retta della domanda aggregata, aumentando il valore dell'intercetta sull'asse delle ordinate:
![]()

Y
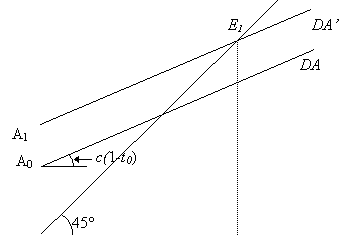
figura 2.1
attraverso una diminuzione dell'aliquota di imposizione fiscale, che fa aumentare la pendenza della retta della domanda aggregata, facendola ruotare verso l'alto, come rappresentato nella figura 2.2:
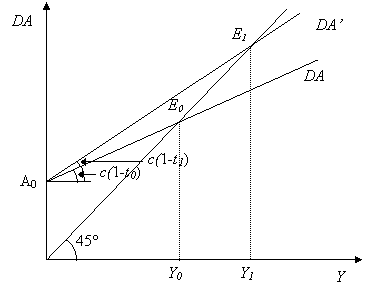
figura 2.2
In conclusione, nel modello reddito-spesa una politica fiscale espansiva ha un effetto positivo sul reddito di equilibrio, indipendentemente dallo strumento che viene utilizzato (aumento della spesa pubblica, diminuzione della tassazione autonoma, riduzione della pressione tributaria). Una politica fiscale espansiva, infatti, accresce la domanda aggregata direttamente, attraverso l'aumento della spesa pubblica per beni e servizi, o indirettamente, mediante la diminuzione della tassazione autonoma o la riduzione della pressione tributaria che fanno aumentare il reddito disponibile e pertanto i consumi. In ogni caso si determina un aumento del livello del reddito di equilibrio.
2.3 - Il prelievo fiscale come stabilizzatore automatico
Uno stabilizzatore automatico è un meccanismo che ha la proprietà di favorire automaticamente la stabilità economica, cioè di operare in funzione anti-ciclica, nel senso di ridurre la dimensione delle fluttuazioni del reddito. In presenza di una diminuzione di una componente autonoma della domanda aggregata, il meccanismo attraverso cui opera lo stabilizzatore automatico mette in moto un aumento della spesa che compensa in parte l'effetto negativo di quella diminuzione e, viceversa, nel caso di un aumento di una componente autonoma della domanda, automaticamente mette in moto una diminuzione della spesa. In sostanza, lo stabilizzatore automatico tende a ridurre l'entità delle fluttuazioni della domanda aggregata e del reddito, senza che sia necessario un intervento ad hoc dei responsabili di politica economica[i].
Quando il prelievo fiscale è una funzione diretta del livello del reddito, invece di essere esclusivamente autonomo, esso svolge il ruolo di stabilizzatore automatico[ii], nel senso che concorre a ridurre la variabilità del reddito nazionale conseguente alla variabilità delle componenti autonome della domanda aggregata. Consideriamo il caso di una riduzione degli investimenti. La diminuzione della domanda aggregata riduce il reddito delle famiglie ed il processo recessivo si amplifica attraverso il meccanismo del moltiplicatore[iii]. Il prelievo fiscale frena questo processo in quanto con il prelievo dipendente dal reddito, il valore del moltiplicatore risulta, come abbiamo già visto, minore. L'entità complessiva del prelievo fiscale si riduce insieme al reddito nazionale, compensando in parte la caduta del reddito disponibile delle famiglie. In sostanza, il ruolo di stabilizzatore automatico del sistema fiscale agisce per il tramite del reddito disponibile: mentre una variazione di una qualunque componente della spesa autonoma fa variare nella stessa direzione il reddito disponibile, il prelievo fiscale fa variare il reddito disponibile nella direzione opposta, sia pure in misura minore.
Va rilevato che il modello che abbiamo analizzato ipotizza un'aliquota fiscale proporzionale al reddito; come abbiamo detto, il prelievo fiscale legato al reddito opera come uno stabilizzatore automatico. Tuttavia, il ruolo del prelievo fiscale come stabilizzatore automatico è potenziato in caso di un sistema fiscale basato su di una imposta progressiva sul reddito[6], caratterizzata dal fatto che l'aliquota applicata varia con le variazioni del reddito, ed in particolare aumenta quando aumenta il reddito e diminuisce quando diminuisce il reddito.
Il funzionamento dell'imposta progressiva sul reddito come stabilizzatore automatico del sistema economico discende dalle caratteristiche di tale tipo di imposta. Infatti, in caso di un aumento di una componente autonoma della domanda che fa aumentare il reddito, agli incrementi di reddito viene applicata un'aliquota d'imposta più alta, che determina un aumento del gettito tributario percentualmente maggiore dell'incremento di reddito e rappresenta pertanto un drenaggio di potere d'acquisto dalle famiglie ed un freno alla crescita della spesa complessiva. Questo meccanismo opera ovviamente in senso contrario in caso di diminuzione di una componente autonoma della domanda e del reddito.
L'efficacia anticongiunturale del prelievo fiscale dipende anche dalla tempestività della sua entrata in funzione: se l'imposta viene riscossa per ritenuta alla fonte (come nel sistema pay-as-you-earn, cioè del pagamento al momento del guadagno) l'efficacia è sicuramente maggiore rispetto al caso in cui la riscossione avviene periodicamente, con scadenza semestrale od annuale, oppure è soggetta ad accertamento. In riferimento a quest'ultimo caso, il prelievo fiscale può anche avere effetti destabilizzanti sul reddito, quando si dovessero pagare le imposte, calcolate sul reddito elevato di una fase di espansione, in un momento successivo in cui il sistema economico sta invece attraversando una fase di recessione.
La politica fiscale ed il saldo del bilancio dello Stato
In base
all'ipotesi semplificatrice di assenza di trasferimenti alle famiglie ed alle
imprese, il saldo del bilancio dello Stato (o bilancio pubblico) è dato dalla
differenza tra le spese pubbliche e le entrate pubbliche. Quando le uscite
superano le entrate, il saldo è negativo e si registra un disavanzo, o deficit di bilancio indicato con la
lettera ![]() :
:
![]()
Quando le entrate
superano le uscite, il saldo è positivo, ed in tal caso si registra un avanzo,
o surplus di bilancio e quindi si ha ![]() ; quando entrate ed uscite si equivalgono, il saldo è nullo
ed il bilancio pubblico è in pareggio, cioè
; quando entrate ed uscite si equivalgono, il saldo è nullo
ed il bilancio pubblico è in pareggio, cioè ![]() .
.
In base a questa impostazione, che definisce il deficit come differenza tra uscite ed entrate, qualora le uscite
del bilancio dello Stato superino le entrate si determina un valore positivo
del deficit; esso misura il fabbisogno finanziario del settore pubblico.
Il fabbisogno finanziario del settore pubblico, o saldo netto da finanziare, è un concetto analogo a quello di
disavanzo di bilancio, ma se ne differenzia per il fatto che in esso non sono
comprese le vendite di attività finanziarie da parte del settore pubblico. Il
termine impiegato si giustifica con il fatto che generalmente si ha ![]() e la differenza
rappresenta proprio l'ammontare delle uscite pubbliche che necessitano di un
finanziamento, in quanto non coperte da entrate fiscali. Tale finanziamento,
come studieremo meglio in seguito, può avvenire tramite indebitamento sui
mercati, cioè emissione di titoli del debito pubblico, oppure tramite emissione
di base monetaria da parte della Banca Centrale. Per il momento, tuttavia,
nell'analisi trascuriamo i problemi relativi al finanziamento del disavanzo
pubblico.
e la differenza
rappresenta proprio l'ammontare delle uscite pubbliche che necessitano di un
finanziamento, in quanto non coperte da entrate fiscali. Tale finanziamento,
come studieremo meglio in seguito, può avvenire tramite indebitamento sui
mercati, cioè emissione di titoli del debito pubblico, oppure tramite emissione
di base monetaria da parte della Banca Centrale. Per il momento, tuttavia,
nell'analisi trascuriamo i problemi relativi al finanziamento del disavanzo
pubblico.
Quando il prelievo fiscale è una funzione crescente del reddito, il saldo del bilancio pubblico è una funzione decrescente del reddito, grazie agli effetti positivi di aumento delle entrate fiscali. La [3.1] è esplicitata come:
![]()
Rappresentiamo
graficamente la [3.2] nella figura 3.1,
con il reddito in ascissa e le funzioni della spesa pubblica e delle entrate
fiscali in ordinata. La funzione della spesa pubblica è una retta orizzontale,
essendo autonoma rispetto al reddito, mentre la funzione delle entrate fiscali
è rappresentata da una retta crescente, con intercetta pari a ![]() e pendenza pari
all'aliquota fiscale marginale t. Per
un livello di reddito pari a
e pendenza pari
all'aliquota fiscale marginale t. Per
un livello di reddito pari a ![]() il bilancio dello
Stato è in pareggio; per livelli di reddito inferiori, ad esempio
il bilancio dello
Stato è in pareggio; per livelli di reddito inferiori, ad esempio ![]() , il saldo di bilancio è in disavanzo, in quanto, dato il
livello di spesa pubblica
, il saldo di bilancio è in disavanzo, in quanto, dato il
livello di spesa pubblica ![]() , le entrate fiscali legate al reddito, sommate a quelle
autonome, sono insufficienti; per livelli di reddito superiori, ad esempio
, le entrate fiscali legate al reddito, sommate a quelle
autonome, sono insufficienti; per livelli di reddito superiori, ad esempio ![]() , sempre dato il livello di spesa pubblica
, sempre dato il livello di spesa pubblica ![]() , il saldo è in avanzo perché lo Stato ha un maggior introito
fiscale legato al reddito.
, il saldo è in avanzo perché lo Stato ha un maggior introito
fiscale legato al reddito.
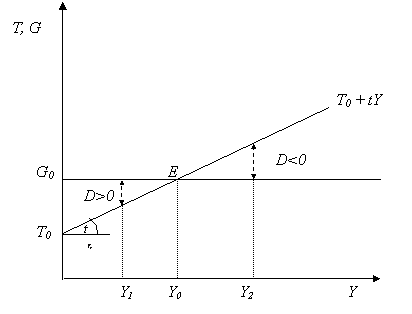
figura 3.1
Esaminiamo ora gli effetti della politica fiscale sul saldo del bilancio dello Stato. Un incremento della spesa pubblica porta ovviamente ad un deterioramento del saldo del bilancio pubblico, ma tale peggioramento è meno che proporzionale rispetto all'aumento della spesa pubblica. Infatti, l'aumento di G ha un effetto d'impatto negativo sul saldo di bilancio pari esattamente alla propria variazione, ma ha anche un effetto indiretto positivo, in quanto, grazie all'aumento di reddito provocato dall'incremento di spesa pubblica, aumenta il gettito tributario e quindi le entrate fiscali. In termini più rigorosi, partendo dall'equazione [3.2], calcoliamo la variazione del saldo di bilancio a seguito di un aumento della spesa pubblica e del conseguente aumento del reddito:
![]()
Sapendo che, quando aumenta la spesa pubblica, l'aumento del reddito è determinato dalla [2.13], si ottiene:
![]()
da cui, ponendo in evidenza ![]() e mettendo a comun
denominatore, si ottiene:
e mettendo a comun
denominatore, si ottiene:
![]()
L'incremento del deficit risulta inferiore all'incremento
della spesa pubblica (![]() ) in quanto la frazione è minore dell'unità perché il
denominatore è maggiore del numeratore.
) in quanto la frazione è minore dell'unità perché il
denominatore è maggiore del numeratore.
Un analogo ragionamento può essere condotto con riferimento ad una variazione in diminuzione della tassazione autonoma:
![]()
Sapendo che, quando diminuisce la tassazione autonoma, l'aumento del reddito è determinato dalla [2.14], si ottiene:
![]()
da cui, ponendo in evidenza ![]() e mettendo a comun
denominatore, si ottiene:
e mettendo a comun
denominatore, si ottiene:
![]()
L'incremento[7]
di deficit risulta minore della
diminuzione della tassazione autonoma (in valore assoluto![]() ) in quanto la frazione è minore dell'unità perché il
denominatore è maggiore del numeratore. Infatti, l'effetto diretto positivo di
un aumento del deficit è mitigato
dall'incremento di entrate fiscali legato all'aumento di reddito provocato
dalla riduzione della tassazione. Tuttavia, mentre l'effetto diretto di aumento
del deficit è lo stesso nel caso di aumento di spesa pubblica e nel caso di
diminuzione di tassazione autonoma, l'effetto indiretto è minore, considerato
che una diminuzione della tassazione autonoma fa aumentare il reddito nazionale
indirettamente, attraverso un aumento del reddito disponibile per i consumi.
) in quanto la frazione è minore dell'unità perché il
denominatore è maggiore del numeratore. Infatti, l'effetto diretto positivo di
un aumento del deficit è mitigato
dall'incremento di entrate fiscali legato all'aumento di reddito provocato
dalla riduzione della tassazione. Tuttavia, mentre l'effetto diretto di aumento
del deficit è lo stesso nel caso di aumento di spesa pubblica e nel caso di
diminuzione di tassazione autonoma, l'effetto indiretto è minore, considerato
che una diminuzione della tassazione autonoma fa aumentare il reddito nazionale
indirettamente, attraverso un aumento del reddito disponibile per i consumi.
Esaminiamo ora l'effetto sul saldo di bilancio pubblico di una diminuzione della pressione tributaria attraverso una diminuzione dell'aliquota fiscale. Tale variazione porta ovviamente ad un deterioramento del saldo del bilancio pubblico, ma tale peggioramento è minore, in valore assoluto, della perdita gettito dovuta alla diminuzione della pressione tributaria. Anche in questo caso, infatti, l'effetto complessivo è il risultato di un effetto di impatto negativo, pari alla perdita di gettito tributario dovuta alla riduzione dell'aliquota di imposizione fiscale, e di un effetto indiretto positivo, pari all'aumento del gettito tributario indotto dall'incremento di reddito[8].
Partiamo
nuovamente dall'equazione [3.2] e calcoliamo la variazione del saldo di
bilancio a seguito di una diminuzione dell'aliquota fiscale da ![]() a
a ![]()
![]()
Poiché, per definizione, ![]() e
e ![]() , per sostituzione nella [3.5] si ottiene:
, per sostituzione nella [3.5] si ottiene:
![]()
Il primo addendo
rappresenta la perdita di gettito tributario dovuta alla riduzione della
pressione tributaria a parità di reddito, in quanto nel nostro esempio, ![]() ; il secondo addendo rappresenta il miglioramento del saldo
dovuto all'incremento di reddito (
; il secondo addendo rappresenta il miglioramento del saldo
dovuto all'incremento di reddito (![]() ) a parità di aliquota ed il terzo addendo rappresenta
l'effetto composto di entrambe le variazioni ed è negativo, ma molto piccolo in
quanto è appunto il prodotto di due variazioni. Poiché esso è sicuramente
inferiore, in valore assoluto, al secondo addendo, il peggioramento del saldo
di bilancio è minore, sempre in valore assoluto, della perdita gettito dovuta
alla diminuzione della pressione tributaria.
) a parità di aliquota ed il terzo addendo rappresenta
l'effetto composto di entrambe le variazioni ed è negativo, ma molto piccolo in
quanto è appunto il prodotto di due variazioni. Poiché esso è sicuramente
inferiore, in valore assoluto, al secondo addendo, il peggioramento del saldo
di bilancio è minore, sempre in valore assoluto, della perdita gettito dovuta
alla diminuzione della pressione tributaria.
3.1 - Il moltiplicatore del bilancio in pareggio
Un ulteriore modo di condurre la politica fiscale consiste nel modificare la composizione del bilancio pubblico, senza alterarne il saldo, variando nella stessa quantità sia la spesa pubblica sia il gettito fiscale. Una tale politica può avere una giustificazione, in quanto, pur mantenendo inalterato il saldo del bilancio dello Stato, essa ha un effetto espansivo sul reddito nazionale e non è neutrale nei confronti del sistema economico.
Tali effetti sono dimostrati dal teorema del bilancio in pareggio (o teorema di Haavelmo, dal nome dell'economista che lo proposto per primo) che afferma che un aumento simultaneo ed identico della spesa pubblica e delle imposte lascia invariato il saldo del bilancio dello Stato, ma fa aumentare il reddito nazionale esattamente nella misura in cui è aumentata la spesa pubblica (e le entrate fiscali). Il risultato vale, ma con segno opposto di contrazione del reddito, anche nel caso di simultanea riduzione della spesa e del prelievo.
Il modo più semplice per dimostrare tale teorema è quello di fare riferimento al modello con imposizione autonoma (paragrafo 2). Ne richiamiamo l'equazione [2.7], che determina il reddito di equilibrio:
![]()
e ridefiniamo l'equazione [3.2] del saldo di
bilancio dello Stato, tenendo conto che ora, per ipotesi, ![]() :
:
![]()
Poiché sia le uscite che le entrate del bilancio pubblico sono esogene, anche il suo saldo è esogeno. Possiamo supporre, per semplicità, che il bilancio dello Stato sia inizialmente in pareggio:
![]()
Consideriamo
ora una politica fiscale che veda di una simultanea ed identica espansione
della spesa pubblica e della tassazione :
![]() . In questo caso, per la [3.8], il saldo del bilancio
pubblico rimane in pareggio. Gli effetti sul reddito nazionale di una tale
manovra possono essere misurati attraverso i moltiplicatori della spesa
pubblica e delle imposte autonome:
. In questo caso, per la [3.8], il saldo del bilancio
pubblico rimane in pareggio. Gli effetti sul reddito nazionale di una tale
manovra possono essere misurati attraverso i moltiplicatori della spesa
pubblica e delle imposte autonome:
[3.9]![]()
Analiticamente, l'effetto positivo sul reddito nazionale discende dal fatto che, in valore assoluto, il moltiplicatore della spesa pubblica è maggiore del moltiplicatore delle imposte autonome. Il significato economico è chiaro: la maggiore spesa pubblica si traduce integralmente in maggiore domanda aggregata e maggior reddito, mentre il maggior prelievo fiscale si traduce solo in parte in minore domanda aggregata, in quanto riduce il reddito disponibile che si ripercuote solo in parte in minori consumi, mentre per la parte restante si traduce in minore risparmio.
Il risultato del teorema del bilancio in pareggio è stato dimostrato - per semplicità di analisi - nel caso di tassazione totalmente autonoma, ma si tratta di un risultato del tutto generale, che non dipende dal modo in cui è attuato il prelievo fiscale. Nel caso di tassazione dipendente dal reddito, tuttavia, la dimostrazione è molto più lunga e laboriosa e per questo motivo non la illustriamo.
- Il saldo di bilancio come indicatore della politica fiscale
Come abbiamo visto, quando la tassazione è legata al reddito, anche il saldo del bilancio pubblico dipende dal livello del reddito; variazioni del reddito indipendenti dalla politica fiscale (per esempio dovute a variazioni esogene degli investimenti) fanno variare il deficit pubblico senza che sia intervenuto alcun mutamento nel livello della spesa pubblica o nella pressione fiscale. Si pone pertanto il problema di come interpretare le variazioni del deficit del bilancio dello Stato, nel senso che non sempre un deficit di bilancio è legato ad una politica fiscale eccessivamente espansiva. E' importante quindi capire la natura del deficit di bilancio pubblico per ricavarne le giuste "ricette" di politica fiscale.
Chiariamo questo
concetto con l'ausilio del grafico. Nella figura
3.2, al reddito ![]() corrisponde il
pareggio del bilancio pubblico, cioè l'equazione [3.2] vale con il segno di
eguaglianza. Supponiamo che
corrisponde il
pareggio del bilancio pubblico, cioè l'equazione [3.2] vale con il segno di
eguaglianza. Supponiamo che ![]() sia anche il valore
che assume il reddito di equilibrio del sistema economico,
determinato dall'equazione [2.7]. Se ora si verifica una diminuzione degli
investimenti che fa diminuire il reddito di equilibrio, ad esempio al livello
sia anche il valore
che assume il reddito di equilibrio del sistema economico,
determinato dall'equazione [2.7]. Se ora si verifica una diminuzione degli
investimenti che fa diminuire il reddito di equilibrio, ad esempio al livello ![]() , il bilancio pubblico presenta un deficit che si realizza del tutto indipendentemente dalle scelte in
materia di politica economica, in quanto la spesa pubblica, l'imposizione
autonoma e l'aliquota fiscale sono rimaste invariate.
, il bilancio pubblico presenta un deficit che si realizza del tutto indipendentemente dalle scelte in
materia di politica economica, in quanto la spesa pubblica, l'imposizione
autonoma e l'aliquota fiscale sono rimaste invariate.
Confrontando le due situazioni, non si può pertanto affermare che nel secondo caso, di deficit di bilancio pubblico, il governo stia attuando una politica fiscale troppo espansiva, mentre nel primo caso la politica fiscale era adeguata. Si tratta invece di un disavanzo congiunturale, legato al basso livello di reddito, disavanzo che tende a ridursi da solo quando l'economia supererà la fase negativa ed il reddito aumenterà nuovamente. In questa situazione, la politica fiscale non dovrebbe modificarsi per cercare di contenere il deficit, perché non farebbe che aggravare la situazione. Infatti, una riduzione della spesa pubblica (o un aumento della pressione fiscale) per riportare il bilancio pubblico in pareggio farebbe diminuire la domanda aggregata, e con essa il reddito nazionale e, di conseguenza, diminuirebbero le entrate fiscali. Oltre a non risolvere i problemi del deficit del bilancio pubblico, una tale politica fiscale sarebbe prociclica, e quindi opererebbe in maniera esattamente contraria a quanto necessario a fini di stabilizzazione delle oscillazioni del reddito.[11]
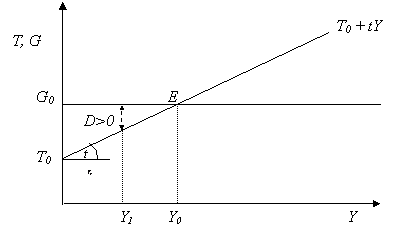
figura 3.2
Se invece il deficit avesse natura strutturale, le indicazioni di politica fiscale sarebbero diverse. Un disavanzo strutturale è quello che il sistema economico presenta quando il suo reddito è al livello potenziale[12] (o di pieno impiego) e non risente quindi della variabilità congiunturale del reddito. Il saldo di bilancio di pieno impiego è misurato in corrispondenza del reddito potenziale: se a tale livello di reddito il bilancio pubblico è in deficit, il disavanzo non si può riassorbire da solo, ma deve essere ridotto grazie ad un opportuno intervento di politica fiscale.
Per il fatto di non dipendere dall'andamento della congiuntura, il saldo di bilancio di pieno impiego è un indicatore del carattere espansivo o restrittivo della politica fiscale: esso è una misura della cosiddetta "posizione di bilancio" (o fiscal stance) del governo.
La politica fiscale nel modello IS-LM di economia chiusa
Partiamo dal semplice modello IS-LM di economia chiusa, richiamandone brevemente le equazioni:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tutte le variabili sono
espresse in termini reali, ad eccezione dell'offerta (data) di moneta ![]() e del livello dei
prezzi
e del livello dei
prezzi ![]() . Nell'impostazione keynesiana, quando vi sono risorse
inutilizzate il livello dei prezzi è assunto costante ed esogenamente
determinato. L'equazione [4.1] definisce l'equilibrio sul mercato dei beni. I
consumi sono funzione del reddito disponibile in base alla propensione
marginale al consumo
. Nell'impostazione keynesiana, quando vi sono risorse
inutilizzate il livello dei prezzi è assunto costante ed esogenamente
determinato. L'equazione [4.1] definisce l'equilibrio sul mercato dei beni. I
consumi sono funzione del reddito disponibile in base alla propensione
marginale al consumo ![]() , la tassazione dipende dal reddito in base all'aliquota
marginale
, la tassazione dipende dal reddito in base all'aliquota
marginale ![]() , la spesa pubblica è esogena, mentre gli investimenti sono
una funzione decrescente del tasso di interesse
, la spesa pubblica è esogena, mentre gli investimenti sono
una funzione decrescente del tasso di interesse ![]() . Sostituendo la [4.4] nella [4.3] ed il risultato nella [3.2]
si ottiene:
. Sostituendo la [4.4] nella [4.3] ed il risultato nella [3.2]
si ottiene:
![]()
che, sostituita nella condizione di equilibrio sul mercato dei beni insieme alla [4.5] e [4.6], ci dà l'espressione analitica della curva IS:
![]()
Ponendo nuovamente ![]() , si può riesprimere la [4.8] come:
, si può riesprimere la [4.8] come:
![]()
L'equazione [4.7] definisce l'equilibrio sul mercato della moneta, dove la domanda di moneta per transazioni è funzione crescente del reddito e quella speculativa è funzione decrescente del tasso di interesse. Essa può essere riespressa come:
![]()
Eguagliando
le due equazioni [4.9] e [4.10], moltiplicando ambo i membri per ![]() e riorganizzando i
termini, si ottiene il livello di reddito che assicura l'equilibrio simultaneo
sul mercato dei beni e su quello della moneta:
e riorganizzando i
termini, si ottiene il livello di reddito che assicura l'equilibrio simultaneo
sul mercato dei beni e su quello della moneta:
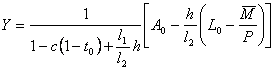
Il livello di equilibrio del reddito dipende sia dalla domanda aggregata di beni, sia dalle condizioni di equilibrio sul mercato della moneta. Infatti la domanda aggregata dipende a sua volta anche dal mercato della moneta dove si determina il tasso di interesse che influenza gli investimenti.
4.1 - La politica fiscale "pura"
Una politica fiscale espansiva condotta attraverso un aumento della spesa pubblica finanziata con titoli collocati sul mercato conduce ad un aumento del reddito misurato in base al moltiplicatore applicato alla variazione della spesa stessa:
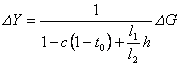
Si noti come il
moltiplicatore risulta inferiore rispetto a quello del corrispondente modello
reddito-spesa (equazione [2.12]), in quanto il denominatore risulta aumentato
del termine ![]() che è positivo. La presenza di tale addendo riflette i legami
tra il mercato dei beni e quello della moneta: la spinta della spesa pubblica
mette in moto il moltiplicatore e fa crescere il reddito, ma la crescita del
reddito fa aumentare la domanda di moneta per transazioni in base al parametro
che è positivo. La presenza di tale addendo riflette i legami
tra il mercato dei beni e quello della moneta: la spinta della spesa pubblica
mette in moto il moltiplicatore e fa crescere il reddito, ma la crescita del
reddito fa aumentare la domanda di moneta per transazioni in base al parametro ![]() . Data l'offerta di moneta, che non è variata, l'eccesso di
domanda di moneta rispetto all'offerta spinge verso l'alto il tasso di
interesse; in effetti, il collocamento dei titoli pubblici sul mercato aumenta
l'offerta dei titoli, ne fa ridurre il prezzo e, per il noto legame inverso tra
prezzo dei titoli e tasso di interesse, porta il tasso di interesse ad
aumentare. Tale aumento riduce la domanda di moneta speculativa in base al
parametro
. Data l'offerta di moneta, che non è variata, l'eccesso di
domanda di moneta rispetto all'offerta spinge verso l'alto il tasso di
interesse; in effetti, il collocamento dei titoli pubblici sul mercato aumenta
l'offerta dei titoli, ne fa ridurre il prezzo e, per il noto legame inverso tra
prezzo dei titoli e tasso di interesse, porta il tasso di interesse ad
aumentare. Tale aumento riduce la domanda di moneta speculativa in base al
parametro ![]() . Infatti la preferenza per la liquidità diminuisce al
crescere del tasso di interesse, e la liquidità resa disponibile sarà tanto
maggiore quanto più elevata è la sensibilità della domanda di moneta rispetto
al tasso di interesse, misurata appunto dal parametro
. Infatti la preferenza per la liquidità diminuisce al
crescere del tasso di interesse, e la liquidità resa disponibile sarà tanto
maggiore quanto più elevata è la sensibilità della domanda di moneta rispetto
al tasso di interesse, misurata appunto dal parametro ![]() : se
: se ![]() è elevato, l'equilibrio
sul mercato della moneta si ottiene con minori incrementi del tasso di
interesse. L'aumento del tasso di interesse scoraggia una parte degli
investimenti privati, resi non più convenienti al nuovo livello del costo del
denaro. La contrazione degli investimenti, a sua volta, è tanto maggiore quanto
più essi risultano sensibili all'aumento del tasso di interesse, cioè tanto più
è elevato il parametro
è elevato, l'equilibrio
sul mercato della moneta si ottiene con minori incrementi del tasso di
interesse. L'aumento del tasso di interesse scoraggia una parte degli
investimenti privati, resi non più convenienti al nuovo livello del costo del
denaro. La contrazione degli investimenti, a sua volta, è tanto maggiore quanto
più essi risultano sensibili all'aumento del tasso di interesse, cioè tanto più
è elevato il parametro ![]() . L'addendo
. L'addendo ![]() misura in sostanza
l'entità della retroazione monetaria,
che sarà maggiore quanto più elevati sono i valori dei parametri
misura in sostanza
l'entità della retroazione monetaria,
che sarà maggiore quanto più elevati sono i valori dei parametri ![]() e
e ![]() e minore
quanto più alto è il valore del parametro
e minore
quanto più alto è il valore del parametro ![]() .
.
Graficamente, il livello di equilibrio del
reddito risulta determinato dall'incontro della IS e della LM. A seguito della politica
fiscale espansiva si verifica una traslazione della curva IS verso destra. La
misura dello spostamento della IS, misurato in ascissa ,
è dato dal moltiplicatore della spesa pubblica ![]() applicato alla
variazione della spesa stessa, ma la misura dell'incremento della domanda
aggregata risulta minore (equazione [4.12]) a causa della retroazione
monetaria.
applicato alla
variazione della spesa stessa, ma la misura dell'incremento della domanda
aggregata risulta minore (equazione [4.12]) a causa della retroazione
monetaria.

figura 4.1.a
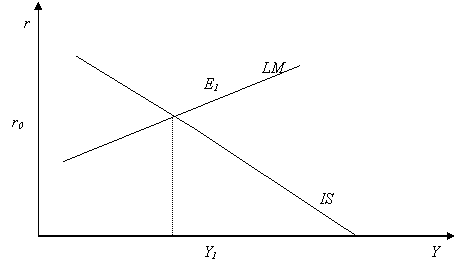
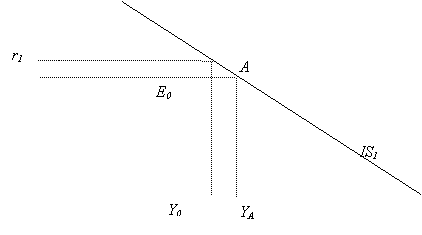
figura 4.1.b
Poiché i parametri che determinano l'entità della retroazione monetaria sono quelli che determinano la pendenza delle curve IS ed LM, si possono confrontare graficamente due diverse situazioni.
Nella figura 4.1 sono riportati due equilibri macroeconomici, con una
stessa IS, ma con due diverse curve LM che differiscono per un diverso valore
della sensibilità della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse, ![]() . Nella figura 4.1.a
la LM riflette un basso valore di
. Nella figura 4.1.a
la LM riflette un basso valore di ![]() , cioè una bassa sensibilità della domanda di moneta al tasso
di interesse, che comporta una elevata pendenza della retta[15],
mentre nella figura 4.1.b è
rappresentata una LM più piatta, con una maggiore sensibilità della domanda di
moneta rispetto al tasso di interesse. Un dato spostamento della IS verso
destra, che rappresenta una politica fiscale espansiva di eguale intensità,
comporta un maggior aumento del reddito di equilibrio nel secondo caso rispetto
al primo. La ragione risiede nel fatto che nel secondo caso basta un minor
aumento del tasso di interesse per riportare in equilibrio il mercato della
moneta (la domanda di moneta speculativa diminuisce molto all'aumento del tasso
di interesse); pertanto gli investimenti privati diminuiscono di meno. La
politica fiscale espansiva conduce ad un minor aumento del tasso di interesse e
provoca un minore spiazzamento degli
investimenti privati, con un effetto espansivo della domanda aggregata
maggiore:
, cioè una bassa sensibilità della domanda di moneta al tasso
di interesse, che comporta una elevata pendenza della retta[15],
mentre nella figura 4.1.b è
rappresentata una LM più piatta, con una maggiore sensibilità della domanda di
moneta rispetto al tasso di interesse. Un dato spostamento della IS verso
destra, che rappresenta una politica fiscale espansiva di eguale intensità,
comporta un maggior aumento del reddito di equilibrio nel secondo caso rispetto
al primo. La ragione risiede nel fatto che nel secondo caso basta un minor
aumento del tasso di interesse per riportare in equilibrio il mercato della
moneta (la domanda di moneta speculativa diminuisce molto all'aumento del tasso
di interesse); pertanto gli investimenti privati diminuiscono di meno. La
politica fiscale espansiva conduce ad un minor aumento del tasso di interesse e
provoca un minore spiazzamento degli
investimenti privati, con un effetto espansivo della domanda aggregata
maggiore: ![]() è maggiore nella figura 4.1.b.
è maggiore nella figura 4.1.b.
Nella figura 4.2 sono invece riportati due equilibri macroeconomici, con la stessa LM, ma con due diverse curve IS che differiscono per un diverso valore della sensibilità degli investimenti privati al tasso di interesse, h.
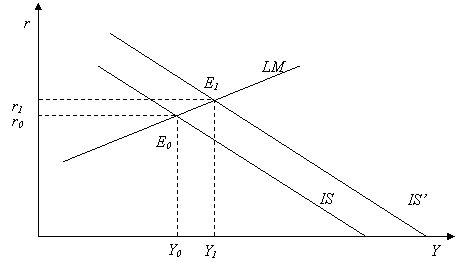
figura 4.2.a
Nella figura 4.2.a la IS riflette un alto
valore di ![]() , che comporta una minore pendenza della retta (ed una minore
intercetta sull'asse delle ordinate), mentre nella figura 4.2.b è rappresentata una IS più rigida, con una minore
sensibilità degli investimenti al tasso di interesse. Un dato spostamento della
IS verso destra, che rappresenta una politica fiscale espansiva di eguale
intensità, comporta un maggior aumento del reddito di equilibrio nel secondo
caso rispetto al primo. In questo ultimo caso, in effetti, l'aumento del tasso
di interesse causato dalla retroazione monetaria ha un minor impatto negativo
sugli investimenti, che sono meno sensibili alle variazioni del tasso di
interesse, e quindi l'effetto
spiazzamento è minore.
, che comporta una minore pendenza della retta (ed una minore
intercetta sull'asse delle ordinate), mentre nella figura 4.2.b è rappresentata una IS più rigida, con una minore
sensibilità degli investimenti al tasso di interesse. Un dato spostamento della
IS verso destra, che rappresenta una politica fiscale espansiva di eguale
intensità, comporta un maggior aumento del reddito di equilibrio nel secondo
caso rispetto al primo. In questo ultimo caso, in effetti, l'aumento del tasso
di interesse causato dalla retroazione monetaria ha un minor impatto negativo
sugli investimenti, che sono meno sensibili alle variazioni del tasso di
interesse, e quindi l'effetto
spiazzamento è minore.
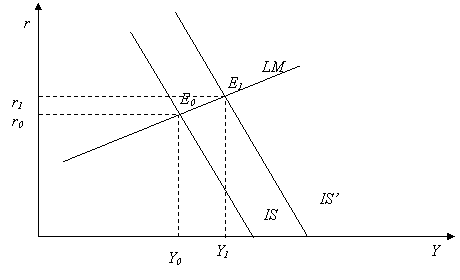
figura 4.2.b
4.2 - La politica fiscale e la monetizzazione del deficit pubblico
Nello studiare gli effetti sul reddito nazionale di una politica fiscale espansiva "pura" è stato ipotizzato che il conseguente deficit di bilancio pubblico fosse finanziato attraverso l'emissione ed il collocamento sul mercato di titoli del debito pubblico. L'indebitamento non è tuttavia l'unico modo di finanziare un deficit di bilancio. In linea di principio, l'espansione fiscale può essere finanziata con moneta emessa dalla banca centrale. In sostanza, la banca centrale acquista i titoli del debito pubblico emessi per finanziare il deficit di bilancio dovuto all'aumento di spesa pubblica. In tal caso, si parla di monetizzazione del deficit pubblico e di politica monetaria accomodante . Quando il deficit viene monetizzato, gli effetti sul livello di equilibrio del reddito nazionale sono ovviamente diversi rispetto a quelli di una politica fiscale "pura", in quanto la crescita del reddito fa aumentare la domanda di moneta per transazioni, ma contemporaneamente si ha un aumento dell'offerta di moneta. Come abbiamo già visto, l'aumento della domanda di moneta per transazioni spinge verso l'aumento del tasso di interesse; l'aumento dell'offerta di moneta, invece, aumentando la liquidità e facendo aumentare la domanda ed il prezzo dei titoli, tende a far ridurre il tasso di interesse. Gli effetti sul tasso di interesse sono quindi opposti e, almeno in parte, si compensano reciprocamente; anche il fenomeno della retroazione monetaria ne viene influenzato e l'effetto espansivo sul reddito dell'iniziale politica fiscale espansiva risulta maggiore.
E
Da
un punto di vista analitico, partiamo dall'equazione [4.11] e rappresentiamo la
monetizzazione del deficit
considerando un aumento di spesa pubblica ed un pari aumento dell'offerta di
moneta; l'aumento del reddito sarà ora misurato in base al moltiplicatore
applicato alla variazione della spesa ed alla variazione dell'offerta di moneta:
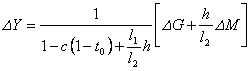
Poiché ![]() , abbiamo:
, abbiamo:
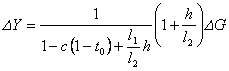
Da un confronto tra la [4.12] e la [4.13], appare chiaramente che l'aumento del reddito nel caso di una politica fiscale "pura" risulta inferiore rispetto al caso della politica fiscale con monetizzazione del deficit. La ragione sta proprio nella diversa variazione del tasso di interesse e, quindi, nel diverso effetto sugli investimenti privati.
Graficamente,
nella figura 4.3 riportiamo gli
effetti combinati di una politica fiscale espansiva, che sposta la curva IS nella posizione IS', e di una politica monetaria accomodante, che sposta la curva LM nella posizione LM'. Poiché il tasso di interesse è rimasto invariato rispetto alla
situazione iniziale ,
gli investimenti delle imprese non risultano modificati e la maggiore domanda
aggregata dovuta all'incremento di spesa pubblica si aggiunge totalmente (senza
alcuno spiazzamento) alle altre componenti della domanda aggregata. La nuova
posizione di equilibrio è rappresentata dal punto ![]() , cui corrisponde un livello di reddito
, cui corrisponde un livello di reddito ![]() maggiore di
maggiore di ![]() , ottenibile con una politica fiscale "pura" (quando si
sposta solo la curva IS).
, ottenibile con una politica fiscale "pura" (quando si
sposta solo la curva IS).
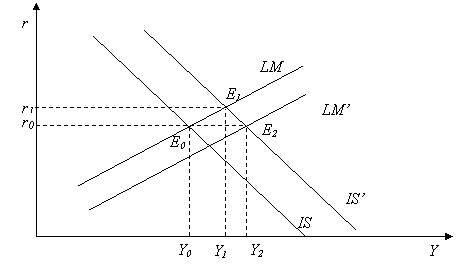
figura 4.3
4.3 - Alcuni casi particolari relativi all'efficacia della politica fiscale
Sulla base dell'analisi fin qui condotta è abbastanza semplice individuare alcune situazioni "estreme" in cui la politica fiscale "pura" risulta totalmente inefficace nell'influenzare il livello di equilibrio del reddito, oppure in cui la stessa politica fiscale risulta pienamente efficace.
Iniziamo da un caso in cui la politica fiscale risulta totalmente inefficace.
Qualora la domanda di moneta sia legata solamente al livello del reddito[20] (domanda di moneta per transazioni) e non sia invece influenzata dal tasso di interesse, la curva LM è una retta verticale con intercetta sull'asse delle ascisse in corrispondenza del livello di reddito che uguaglia la domanda e l'offerta (data) di moneta, in quanto le condizioni dell'equilibrio sul mercato della moneta sono indipendenti rispetto al livello del tasso d'interesse. Partendo da una situazione iniziale di equilibrio, un aumento della spesa pubblica non ha alcun effetto sul reddito di equilibrio, che dipende solo dalla condizione di equilibrio sul mercato della moneta. La politica fiscale risulta quindi del tutto inefficace (figura 4.4) e lo spiazzamento degli investimenti privati è completo: la spesa pubblica si sostituisce, per un pari ammontare, agli investimenti nella domanda aggregata.
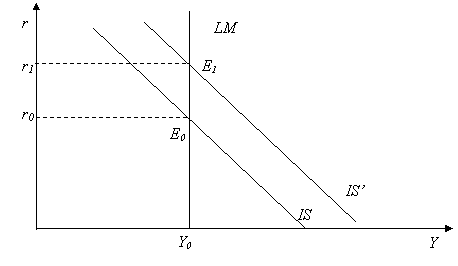
figura 4.4
La politica fiscale produce invece il massimo effetto espansivo sul reddito quando non opera il meccanismo di retroazione monetaria: ciò avviene quando il tasso di interesse non varia al variare della domanda aggregata. E' questo il caso in cui l'elasticità della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse è infinita ad un tasso di interesse sufficientemente basso; come sappiamo, la curva LM è allora una retta orizzontale in corrispondenza di tale tasso di interesse. In sostanza, l'equilibrio sul mercato della moneta non è influenzato dal livello del reddito, perché la domanda di moneta è comunque infinita al dato tasso di interesse (trappola della liquidità). Un aumento della spesa pubblica, che fa traslare la curva IS a destra, non è in grado pertanto di influenzare il tasso di interesse, l'effetto di spiazzamento è nullo e quindi il moltiplicatore della spesa pubblica risulta pari a quello del modello reddito-spesa.[22]
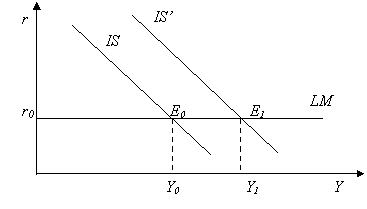
figura 4.5
La politica fiscale produce il massimo effetto espansivo sul reddito anche qualora la sensibilità degli investimenti al tasso di interesse è nulla. Se gli investimenti privati non sono influenzati dal tasso di interesse, l'equilibrio sul mercato dei beni dipende solo dal livello del reddito (come nel modello reddito-spesa). La curva IS è allora una retta verticale in corrispondenza del livello di reddito determinato dalla domanda aggregata. Partendo da una situazione iniziale di equilibrio, un aumento della spesa pubblica trasla la curva IS a destra: l'aumento del reddito di equilibrio sarà pari al moltiplicatore senza retroazione monetaria applicato all'aumento di spesa pubblica. Nonostante l'aumento del tasso di interesse di equilibrio, legato alle condizioni di equilibrio sul mercato della moneta, non si verifica spiazzamento, perché gli investimenti non reagiscono alla variazione del tasso di interesse.
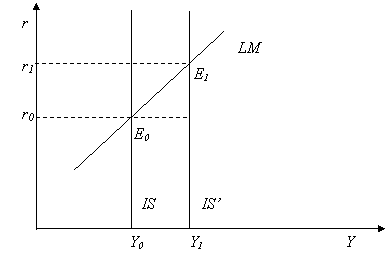
figura 4.6
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025