|
|
| |
ALTRI DOCUMENTI
|
||||||||||

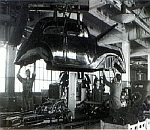
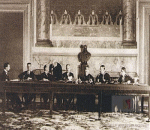
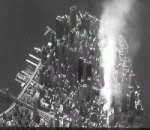

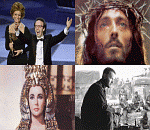

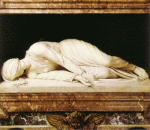
STORIA · Dal latino historia, in greco istoria, propriamente il termine sta a significare
"ricerca, indagine", derivando dalla comune radice latina vid-
di videre. Esposizione ordinata dei fatti umani, quali risultano da
un'indagine critica, volta ad accertare la verità degli stessi insieme alle
loro connessioni reciproche e a riconoscere nello sviluppo dei fatti stessi
unità coerenti (che la sociologia generale, coordinandosi
multidisciplinariamente con le scienze sociali tutte, dovrebbe poter
trasformare in ipotesi e leggi scientifiche, laddove queste unità coerenti si
dimostrassero costanti storico-sociali inevitabili delle azioni umane, oltre le
apparenze e le opinioni storicistiche contingenti come, ad esempio, nel caso
delle identità politiche sostanziali tra elìtes democratiche, pur
appartenenti a diversi contesti e periodi storici, nota RDM).
Definita così la storia, si può con ciò, separandola, accostarla alla cronaca,
che è invece esposizione dei fatti nella loro più semplice successione
cronologica. Il nome storia, inteso come "ricerca", fu adoperato la
prima volta da Erodoto (490/480 circa a.C. - 430/420 circa a.C.), che adoperò in
primis l'indagine sul campo e la presa diretta di usanze e costumi,
attività che gli consentirono di creare un proprio metodo, protoscientifico,
inglobando per la prima volta anche lo studio de 747g66h i documenti nella ricostruzione
storica; tutto ciò gli valse l'appellativo ciceroniano di pater historiae.
I "logografi", che lo precedettero, erano spinti invece dalla mera
curiosità e dall'attrazione del meraviglioso, non già dal rigore della ricerca
storica, mescolando ingenuamente miti, racconti, cerimonie religiose, miracoli,
eventi e favole. Erodoto, distinguendo accuratamente ciò che di cui era
testimone oculare e ciò che gli era stato riferito tramite la forma narrativa
del racconto, vagliava e filtrava alla luce delle proprie riflessioni di uomo
esperto: l'obiettività lo portò a essere considerato quel "padre degli
studi storici" che precedette Tucidide, il più grande degli storici greci.
"Erodoto di greca historia padre", scrisse Francesco Petrarca.
Fin dai primordi dei
discorsi storici il problema non fu di inquadrare le "cose" da
considerare storicamente importanti o rilevanti: la storiografia più antica e,
sopratutto, le scienze sociali, hanno a lungo termine rivelato essere
virtualmente importanti, utili e sommamente interessanti persino quelle,
apparentemente, più minute o marginali tra le vicende umane; si consideri il
filone sociologico relativo alle interviste agli italiani di status non
elevato, emigrati in altre nazioni, quanto ha rappresentato, ai fini
conoscitivi, nel costituire memoria, storica e collettiva insieme, sempre
analizzabile, sui ricordi, le emozioni, le testimonianze, in definitiva, di
milioni di persone e di interi popoli durante epoche di transizione economica,
politica, sociale.
Il problema vero, piuttosto, fu osservare le res gestae umane, i fatti,
e considerare la natura della forma conoscitiva come definita e condizionata in
modo inoppugnabile da quelle della realtà da conoscere, con ciò legando la
giustificabilità delle azioni umane alla possibilità di conoscerle. La storia
operata, cioé le res gestae, da correlare, senza falsificazione
conoscitiva, alla historia rerum gestarum, cioé la storia scritta, era
il primo problema scientifico della storiografia d'ogni tempo.
La 'filosofia' dei fatti storici nasce così con il dilemma di essere oggettiva
e nello stesso tempo non ridursi a mera cronologia o successione di fatti ma,
bensì, essere capace di interpretare i fatti oggettivi, cogliendo insieme
"essere" reale dei fatti e piani generali, voluti o meccanicamente
presenti, che i fatti testimoniano e dal quale sono generati. Poter essere,
quindi, capace di rimanere legata, come disciplina, alla narrazione storica ed insieme
non esserne schiava, individuando nella storia leggi, costanti, variabili,
unicità, essere e divenire non direttamente chiari e sintetizzati dal
susseguirsi degli eventi storici.
Dalla casualità della storia, interpretata appunto come 'caso' dal mondo
culturale greco antico, con una concezione ciclica del tempo storico, come per
il fluire del tempo naturale (ad es. i cicli stagionali), passando attraverso
la teleologicità (o fine ultimo di ogni fatto) del pensiero medievale
cristiano-occidentale, il quale recuperò invece la concezione dell'ebraismo di
una storia umana unica, con un inizio rappresentato dalla creazione e una sua
fine "avvento del regno di Dio sulla Terra", giungiamo nei secoli ad
un affinamento metodologico degli studi storiografici che, oltre al costante
problema precedentemente descritto, permetterà nelle epoche più recenti un
miglioramento della scientificità storiografica; ciò a vantaggio di una
possibile integrazione di orizzonti culturali fra le scienze sociali, come tra
la sociologia, scienza della società, fatto umano imprescindibile da
considerare al fine di comprendere ed interpretare il corso delle azioni umane,
e la storia stessa, la quale può coordinare, con metodo autonomo, i risultati
ottenuti dalle altre discipline, autentiche chiavi di lettura specialistiche
più adatte ad interpretare i nodi teorici sollevati dall'interpretazione dei
fatti umani.
Il rigore metodologico applicato dagli studiosi moderni di storia deriva dagli
illustri interventi di storici come S. Agostino, che, nel tentativo di scorgere
i disegni divini nell'excursus storico umano, permette alla
storiografia, al di là dei risultati e delle opinioni agostiniane, di
avvicinare le scienze volte a comprendere i fatti oltre la loro mera evidenza
avalutativa, sostanzialmente incapace di misurare gli esseri viventi e le loro
complesse influenze reciproche nei millenni. Massimi storiografi furono, sul
piano del pensiero in riferimento ai fatti storici e osservandone la generale
capacità interpretativa, Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini, che
liberarono la storia politica dai condizionamenti teologici e della
predicazione morale.
Padre della storiografia moderna, con netta cesura epistemologica, epocale,
negli studi storiografici, risulta essere il pensiero di G.B.Vico, il quale
parte dall'assunto che il verace accertamento della natura di una cosa ignota è
identico comportamento della sua ricostruzione genetica; come il matematico, è
conoscitore perfetto colui che è creatore delle sue costruzioni: perciò, a
parte il Divino intervento, che Vico considera da credente come l'intervento di
chi è Creatore e perfetto Conoscitore delle cose create, solo l'uomo conosce e
determina i fatti umani a lungo termine, quando essi sono storia delle nazioni.
Prezioso apporto allo sviluppo storiografico, il discorso vichiano non ebbe nei
secoli dell'immediato futuro la stessa fortuna culturale che avrebbe meritato,
ontologicamente, come supporto teorico determinante allo sviluppo degli studi
storici: maggiormente seguito a livello europeo fu il discorso storico
hegeliano, che pur aveva 'partorito' l'assurda contraddizione, creata dalla
dialettica di F.Hegel (ad esempio in Lezioni sulla filosofia della storia)
e dei suoi numerosi epigoni, sul momento terminale dello sviluppo storico che
veniva posto al presente, giungendo all'ipotesi filosofica che nulla vi fosse
più da percorrere storicamente, né più un divenire storico possibile, né
tantomeno una qualsivoglia attività teoretica e pratica presente. La reazione a
questa assurda filosofia della storia, che vedeva insieme alla ipotetica
perfezione presente l'immanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
storica, fu il movimento positivista, che poteva ben dirsi nettamente opposto
all'idea di una filosofia che reputava la storia presente perfetta ma incapace
di evolversi.
Il positivismo, tentativo empirista invero estremista, nella causalità fattuale
naturale appurava essere l'unica forma mentis con la quale affrontare
metodi e risultati conoscitivi. In ciò vi era certamente uno svilimento
neoempirista estremo degli studi sulle cause storiche, di fronte al quale
veniva eliminata la scientificità della storia stessa, immolata come
ascientifica, poiché interpretante i fatti umani attraverso tragitti
conoscitivi non legati in modo ferreo a dimostrate leggi naturali. In realtà si
può aggiungere che non vi può essere lontananza reale tra gli studi sociologici
meno superficialmente empiristici e gli interessi secolari degli studi
storiografici: la società, i gruppi umani studiati dai sociologi, sono parti
integrate nel sistema sociale che gli storici considerano tramite la loro
ricerca, documentata da fonti attendibili post facto, che i sociologi
vogliono conoscere invece con formule o leggi scientifiche. In realtà,
osservando bene i due metodi, non è impossibile trovare un integrato
sistema-metodo da applicare, il quale vedrebbe i risultati scientifici,
classificati come leggi sociali, coesistere tranquillimente con documentati
riscontri oggettivi, sulle leggi medesime, nei fatti umani di ogni tempo; il
problema della separazione spesso rigida tra studi storiografici e studi
sociologici non è sicuramente ontologico ma metodologico, professionale,
accademico, didattico, divulgativo, massmediatico, sociale e persino
editoriale. Ma è non sicuramente nell'essenza di ogni possibile simbiotica integritas
studiorum.
Max Weber si occupò di metodologia delle scienze storico-sociali, giudicando la
scienza intrinsecamente avalutativa, non formulante cioè giudizi di valore,
quanto piuttosto esprimente correttezza ed adeguatezza di certe figure
concettuali - cosidetti tipi ideali o idealtipi - che configurano
alcuni modelli astratti come IL cristianesimo, LA democraticità istituzionale o
IL capitalismo, creati dallo storico al fine di ridurre ad unum dati
complessi derivanti dall'esperienza. Attività simile (ma non identica) a quella
già considerata in questa sede a proposito del prospetto
analitico di una tassonomia filosofica: attività definitoria di
categorie concettuali utili alla verifica empirica, nel caso weberiano
ontologicamente nei settori storiografici (paleografia, epigrafia, diplomatica,
attendibilità e veridicità delle fonti storiche etc.) mentre nel caso
considerato in queste pagine Internet metodologicamente, ai fini di indirizzare
fruttuosamente la ricerca empirico-scientifica.
Infine è doveroso aggiungere il particolare rilievo in Italia ebbero gli studi
storici ed i problemi filosofici ad essi connessi con l'intervento autorevole
di due esponenti dell'idealismo italiano, B.Croce e G.Gentile. Croce sostenne essere il giudizio storiografico il
grado più alto e concreto dell'attività teoretica dello spirito. A Croce sembrò
evidente una identità di filosofia e storiografia, essendo per lui la filosofia
il momento metodologico della storiografia, ossia quello della delucidazione
critica delle categorie universali, le quali nel giudizio si predicano del
fatto singolo. Gentile viceversa, al di là di una cospicua comunanza di
influenze e di pensiero con Croce, contestava il momento epistemologico dove si
realizzava l'identità di filosofia e storiografia, pervenendo alla conclusione
che i fatti, o storia in opera, esistono come manifestazione dello spirito
pratico; dall'altra parte abbiamo invece le categorie, che fungono da ambito
della filosofia come metodologia; motivo per cui la sintesi di filosofia e
storiografia è sì suggestiva ma fallace.
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025