|
|
| |
Economia Politica – Integrazione
Cap. XXV – La teoria del commercio internazionale
1. Le ragioni dello scambio internazionale
Lo scambio di beni avviene sia all’interno di uno Stato, sia tra diversi Stati. Gli scambi di beni all’interno del Paese costituiscono il commercio interno, mentre gli scambi di beni tra imprese di Paesi diversi costituiscono il commercio internazionale. Il commercio internazionale non è soggetto alle stesse leggi del commercio interno poiché, mentre all’interno di un Paese la mobilità dei fattori produttivi (capitale e lavoro) è alta, da un Paese all’altro è assai minor 636c24g e. Inoltre le stesse conoscenze tecniche vengono comunicate da un Paese all’altro meno facilmente che all’interno di un singolo Paese. Quindi la scarsa mobilità dei fattori produttivi e delle conoscenze tecnologiche porta ad una distribuzione diseguale tra i diversi Paesi; anche le risorse naturali sono distribuite in modo diseguale. Questo fa sì che in alcuni Paesi risulti più conveniente la produzione di certi beni e in altri risulti più conveniente la produzione di altri beni, o meglio la produzione di beni avviene a costi diversi nei vari Paesi. Il fatto che la produzione di alcuni beni sia più conveniente in un Paese piuttosto che in un altro, può indurre ogni Paese a specializzarsi nella produzione del bene a lui più conveniente, facendo così nascere l’esigenza del commercio internazionale.
2. La teoria dei costi comparati
a) il caso in cui ciascun Paese ha un vantaggio nella produzione di un bene
I primi economisti, tra cui Ricardo, che studiarono l’argomento misuravano il costo di un bene mediante il tempo di lavoro necessario a produrlo.
Facciamo un esempio: supponiamo che il costo di produzione di 1 quintale di grano in Inghilterra sia pari a 80 ore di lavoro mentre in Portogallo a 100; invece il costo di produzione di 1 ettolitro di vino è pari a 110 nel primo e a 70 nel secondo. Supponiamo inoltre che i prezzi dei beni siano proporzionali ai costi di produzione, cioè che i salari siano eguali nei due Paesi. L’Inghilterra ha un vantaggio nella produzione del grano e il Portogallo in quella del vino, perciò all’Inghilterra converrà specializzarsi nella produzione di grano e comprare vino dal Portogallo, viceversa al Portogallo converrà specializzarsi nella produzione di vino e comprare grano dall’Inghilterra.
Quindi la ragione dello scambio tra i due Paesi sembrerebbe la differenza tra i costi di produzione dei due beni, infatti se il costo del grano o del vino fosse eguale tra i due Paesi non nascerebbe alcuno scambio. Ricardo poi notò anche che la condizione perché si verifichi lo scambio internazionale non è il divario tra i costi assoluti ma quello tra i costi relativi o comparati. Annunciò così la teoria dei costi comparati. Il costo comparato è il rapporto tra i costi di due beni nello stesso Paese. Nell’esempio precedente il costo comparato di grano e vino per l’Inghilterra sarà 80/110 e per il Portogallo 100/70. La ragione di scambio internazionale è il rapporto tra i prezzi dei due beni nello scambio internazionale. Quindi la ragione di scambio oscillerà tra 80/110 e 100/70, ovvero i costi comparati. Si può concludere quindi che: quando vi è un divario tra i costi comparati di due Paesi, lo scambio internazionale è conveniente per entrambi purché la ragione di scambio internazionale tra i due beni sia compresa tra i costi comparati.
b) il caso in cui Paese ha un vantaggio uguale nella produzione di entrambi i beni
Quando un Paese ha un vantaggio nella produzione di entrambi i beni, l’analisi dei costi assoluti non spiega più nulla e diventa importante la teoria dei costi comparati. In questo caso si possono verificare due ipotesi: questo vantaggio è uguale per entrambi i beni, oppure è maggiore per uno dei due.
Se
pensiamo al primo caso: il costo di produzione di 1 quintale di grano in
Inghilterra è 80 ore di lavoro e in Portogallo 160; il costo di produzione di 1
ettolitro di vino è
c) il caso in cui un Paese ha un vantaggio nella produzione di entrambi i beni, ma maggiore per uno dei due: il paradosso ricardiano
Supponiamo
che il costo di produzione di 1 quintale di grano sia di 80 ore di lavoro in
Inghilterra e di
3. L’equilibrio del mercato internazionale dei beni
Abbiamo visto che vi è convenienza allo scambio per entrambi i Paesi quando c’è un divario tra i costi comparati, purché lo scambio avvenga ad una ragione compresa tra i valori dei costi comparati. Ma come si determina il valore esatto della ragione di scambio, cioè come si determinano i prezzi a cui beni vengono scambiati sui mercati internazionali? Il mercato internazionale funziona come quello interno. Per ogni bene vi sono domanda e offerta, che il prezzo di equilibrio rende uguali; la teoria dei costi comparati ci dice che se la domanda e l’offerta determinassero un prezzo di equilibrio al di là dei valori dei costi comparati, cesserebbe la convenienza allo scambio per uno dei due Paesi e quindi lo scambio non si verificherebbe. La determinazione dei prezzi di equilibrio sul mercato internazionale avviene dunque come nei mercati interni. L’unica differenza è che nei mercati interni si considera la domanda e l’offerta di un singolo bene, nella teoria del commercio internazionale consideriamo due Paesi che si scambiano reciprocamente due beni. Si parla infatti di ragione di scambio internazionale, cioè il rapporto tra i prezzi dei due beni. La ragione di scambio di equilibrio sarà dunque il rapporto tra i prezzi di equilibrio dei due beni. Quindi nello scambio di beni tra due Paesi la posizione di equilibrio è caratterizzata da quella ragione di scambio che eguaglia per ciascuno dei due beni la quantità domandata da un Paese e la quantità offerta dall’altro. Questo risultato è stato raggiunto dall’economista inglese John Stuart Mill. Sia la teoria di Ricardo che il risultato di Mill possono essere generalizzati in modo da considerare molti Paesi che commerciano tra di loro scambiandosi molti beni.
Sviluppi successivi della teoria dei costi comparati
La
teoria dei costi comparati fu la base scientifica per sostenere l’abolizione
dei dazi sul grano nell’Inghilterra della prima metà dell’Ottocento. L’aumento
della popolazione in Inghilterra faceva aumentare la domanda di grano; per
aumentarne la produzione i proprietari terrieri mettevano a coltura terreni via
via meno fertili e questo determinava un aumento del prezzo del grano. Era però
possibile importare dall’estero che aveva grande abbondanza di terre fertili e
quindi a prezzi più bassi. Perciò i dazi sul grano importato avvantaggiavano
solo i proprietari terrieri creando delle rendite a loro favore. Secondo la
teoria classica, i costi di produzione dei beni venivano misurati da Ricardo in
ore-lavoro; con l’affermarsi dell’indirizzo neo-classico i prezzi dei beni non
sono determinati più dalle quantità di lavoro ma dalle preferenze soggettive,
di conseguenza si sentì il bisogno di riformulare la teoria dei costi
comparati. G. Haberler ha misurato dunque i costi di produzione dei beni in
termini di costo-opportunità. Il costo-opportunità
indica la produzione alternativa cui occorre rinunciare per ottenere un’unità
in più di un dato bene, ovvero il saggio marginale di trasformazione. Se ad
esempio si producono
5. La teoria di Heckscher e Ohlin
Lo scambio internazionale si verifica perché esistono differenze nei costi (comparati) di produzione dei beni nei vari Paesi. Una delle cause è la diversità nella dotazione dei fattori produttivi tra le nazioni, determinata da una diversa dotazione naturale delle risorse, dal grado di sviluppo dei vari Paesi, dalle loro istituzioni sociali. Gli economisti svedesi E. F. Heckscher e B. G. Ohlin sostengono che ogni Paese tenderà ad esportare quei beni la cui produzione richiede un uso più intenso del fattore che in quel Paese è abbondante (lavoro – capitale). Le analisi empiriche però non sempre hanno dato ragione a questa teoria: gli Stati Uniti, ad esempio, risultano essere esportatori anche di beni ad alta intensità di lavoro, pur essendo specializzati in beni ad elevato contenuto di capitale. Questo risultato è noto come paradosso di Leontief dal nome dell’economista che lo ha trovato. Heckscher e Ohlin inoltre hanno affermato che i prezzi dei fattori produttivi nei Paesi tra i quali si svolge lo scambio internazionale tendono ad eguagliarsi. P. A. Samuelson ha approfondito questo punto, affermando: man mano che una nazione in cui vi è sovrabbondanza di lavoro si specializza nella produzione di beni ad alta intensità di questo fattore, aumenterà la domanda di lavoro da parte delle imprese e quindi i salari tenderanno a crescere; la domanda di capitale non aumenterà e di conseguenza il prezzo del capitale tenderà a diminuire. Viceversa in un Paese che ha sovrabbondanza di capitale, man mano che si specializza nella produzione di beni che contengono questo fattore, crescerà la domanda di capitale e diminuirà quella di lavoro, perciò il prezzo del capitale tenderà a salire e i salari a scendere. Quando i fattori sono anch’essi mobili da un Paese all’altro, la tendenza all’eguagliamento dei prezzi dovrebbe rafforzarsi. L’esperienza però non sembra avvalorare questa teoria. Infatti nei Paesi dove il capitale è abbondante normalmente si ha un intenso progresso tecnologico con una conseguente crescita della produttività del lavoro che consente un forte aumento dei salari, mentre ciò non accade nelle nazioni che hanno sovrabbondanza di popolazione rispetto al capitale. L’esistenza di restrizioni agli scambi e ai movimenti dei fattori può essere un elemento che ostacola la tendenza alla parificazione dei prezzi dei fattori nei diversi Paesi. Tale tendenza opera comunque lentamente e nel lungo periodo, a causa delle forze che la contrastano.
6. La teoria del ciclo del prodotto e gli sviluppi successivi
Il commercio internazionale non può essere collegato esclusivamente alla dotazione dei fattori produttivi dei diversi Paesi, perciò si devono prendere in considerazione altri elementi come il progresso tecnico. La teoria del ciclo del prodotto mira a schematizzare le fasi della vita di un bene per derivare delle conclusioni sulla composizione del commercio internazionale e sul suo sviluppo.
- Fase introduttiva: un prodotto nuovo richiede ricerca, sperimentazione, adattamento ed eventuali modifiche; questo comporta un uso intenso di lavoro specializzato ed alti costi di produzione, quindi il prodotto sarà venduto a prezzi alti;
- a questa succede una fase di sviluppo in cui il bene può essere prodotto in serie e distribuito su larga scala; diminuisce l’importanza del fattore lavoro nel processo produttivo e aumenta l’intensità del capitale; cresce il numero dei produttori riducendo il costo di produzione del bene e ne aumenta l’offerta; di conseguenza il prezzo del bene diminuisce;
- fase della maturità, man mano che il mercato diventa saturo il numero delle vendite del prodotto raggiunge un limite; il bene in questa fase è standardizzato e i processi produttivi impiegano sempre più intensamente il capitale; le unità produttive sono più ampie e la manodopera poco qualificata; un aumento del prezzo del bene ora provocherebbe una riduzione della domanda.
Questo schema mira a spiegare la composizione e lo sviluppo del commercio internazionale. Storicamente l’introduzione di prodotti nuovi si è avuta in Paesi con un alto livello di reddito per abitante; quando sono nella fase di sviluppo invece i beni si diffondono nelle nazioni che hanno un livello minore di reddito pro capite; quando sono nella fase di maturità i beni entrano nei Paesi che sono attualmente sottosviluppati. Questa teoria attribuisce quindi un’importanza determinante alla tecnologia ed ai suoi mutamenti per spiegare le correnti degli scambi internazionali. Una teoria diversa è quella di Helpman e Krugman, i quali hanno sostenuto che ciascun Paese vende all’estero i beni ad un prezzo diverso da quello a cui li vende all’interno; in questo modo cerca di sfruttare la struttura della domanda di ogni altro Paese e questo spiega le correnti attuali degli scambi internazionali.
Cap. XXVI – La politica commerciale
1. Protezionismo e libero scambio
La produzione dei beni avviene a costi diversi nei vari Paesi e quando vi è un divario tra i costi comparati lo scambio internazionale è vantaggioso per entrambi i Paesi. Quindi una politica ispirata alla libertà degli scambi (di libero scambio), ovvero che non pone restrizioni, consente ad ogni Paese di specializzarsi nelle produzioni in cui ha costi minori e avvantaggia tutte le nazioni poiché tutti i beni vengono prodotti al minor costo possibile. Spesso però i Paesi hanno adottato politiche protezionistiche per ridurre le importazioni ed espandere le esportazioni. Gli strumenti principali sono i dazi doganali (o tariffe), i contingenti di importazione e i sussidi all’industria nazionale. I dazi doganali sono tributi che colpiscono le merci straniere che entrano nel territorio nazionale; possono essere specifici o ad valorem: il dazio specifico è commisurato alla quantità della merce importata, il dazio ad valorem è commisurato ad una percentuale del valore (prezzo moltiplicato per quantità) della merce importata. Attualmente in Italia si usa il sistema dei dazi ad valorem. A seconda del fine i dazi possono essere fiscali o protettivi: i dazi fiscali hanno lo scopo di fornire delle entrate finanziarie allo Stato, i dazi protettivi di scoraggiare l’ingresso delle merci straniere nel Paese. In genere i dazi fiscali sono lievi perché determinerebbero un forte aumento del prezzo delle merci importate e un calo della domanda, di conseguenza finiscono per scoraggiarne l’ingresso nel Paese. Quindi un dazio fiscale alto non assolverebbe più la sua funzione di fornire entrate allo Stato ma assolverebbe la funzione protettiva. I contingenti di importazione consistono nel determinare la quantità massima di un prodotto estero che può essere importata. Occorre dunque trovare un sistema per suddividere la quantità di merce ammessa all’importazione tra tutti gli operatori che desiderano importarla; di solito si usano le licenze di importazione, ovvero chiunque desideri importare quella merce deve procurarsi la licenza dai competenti organi amministrativi. I sussidi o premi all’industria nazionale, detti anche premi all’esportazione, consistono nel pagare somme di denaro oppure nel concedere sgravi tributari o degli oneri sociali alle imprese. Queste misure riducono i costi di produzione delle imprese che potranno vendere i loro prodotti a prezzi più bassi; così potranno esportare di più e vendere di più all’interno, importando meno perché i consumatori interni preferiranno i prodotti nazionali ad un prezzo minore di quelli importati.
2. Le ragioni a favore del protezionismo
I
dazi e i sussidi alterano i prezzi dei beni e quindi i costi comparati,
riducendo gli scambi di merci tra i Paesi; invece i contingenti riducono
direttamente tali scambi. Con la politica protezionistica vengono persi i
vantaggi della specializzazione produttiva messi in evidenza dalla teoria dei
costi comparati, in altre parole distrugge la ricchezza. Le misure
protezionistiche riducono il benessere anche del Paese che le adotta perché
producono l’effetto di far impiegare risorse (lavoro e capitale) nella
produzione di certi beni a costi più elevati anziché nella produzione di altri
beni a costi minori. La necessità per gli Stati di adottare politiche
protezionistiche è stata sostenuta secondo diverse argomentazioni. La prima è
di carattere extra-economico: l’eccessiva specializzazione produttiva può
danneggiare l’indipendenza politica di un Paese quando questo dipende dal
commercio internazionale per i generi alimentari o per il materiale bellico.
Altri argomenti sono di natura economica e il più noto è quello dell’industria giovane, elaborato da vari
economisti tra cui J. Stuart Mill. Secondo Mill un Paese nella fase iniziale
dello sviluppo deve adottare misure di protezione dalla concorrenza estera,
altrimenti le industrie non potrebbero nascere o quelle già nate non potrebbero
sopravvivere; ovviamente quando le industrie si sono consolidate questa
politica protezionistica dovrebbe essere abbandonata. L’economista tedesco F.
List evidenziò che l’Inghilterra fu il primo paese ad avere la rivoluzione
industriale perciò non doveva proteggere la propria industria, mentre
Ad esempio, se gli Stati Uniti impongono un dazio sull’importazione di calzature italiane e i produttori italiane non riescono a smerciarle altrove, i produttori ne abbasseranno il prezzo; in questo caso il dazio non avrà un effetto protettivo per l’industria americana ma avrà carattere fiscale. Ma a priori nulla lascia ritenere che gli stranieri si accolleranno l’onere del dazio, infatti i produttori italiani potranno vendere altrove e quindi non ridurre il prezzo. L’addossamento del dazio agli stranieri potrà quindi verificarsi solo in condizioni molto particolari.
Inoltre i Paesi industrializzati hanno difficoltà a produrre diversi beni a costi competitivi perché i Paesi in via di sviluppo riescono a produrli a costi minori, avendo bassi salari. Questo potrebbe legittimare politiche protezionistiche ma in realtà il libero scambio porta i Paesi industrializzati ad abbandonare la produzione di certi beni con tecniche che impiegano molto lavoro e si specializzerà nella produzione di beni con tecniche ad elevata produttività, accrescendo il benessere generale.
3. Altri strumenti di politica commerciale
La politica di un Paese volta a regolare gli scambi di merci con gli altri Paesi prende il nome di politica commerciale, che può essere ispirata alla libertà di scambi (liberista) oppure può essere protezionista. Gli strumenti del protezionismo esaminati prima sono strumenti di politica commerciale.
a) il dumping
Un altro strumento è rappresentato dal dumping: le grandi imprese nazionali vendono i loro prodotti sui mercati stranieri ad un prezzo inferiore al costo di produzione e recuperano la perdita vendendoli all’interno del Paese ad un prezzo assai più alto. Bisogna ovviamente che lo Stato imponga un dazio in modo da impedire che i prodotti esportati a basso prezzo rientrino nel territorio nazionale. Questo strumento è detto dumping commerciale, infatti esiste anche il dumping valutario ovvero la svalutazione del tasso di cambio, attuata per espandere le esportazioni.
b) la tariffa doganale
La tariffa doganale di uno Stato è l’elenco di tutte le merci che lo Stato colpisce con un dazio al loro ingresso, con l’indicazione delle aliquote del dazio per ogni merce. La tariffa può essere generale (o autonoma) e convenzionale (o contrattuale). La tariffa generale o autonoma è quella che lo Stato applica alle merci dei Paesi con i quali non ha stipulato trattati di commercio, mediante i quali i Paesi fissano dazi inferiori a quelli della tariffa generale. Si viene a creare una nuova tariffa detta convenzionale o contrattuale. Quindi la tariffa convenzionale o contrattuale è quella che lo Stato applica alle merci provenienti dai Paesi con cui ha stipulato trattati di commercio.
c) la clausola della nazione più favorita
Una clausola che viene spesso inserita nei trattati di commercio è la clausola della nazione più favorita. Ogni riduzione della tariffa generale che un Paese A accorda con un Paese C si estende automaticamente a qualunque altro Paese B con cui il Paese A aveva stipulato questa clausola.
Es. Il Paese A fissa nella tariffa generale un dazio di 1,50 € al quintale per l’importazione di zucchero. Conclude inoltre un trattato con il Paese B riducendo il dazio a 1,20 € al quintale, includendo la clausola di nazione più favorita. Successivamente il Paese A conclude un trattato con il Paese C ribassando quel dazio a 1 € al quintale; la clausola nel trattato tra A e B impone ad A di estendere il ribasso accordato a C anche al Paese B.
d) il drawback
I dazi che colpiscono l’importazione di materie prime o di semilavorati determinano aumenti dei costi dei prodotti manufatti che derivano dalla loro trasformazione. Per evitare ciò si ricorre al drawback, ovvero il meccanismo per cui lo Stato rimborsa al produttore del manufatto il dazio sulle materie prime importate. Oppure lo Stato può consentire la temporanea importazione in franchigia a condizione che entro un determinato periodo i manufatti prodotti vengano esportati.
4. Brevi cenni storici su protezionismo e libero scambio
Il
protezionismo è stato più o meno intenso, a seconda delle circostanze storiche,
in tutti quei Paesi che hanno avuto il problema di difendere la propria
industria nascente dalla concorrenza straniera. Nel periodo dalla metà
dell’Ottocento alla prima guerra mondiale si è avuta una prevalenza di libero
scambio, inframmezzata da periodi di ripresa del protezionismo come in Italia e
in Germania. Una prima tariffa doganale in Italia venne introdotta nel 1878 e
poi una più consistente nel 1887. Invece nel periodo tra le due guerre mondiali
si è avuta una prevalenza del protezionismo, sfociato dalle politiche
nazionalistiche, insieme al bilateralismo degli scambi, cioè il tentativo da
parte di ogni Paese di avere la bilancia degli scambi in pareggio con ciascuna
altra nazione presa singolarmente, e all’autarchia, cioè produrre all’interno
tutto ciò di cui un Paese ha bisogno. Questa politica impoverì i Paesi che la
praticavano e gli altri, inoltre si inquadrava nelle ideologie nazionalistiche
che portarono allo scoppio del secondo conflitto mondiale. Dopo la seconda
guerra mondiale gli Stati non socialisti tornarono al libero scambio
abbandonando il bilateralismo. Lo scopo era creare un sistema generale di
relazioni economiche, monetarie e commerciali, affidandone la gestione ad
appositi organismi come il Fondo
Monetario Internazionale (F.M.I.) e
5. Le barriere non tariffarie
Esistono altri strumenti di protezionismo detti barriere non tariffarie. Tali barriere sono numerosissime, hanno avuto un forte sviluppo a partire dagli anni Settanta e hanno rappresentato un modo attraverso cui molti Stati, in particolare Stati Uniti e Giappone, hanno eluso quei trattati internazionali come il GATT. Due esempi di barriere non tariffarie sono le restrizioni volontarie all’esportazione e i regolamenti sanitari. Le restrizioni volontarie all’esportazione consistono nel fenomeno per cui un Paese A, facendo uso della sua forza politica, convince un altro Paese B a ridurre le sue esportazioni verso A. L’altro esempio sono i regolamenti sanitari, ovvero un Paese A vieta l’importazione di un bene da un Paese B perché quel bene non è prodotto secondo le regole previste dalle leggi sanitarie del Paese A. Il Paese B potrebbe produrre il bene secondo le norme del Paese A ma comporterebbe degli aggravi di costo, per cui è come se il Paese A avesse imposto un dazio sulla merce del Paese B.
6. Le unioni
doganali e
Quando
più Paesi si impegnano ad eliminare i dazi tra di loro, si ha una zona (o area) di libero scambio. Se essi si impegnano anche ad attuare una
politica tariffaria comune nei confronti dei Paesi terzi si ha un’unione doganale. Se un’unione doganale
prevede anche la libertà di movimento dei fattori produttivi si ha un mercato comune. Se i Paesi in un
mercato comune prevedono politiche economiche comuni o coordinate, si ha un’unione economica. Un esempio di area di
libero scambio è l’EFTA (European Free Trade Association) sorta nel 1958 tra
Gran Bretagna, Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera,
Finlandia; oggi comprende solo 4 Paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e
Svizzera.
Cap. XXVII – La bilancia dei pagamenti e il cambio
1. La funzione delle riserve valutarie
a) l’esigenza di una moneta con cui regolare gli scambi internazionali
Gli scambi di merci tra diversi Paesi non avvengono più con il sistema del baratto e quindi si è sentita l’esigenza di avere anche per essi una moneta. Per gli scambi internazionali però vi è una difficoltà in più perché non esiste un’autorità sopranazionale che stampi una moneta accettata in tutti gli Stati. In alcuni periodi dunque questi pagamenti venivano fatti in oro, in altri periodi venivano fatti mediante una moneta di un Paese con un’economia forte, tale valuta è oggi il dollaro americano.
b) i pagamenti internazionali in regime di convertibilità delle monete
In diversi periodi storici numerose monete erano convertibili in oro o in una moneta detta moneta-chiave (o valuta-chiave, divisa-chiave), nel senso che in molti Stati la banca centrale era pronta a cambiare in oro o nella divisa-chiave la propria moneta nazionale sulla base di una parità fissa. In questo caso gli scambi internazionali venivano pagati con tutte le valute convertibili.
Se ad esempio gli italiani pagano la merce importata dall’Inghilterra con le lire, gli inglesi possono portare alla banca centrale inglese le lire e ottenere in cambio un certo quantitativo di oro o di dollari.
Sembrerebbe quindi che i cittadini di un Paese vengano così a possedere oro o valute-chiave o in genere valute di altri Paesi, ma di solito non è così. E’ la banca centrale che possiede l’oro e le valute estere, infatti quando ad esempio un italiano esporta merce in Inghilterra e riceve sterline, le porterà alla Banca d’Italia che (attraverso l’UIC, ufficio italiano cambi) gli darà in cambio lire e non oro.
c) l’importanza delle riserve valutarie
Quindi comunque vengano regolati i pagamenti internazionali, le esportazioni determinano l’ingresso di valute estere nei forzieri della banca centrale del Paese che esporta, mentre le importazioni determinano uscita di valute estere dal Paese che importa. Supponiamo che in un certo periodo di tempo un Paese esporti meno di quanto importi; la banca centrale di quel Paese riceve come pagamento delle esportazioni una quantità totale di diverse valute estere ma d’altra parte deve sborsare una cifra maggiore per consentire il pagamento delle importazioni. Risulta chiara l’esigenza per un Paese di disporre di una certa quantità di mezzi di pagamento internazionali (oro, valute-chiave, valute estere) per far fronte a squilibri temporanei tra importazioni ed esportazioni. Le quantità di mezzi di pagamento internazionali possedute dalla Banca centrale di un Paese costituiscono le riserve valutarie. Le riserve valutarie dei Paesi che hanno aderito all’Unione monetaria europea sono gestite dalla Banca centrale europea e sono costituite da oro, dollari e altre valute pregiate. Sappiamo inoltre che nei Paesi industrializzati dell’Europa e del Nord America non sono più solo le banche centrali a detenere le riserve valutarie. Infatti nei Paesi in cui si segue una politica di libero scambio gli esportatori e gli importatori non si rivolgono alla banca centrale ma possono rivolgersi a qualunque banca. Le valute estere possedute dalle banche rappresentano una riserva analoga alle riserve valutarie gestite dalla banca centrale, spesso vengono depositate presso banche straniere o utilizzate per comprare titoli stranieri.
2. La bilancia dei pagamenti da un punto di vista contabile
Le esportazioni e le importazioni di merci non sono gli unici rapporti economici internazionali. Il documento che registra tutti i rapporti economici che un Paese ha con l’estero prende il nome di bilancia dei pagamenti.
|
Bilancia dei pagamenti: |
A) Bilancia delle transazioni correnti (partite correnti): B) Movimenti di capitali: |
1) Esportazioni e importazioni di merci (bilancia commerciale) 2) Partite invisibili (turismo, ecc.) 3) Trasferimenti unilaterali (rimesse degli emigranti, donazioni, interessi, dividendi, ecc.) 1) Investimenti finanziari 2) Investimenti diretti |
La bilancia dei pagamenti di un Paese si riferisce ovviamente ad un periodo di tempo determinato, normalmente un anno. Quella parte della bilancia dei pagamenti che comprende solo le esportazioni e le importazioni di merci prende il nome di bilancia commerciale; invece le partite invisibili riguardano le esportazioni e le importazioni di servizi come il turismo (il turista americano che mangia in un ristorante italiano); i trasferimenti unilaterali sono movimenti di valuta che non nascono da uno scambio e quindi non danno luogo a un corrispondente movimento di beni o prestazione di servizi. Questi ultimi comprendono: le rimesse degli emigranti, somme di denaro che ad esempio gli italiani emigrati all’estero inviano in patria; le donazioni, ad esempio una somma di denaro regalata da un cittadino americano ad un italiano o viceversa; gli interessi, che il Tesoro italiano paga su un titolo del debito pubblico italiano posseduto da uno straniero (un uscita) oppure che un italiano possiede su un titolo straniero (entrata); i dividendi, pagati ad esempio da un’impresa italiana su un’azione posseduta da uno straniero o viceversa. Il complesso delle voci considerate finora costituisce la bilancia delle transazioni correnti (o delle partite correnti). Invece i movimenti di capitali comprendono i movimenti di valuta effettuati per compiere un investimento in un Paese straniero. Gli investimenti finanziari consistono nell’acquisto di titoli stranieri da parte di cittadini italiani o di titoli italiani da parte di cittadini stranieri. Se invece un italiano acquista uno stabilimento industriale all’estero o uno straniero acquista uno stabilimento industriale in Italia, si ha un investimento diretto.
3. La necessità per un Paese di avere la bilancia dei pagamenti in equilibrio
Tutte le voci della bilancia dei pagamenti determinano entrata o uscita di oro o di valute estere per un Paese. Le esportazioni di merci determinano ingresso di valuta nel Paese che esporta, mentre le importazioni di merci determinano uscita di valuta. Quando in un dato periodo di tempo le entrate totali di valuta in un Paese superano le uscite totali di valuta da quel Paese, diremo che la bilancia dei pagamenti di quel Paese è in avanzo, o in attivo o i surplus, o che ha un saldo positivo (attivo); il saldo della bilancia dei pagamenti è dato dalla differenza tra le entrate e le uscite totali di valuta. Quando le entrate e le uscite di valuta sono uguali, la bilancia dei pagamenti è in pareggio o in equilibrio e il suo saldo è uguale a 0. Quando le uscite di valuta superano le entrate, la bilancia dei pagamenti è in disavanzo, o in passivo o in deficit, e il suo saldo è negativo (passivo). Sappiamo che ogni Paese dispone di una certa quantità di riserve valutarie, perciò se in un dato periodo la bilancia dei pagamenti è in deficit, il Paese finanzierà questo deficit con le riserve valutarie che possiede. Tale situazione non può durare a lungo poiché prima o poi le riserve valutarie del Paese si esaurirebbero; pertanto ogni Paese deve preoccuparsi di mantenere la propria bilancia dei pagamenti in equilibrio o per lo meno che il deficit non vada al di là di certi limiti. Invece se la bilancia dei pagamenti di un Paese è in surplus, le sue riserve valutarie aumenteranno, ma nemmeno questa situazione può mantenersi per lunghi periodi, perché se un Paese ha la propria bilancia in avanzo, altri ce l’avranno in disavanzo e quindi correggeranno la situazione. Inoltre quando la bilancia dei pagamenti è in surplus entra valuta nel Paese, quindi la quantità di moneta interna aumenta perché la valuta estera viene trasformata dalla banca centrale in moneta interna; un continuo aumento di quantità di moneta interna crea pressione inflazionistica nel Paese (aumento dei prezzi). Pertanto ciascun Paese, anche se per un certo tempo può avere squilibri nella bilancia dei pagamenti, nel lungo periodo si adopererà per avere la bilancia dei pagamenti in equilibrio.
4. La bilancia dei pagamenti dell’Italia
|
VOCI |
Saldo 2003 |
|
Conto corrente |
|
|
Merci |
|
|
Servizi |
|
|
Redditi |
|
|
Trasferimenti unilaterali |
|
|
Conto capitale |
|
Lo schema contabile della bilancia dei pagamenti italiana è leggermente diverso da quello generale. Il saldo è la differenza tra entrate e uscite e può essere positivo, negativo o uguale a 0. Le entrate rappresentano entrate di valuta e le uscite, uscite di valuta. Le entrate relative alla voce “merci” rappresentano le entrate di valuta conseguenti all’esportazione di merci, mentre le uscite relative alla voce “merci” rappresentano le uscite di valuta. La voce “merci” dunque rappresenta il saldo della bilancia commerciale. La voce “servizi” rappresenta le partite invisibili. La somma delle voci “redditi” e “trasferimenti unilaterali” è uguale ai trasferimenti unilaterali; la voce “redditi” contiene i redditi da lavoro (salari e stipendi) e i redditi da capitale (interessi e dividendi), nello schema precedente i redditi da lavoro erano chiamati rimesse degli emigranti e i redditi da capitale erano gli interessi e i dividendi. La voce “trasferimenti unilaterali” nella bilancia dei pagamenti italiana contiene solo le donazioni ed altre poche operazioni. La voce “conto corrente” è la somma di quattro voci: merci, servizi, redditi, trasferimenti unilaterali. Gli investimenti di cittadini stranieri in Italia sono nelle entrate dei movimenti di capitali (conto capitale) e gli investimenti di cittadini italiani in Paesi esteri sono nelle uscite della stessa voce. Ogni sezione o voce della bilancia dei pagamenti ha un saldo, dato dalla differenza tra entrate e uscite. Il saldo che però conta è essenzialmente quello totale (o globale), cioè la differenza tra la somma delle entrate e la somma delle uscite, detto saldo della bilancia dei pagamenti. Infatti è il saldo totale che determina l’aumento o meno delle riserve valutarie. Un Paese quindi potrebbe avere eccesso di importazioni sulle esportazioni di merci e colmare tale deficit con un saldo positivo delle partite invisibili o dei trasferimenti unilaterali o dei movimenti di capitali in modo da avere la bilancia dei pagamenti in pareggio, cioè un saldo totale pari a 0.
5. Grandezze reali e grandezze finanziarie nella bilancia dei pagamenti
Di tutte le voci che costituiscono la bilancia dei pagamenti solo le esportazioni e le importazioni fanno parte del prodotto nazionale. Le importazioni italiane non fanno parte del reddito nazionale italiano, ma vengono incluse con segno negativo solo per una pura ragione contabile; in realtà le importazioni italiane sono beni prodotti in altri Paesi e quindi fanno parte del reddito nazionale di quei Paesi. Invece, ad esempio, gli acquisti di titoli stranieri da parte di un italiano e gli acquisti di titoli italiani da parte di uno straniero non fanno parte del reddito nazionale di nessun Paese. Sono dette grandezze finanziarie e non reali, dato che non esisterebbero in un’economia di puro baratto. Le esportazioni e le importazioni invece sono grandezze reali dato che esistono anche in un’economia di puro baratto. Consistono nella produzione di beni e servizi che vengono venduti fuori del Paese. Le grandezze reali sono finanziate mediante valuta estera a differenza degli scambi interni che sono finanziati mediante moneta interna. Nella bilancia dei pagamenti mettiamo insieme e sommiamo grandezze reali con grandezze finanziarie poiché per un Paese è importante il saldo totale della bilancia dei pagamenti, perciò è utile considerare simultaneamente tutte le sue voci.
6. Il mercato valutario e la determinazione del cambio
In molti Paesi le valute straniere non sono detenute solo dalla banca centrale, ma anche dalle banche ordinarie. Il mercato valutario (o mercato delle valute, delle divise, dei cambi) è il luogo in cui si scambiano le monete dei diversi Paesi; per ogni valuta vi sono una domanda e un’offerta e queste dipendono dal prezzo di una valuta in termini di un’altra. Ad esempio, la domanda di dollari dipende dalla quantità di euro che bisogna dare per ottenere 1 dollaro, questo è il cambio, cioè il tasso di cambio dollaro-euro, cioè il prezzo del dollaro in termini di euro. Il cambio euro-dollaro ovviamente è il reciproco del precedente. In generale il tasso di cambio (o il cambio) tra due monete A e B è la quantità di moneta B necessaria ad acquistare una unità della moneta A. Quanto maggiore sarà la quantità di dollari che un americano deve sborsare per comprare 1 euro, tanto minore sarà la domanda di euro da parte degli americani. Pertanto la domanda di euro è funzione decrescente del tasso di cambio euro-dollaro; invece l’offerta di euro è funzione crescente del tasso di cambio euro-dollaro.
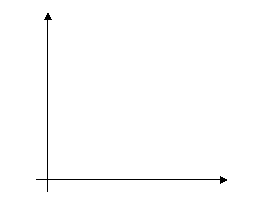
La domanda (D) diminuisce all’aumentare del cambio euro-dollaro, l’offerta (S) invece aumenta all’aumentare del cambio euro-dollaro. Le curve hanno lo stesso andamento di quelle di domanda e di offerta di un bene. L’intersezione tra di esse determina il cambio di equilibrio, che eguaglia la quantità domandata a quella offerta. L’eguaglianza tra la domanda e l’offerta di euro comporta l’equilibrio della bilancia dei pagamenti dell’UEM, cioè un saldo pari a 0, perché la domanda di euro equivale all’ingresso di valuta straniera e l’offerta di euro all’uscita di valuta straniera. Sul mercato dei cambi agiscono gli speculatori, i quali si comportano in modo analogo agli speculatori di borsa, ovvero svolgono un’azione di stabilizzazione dei cambi evitando brusche variazioni di questi. Se il cambio euro-dollaro aumenta si dice che l’euro si rivaluta o si apprezza (rivalutazione) e il dollaro si svaluta o si deprezza (svalutazione). Nell’uso corrente il termine svalutazione di una moneta può avere due significati:
a) perdita di potere d’acquisto esterno della moneta, perché con la stessa quantità di moneta si possono acquistare meno quantità di beni;
b) perdita di potere d’acquisto interno della moneta, perché i prezzi aumentano.
Si tratta di due fenomeni diversi, che vanno tenuti distinti.
Cap. XXVIII – I meccanismi di aggiustamento delle bilance dei pagamenti: il sistema aureo (1870-1914)
1. I presupposti del sistema aureo
Per ogni Paese esiste la necessità di avere la bilancia dei pagamenti in equilibrio, ciò non significa che ogni anno il saldo debba essere pari a 0, ma che nel lungo periodo ci sia una tendenza all’equilibrio delle bilance dei pagamenti dei diversi Paesi. I meccanismi che conducono a tale equilibrio sono stati differenti nelle diverse epoche storiche e hanno risposto a sistemi differenti di relazioni internazionali sia economiche che monetarie. Il sistema aureo (o gold standard) rappresentò il sistema di regolazione delle relazioni economiche internazionali dal 1870 al 1914, data di inizio della prima guerra mondiale. Tale sistema era basato su alcune regole del gioco che venivano accettate e rispettate da tutti i principali Paesi dell’epoca. Questi presupposti erano:
parità fissa tra ciascuna moneta e l’oro;
convertibilità di ciascuna moneta in oro;
legame tra la quantità di moneta in circolazione e la quantità d’oro posseduta da ciascun Paese.
Il
primo presupposto comportava che ogni Paese dichiarasse la parità della propria
moneta rispetto all’oro: perciò ad esempio 1 dollaro pesava
2. La determinazione del cambio e i punti dell’oro
La parità (aurea) tra due monete (cartacee) è il rapporto tra le parità delle due monete rispetto all’oro. Anche nel sistema aureo il cambio tra due monete cartacee è determinato dall’equilibrio tra la domanda e l’offerta sul mercato valutario, ma si può facilmente dimostrare che nel sistema aureo il cambio tra due monete è fisso. Infatti finché le banche centrali rispettano la regola della convertibilità sulla base della parità dichiarata, il cambio tra due monete cartacee sarà sempre determinato dal rapporto tra le parità di queste monete rispetto all’oro. E’ ovvio dunque che il cambio è fisso.
Ma
supponiamo che un italiano voglia acquistare dei marchi, dovrà spedire il corrispettivo
in oro in Germania e quindi dovrà sostenere dei costi per il trasporto e
l’assicurazione. Supponiamo che queste spese per
Vediamo quindi che il cambio in regime aureo non è del tutto fisso ma può oscillare entro due limiti molto ristretti, detti punto dell’oro. I punti dell’oro si determinano aggiungendo e sottraendo dalla parità tra le due monete le spese di spedizione e di assicurazione dell’oro da un Paese all’altro; il primo punto si chiama punto superiore dell’oro e il secondo punto inferiore.
3. L’aggiustamento delle bilance dei pagamenti
Nel regime aureo vi era un meccanismo automatico che riportava in equilibrio le bilance dei pagamenti tutte le volte che queste erano in squilibrio.
Se
consideriamo due Paesi e supponiamo che l’Italia abbia la bilancia dei
pagamenti in deficit mentre
Il processo di aggiustamento appena descritto è basato sulla teoria quantitativa della moneta. Un processo analogo si verifica anche con la teoria keynesiana e si fa l’ipotesi che nei due Paesi vi siano delle risorse disoccupate. Nella teoria keynesiana un aumento della quantità di moneta determina una diminuzione del tasso di interesse, che a sua volta genera un aumento degli investimenti che, attraverso il moltiplicatore, determina un aumento del reddito nazionale e dell’occupazione. Una diminuzione della quantità di moneta invece genera un aumento del tasso di interesse, quindi una diminuzione degli investimenti e del reddito nazionale e dell’occupazione. Quindi anche se nei Paesi considerati vi è disoccupazione, nel sistema aureo vi è sempre un meccanismo automatico che tende a riportare in equilibrio le bilance dei pagamenti.
4. I movimenti di capitali
Il processo di aggiustamento include, oltre ad esportazioni ed importazioni, anche i movimenti capitali. Quando in Italia diminuisce la quantità di moneta in circolazione, le banche italiane aumenteranno il saggio d’interesse che pagano sui depositi dei clienti e inoltre le imprese emetteranno obbligazioni a un più alto saggio d’interesse. In questo modo i tedeschi verranno a depositare i loro soldi nelle banche italiane e compreranno obbligazioni italiane, si avrà quindi un afflusso di capitali. In Germania d’altra parte avverrà il contrario. Quindi anche i movimenti di capitali tendono a sanare il disavanzo italiano e a ridurre il surplus della bilancia tedesca.
Questo sistema però non funziona allo stesso modo per tutti i Paesi. Infatti quando un Paese piccolo o povero aveva un disavanzo nella bilancia commerciale, il sistema funzionava come descritto. Ma quando il deficit era di un Paese molto ricco e potente, questo Paese non doveva affrontare la fuoruscita di oro con tutte le conseguenze esaminate. Bastava che tale Paese aumentasse il saggio di interesse perché molti stranieri investissero lì i propri capitali, in tal modo l’ingresso di capitali stranieri compensava il disavanzo commerciale. Un Paese ricco quindi per un certo tempo poteva continuare ad avere un deficit nella bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti in pareggio mediante l’afflusso di capitali dall’estero.
Cap. XXIX – I meccanismi di aggiustamento delle bilance dei pagamenti: i cambi flessibili e il controllo dei cambi (1914-1939)
1. Il crollo del sistema aureo
Il sistema aureo durò fino alla prima guerra mondiale, dopo la guerra si cercò di farlo rivivere ma senza successo. Tutte le nazioni infatti abbandonarono gradualmente la convertibilità delle loro monete in oro. Tra le regole del gioco infatti vi era la seguente: un Paese che aveva la bilancia dei pagamenti in deficit registrava una diminuzione delle riserve auree, doveva lasciar diminuire la quantità di moneta in circolazione. Ciò faceva diminuire i prezzi, il livello dei redditi e dell’occupazione. L’equilibrio della bilancia dei pagamenti per un Paese in deficit veniva dunque ottenuto mediante la deflazione interna, cioè facendo diminuire il livello del reddito e dell’occupazione nel Paese. I Paesi deficitari però non si sentivano di accettare la deflazione che avrebbe portato conseguenze politico-sociali negative, mentre i Governi si ponevano la piena occupazione come obiettivo principale. La politica monetaria veniva impiegata per generare un livello di domanda globale che garantisse la piena occupazione, ma spesso questo comportava un livello della domanda interna alto e di conseguenza basse esportazioni ed un elevato volume di importazioni, per cui non assicurava l’equilibrio della bilancia dei pagamenti. Troviamo conflitto tra equilibrio interno (piena occupazione) ed equilibrio esterno (bilancia dei pagamenti). Pertanto i Paesi che avevano la bilancia dei pagamenti in deficit e registravano una diminuzione delle riserve auree non diminuivano la quantità di moneta per evitare la disoccupazione; così facendo però non erano più in grado di convertire la moneta in oro e, mancando il presupposto della convertibilità, il sistema aureo non esisteva più. Anche antecedentemente alla prima guerra mondiale vi erano stati diversi casi di violazione delle regole del gioco che rappresentavano però un’eccezione, mentre dopo il 1918 divenne una regola per cui il sistema crollò.
2. La determinazione del cambio in regime di cambi flessibili
L’abbandono del sistema aureo portò ad un regime di cambi flessibili che in alcuni periodi divennero controllati. In un sistema di cambi flessibili (o fluttuanti o oscillanti), il cambio non sarà fisso come per il sistema aureo (visto che le divise non sono convertibili in oro) ma oscillerà liberamente e sarà determinato sulla base della domanda e dell’offerta di valuta, così come accade per il prezzo di qualunque bene.
3. La teoria della parità dei poteri d’acquisto
L’economista svedese Gustav Cassel enunciò nel 1992 la teoria della parità dei poteri d’acquisto e sostenne che il cambio di equilibrio tra due monete tende ad essere uguale al rapporto tra i poteri d’acquisto interni delle due monete. E’ facile dire che, se il tasso di cambio fra due monete fosse diverso dal rapporto tra i poteri d’acquisto delle stesse, esso si modificherebbe in modo da divenire uguale a tale rapporto. Ogni volta che il potere d’acquisto interno di una delle due monete muta, si modifica anche il tasso di cambio. Se ad esempio un quaderno negli Stati Uniti costa 1 dollaro e in Italia 0,50 euro e il tasso di cambio è 1 dollaro = 1 euro, ad un americano non conviene comprare il quaderno negli Stati Uniti perché allo stesso prezzo ne comprerebbe due in Italia; quindi gli americani vendono dollari sui mercati valutari per acquistare euro e l’offerta di dollari aumenta, facendo diminuire il prezzo del dollaro e quindi il tasso di cambio dollaro-euro; il processo continua finché il tasso di cambio dollaro-euro non raggiunge 1 dollaro = 0,50 euro, cioè il rapporto tra i poteri di acquisto delle due monete.
Il cambio tra le monete di due Paesi, secondo questa teoria, è quindi determinato dal livello dei prezzi interni dei Paesi stessi e si modificherà tutte le volte che mutano i prezzi interni nell’uno o nell’altro paese. La teoria di Cassel non contraddice l’affermazione secondo cui il cambio è determinato dalla domanda e dall’offerta delle valute, infatti sostiene che la domanda e l’offerta delle valute sono influenzate dal potere d’acquisto che esse hanno all’interno dei rispettivi Paesi, quindi il cambio di equilibrio sarà quello che corrisponde al rapporto tra i poteri di acquisto interni delle due monete. A questa teoria si possono fare diverse critiche. Ci si può chiedere di quali prezzi bisognerebbe tener conto per misurare il potere d’acquisto interno delle monete. Poi la domanda e l’offerta di valuta non dipendono solo dal potere d’acquisto interno delle monete, ma anche da altri fattori come l’acquisto e vendita di valute, i cosiddetti movimenti speculativi di capitali, che fanno variare la domanda e l’offerta di valuta ma non hanno nessuna relazione con il potere di acquisto interno delle monete. I movimenti speculativi di capitali possono spostare i tassi di cambio in modo rilevante dalle parità dei poteri d’acquisto, perciò la teoria di Cassel è valida solo in prima approssimazione.
4. Le variazioni del cambio e l’aggiustamento delle bilance dei pagamenti
Nel sistema di cambi flessibili gli squilibri delle bilance dei pagamenti vengono corretti da variazioni nel cambio, mentre i livelli dei prezzi, del reddito e dell’occupazione rimango in un primo tempo invariati. Invece nel sistema aureo ricordiamo che il cambio era fisso e l’equilibrio nella bilancia dei pagamenti viene ristabilito attraverso variazioni del livello dei prezzi, del reddito e dell’occupazione. Nel caso in cui due Paesi si trovino uno con un deficit nella bilancia dei pagamenti (Stati Uniti) e l’altro con un surplus (Inghilterra), entrambi dovuti alla bilancia commerciale, si verificherà una diminuzione del cambio tra le due divise finché la domanda e l’offerta della prima divisa non diventeranno uguali. Quindi benché i prezzi, espressi in dollari, delle merci americane non mutano, esse diventano meno costose per gli stranieri per effetto della svalutazione, infatti i prezzi delle merci americane espressi in sterline diminuiscono. Questo comporta un aumento della domanda di merci americane da parte degli stranieri e cioè un aumento delle esportazioni americane e un aumento della domanda di dollari da parte degli stranieri. Si nota come l’oscillazione del cambio tenda a riportare in equilibrio la bilancia dei pagamenti americana. Nel sistema aureo dunque l’equilibrio delle bilance dei pagamenti veniva raggiunto attraverso variazioni nel livello dei prezzi o del reddito o dell’occupazione dei Paesi, mentre il cambio rimaneva praticamente fisso. Nel regime di cambi flessibili invece l’equilibrio della bilancia dei pagamenti viene raggiunto attraverso variazioni nei cambi mentre i prezzi e il reddito interno non variano.
5. Gli inconvenienti dei cambi flessibili e gli effetti della svalutazione del cambio
a) il ruolo delle elasticità della domanda di esportazioni e importazioni
Sembrerebbe che il sistema di cambi flessibili eviti gli inconvenienti del gold standard, ma in realtà non è così. La svalutazione del cambio accresce la competitività delle esportazioni ma rende più costose le importazioni. Per un Paese la cui economia è basata sulla trasformazione in manufatti di materie prime importate non è possibile ridurre le importazioni senza creare disoccupazione; inoltre la svalutazione del cambio, rendendo più costosa l’importazione di materie prime, genera aumento dei prezzi interni, i sindacati potrebbero reagire chiedendo e ottenendo aumenti salariali, inoltre si potrebbe innescare un processo inflazionistico da conflitto sociale che potrebbe portare ad ulteriori aumenti dei prezzi, ulteriore deficit della bilancia dei pagamenti e successiva svalutazione del cambio. Insomma si avrebbe una spirale svalutazione-inflazione-svalutazione, come è accaduto in diversi Paesi negli anni Settanta. La rivalutazione dei Paesi eccedentari facendo diminuire le esportazioni può determinare disoccupazione in alcuni settori produttivi. Non è detto che la svalutazione del cambio migliori la situazione della bilancia dei pagamenti in un Paese deficitario perché la svalutazione fa sì che lo stesso volume di esportazioni dia luogo a introiti di valuta straniera minori e che lo stesso volume di importazioni comporti un esborso maggiore della moneta nazionale che si è svalutata. In seguito alla svalutazione del cambio la differenza tra uscite ed entrate di valuta straniera deve diminuire, perciò il volume delle esportazioni deve aumentare e/o il volume delle importazioni si deve ridurre in modo da bilanciare l’effetto negativo. Quindi risulta chiara l’importanza dei valori delle elasticità delle esportazioni e importazioni. La svalutazione migliorerà la situazione della bilancia dei pagamenti solo se la somma delle elasticità delle esportazioni e importazioni è superiore ad un certo valore, che è uguale a 1. Questo risultato è noto come la condizione di Marshall-Lerner dai nomi degli autori. Diversi economisti hanno affermato che non sempre il miglioramento della bilancia dei pagamenti si verificherà, infatti la convenienza ad acquistare un bene non dipende soltanto dal prezzo ma anche dalla qualità del bene, dal fatto che sia conosciuto sui mercati e dall’esistenza di una rete non solo di vendita ma anche di assistenza tecnica. Tutti questi elementi fanno sì che una svalutazione del cambio in un breve periodo può non determinare un aumento delle esportazioni. Nel lungo periodo però le imprese possono adottare delle strategie per penetrare nei mercati esteri e quindi la svalutazione del cambio può produrre un aumento delle esportazioni, inoltre il Paese che ha svalutato la propria divisa potrà in parte sostituire le importazioni con beni prodotti all’interno. In conclusione la svalutazione del tasso di cambio difficilmente potrà migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti nel breve periodo, ma lo farà nel lungo periodo. Inizialmente ci sarà una fase di peggioramento e poi una fase di miglioramento, poiché questo andamento si rappresenta con la forma della lettera J si dice che la svalutazione del tasso di cambio produce l’effetto J.
b) il
criterio dell’assorbimento e
Gli esponenti del criterio dell’assorbimento (absorption approach) ritengono che la svalutazione del cambio non può accrescere le esportazioni se il sistema economico è in piena occupazione. In questo caso infatti la produzione non può essere espansa e l’aumento delle esportazioni può avvenire solo se una parte della produzione destinata al consumo interno viene destinata alle esportazioni. Quindi se il sistema economico è in piena occupazione, la svalutazione del tasso di cambio farà aumentare le esportazioni solo se allo stesso tempo verrà adottata una politica fiscale o monetaria restrittiva, cioè che determini una riduzione della domanda interna. Se consideriamo l’equazione degli impieghi del reddito nazionale:
Y = Cp + Ip + G + X – M
dove Y è il reddito nazionale, Cp i consumi privati, Ip gli investimenti privati, G la spesa pubblica, X le esportazioni e M le importazioni. Se Y è dato, X può aumentare solo se Cp, Ip o G diminuiscono.
Gli esponenti della Nuova Scuola di Cambridge individuano nella spesa pubblica finanziata in disavanzo la componente dell’assorbimento da ridurre e quindi consigliano di diminuire il disavanzo pubblico allo scopo di ridurre il deficit della bilancia dei pagamenti. Altri autori sostengono che una politica monetaria restrittiva è il mezzo migliore per ridurre l’assorbimento interno ma è contraddittorio, infatti una politica monetaria restrittiva può generare una diminuzione del reddito e dell’occupazione e quindi sia una diminuzione dell’assorbimento sia una diminuzione della produzione. Ma il problema per un Paese in deficit è solo ridurre l’assorbimento ma non la produzione. In ogni caso la riduzione dell’assorbimento dovrebbe essere maggiore della riduzione della produzione.
c) l’approccio monetario alla bilancia dei pagamenti
Gli esponenti dell’approccio monetario alla bilancia dei pagamenti partono dalla premessa che un deficit della bilancia dei pagamenti produce di per sé una riduzione dell’offerta di moneta. Tale diminuzione non determina né una diminuzione del livello dei prezzi né una diminuzione dell’occupazione. I soggetti economici hanno una certa domanda di moneta, ossia desiderano detenere una certa quantità di moneta, per cui se l’offerta di moneta diminuisce, essi non ridurranno la detenzione di contante ma per avere lo stesso livello di questi ridurranno la spesa, cioè l’assorbimento. La diminuzione dell’assorbimento consentirà un aumento delle esportazioni e il deficit della bilancia dei pagamenti si correggerà automaticamente. L’approccio monetario alla bilancia dei pagamenti comunque è stato criticato per l’estremo irrealismo delle ipotesi su cui è basato.
d) ulteriori inconvenienti di un sistema di cambi flessibili
Uno dei difetti fondamentali del sistema di cambi flessibili è l’incertezza che crea negli operatori economici, che non sanno quale sarà l’equivalente in moneta nazionale di una valuta straniera. Gli operatori comunque possono coprirsi sui mercati dei cambi a termine (ovvero acquistare una valuta che sarà disponibile in una data futura ad un prezzo fissato oggi) ma l’operazione è costosa e in alcuni Paesi questi mercati non sono molto sviluppati. Solitamente le autorità monetarie intervengono sul mercato delle divise, acquistando e vendendo valuta, in modo da smorzare le fluttuazioni del cambio determinate dall’operare quotidiano delle forze di mercato. In questo caso si parla di fluttuazione sporca, si ha invece la fluttuazione pulita quando le autorità non intervengono nel mercato dei cambi e in pratica questa non si verifica quasi mai. Il ruolo che i movimenti di capitali esercitano in regime di cambi flessibili è controverso. Gli speculatori se prevedono che il cambio di un Paese si svaluterà e quello di un altro si rivaluterà, venderanno la moneta del primo e acquisteranno quella del secondo, quest’azione farà svalutare la moneta del primo e rivalutare quella del secondo, inoltre faciliterà il riequilibrio delle bilance. A parte il fatto che le variazioni del cambio possono generare notevoli inconvenienti, i movimenti speculativi di capitali potrebbero continuare anche dopo che le bilance dei pagamenti sono tornate in equilibrio o verificarsi in senso destabilizzante.
6. L’equilibrio interno e l’equilibrio esterno
Tra gli obiettivi della politica economica contemporanea rientrano sia il raggiungimento della piena occupazione (equilibrio interno) sia l’equilibrio della bilancia dei pagamenti (equilibrio esterno). Raggiungere contemporaneamente entrambi gli obiettivi può non essere facile. In un regime di cambi fissi e di libertà di movimento delle merci e dei capitali, gli strumenti a disposizione delle autorità di politica economica sono la politica monetaria e quella fiscale. Le politiche fiscali e monetarie espansive possono generare spinte inflazionistiche e quindi un deterioramento della competitività delle esportazioni e dell’equilibrio esterno. Politiche fiscali e monetarie restrittive invece frenano l’inflazione, ma possono creare disoccupazione. R. Mundell ha enunciato il principio della classificazione efficiente dei mercati, in base al quale è opportuno destinare un dato strumento a realizzare quell’obiettivo per cui lo strumento risulta più idoneo. Nello spirito keynesiano, ritiene che la politica fiscale sia lo strumento più adatto per raggiungere la piena occupazione e che la politica monetaria sia lo strumento più adatto per tenere sotto controllo l’evoluzione dei prezzi. Quindi consiglia di adottare una politica fiscale espansiva perché finalizzata al conseguimento dell’equilibrio interno e una politica monetaria restrittiva perché finalizzata all’equilibrio esterno. Una politica monetaria restrittiva fa aumentare i tassi di interesse a breve termine che hanno il vantaggio di attrarre capitali dall’estero, dando un contributo positivo all’equilibrio esterno. Se si è in regime di cambi flessibili esiste un altro strumento ovvero la svalutazione o rivalutazione del tasso di cambio. In una situazione caratterizzata da piena occupazione e deficit della bilancia dei pagamenti si potranno adottare una svalutazione del tasso di cambio ed una politica fiscale e monetaria restrittiva. In una situazione caratterizzata da disoccupazione e deficit nella bilancia dei pagamenti si potranno adottare una politica fiscale espansiva per raggiungere l’equilibrio interno e una svalutazione del tasso di cambio per rendere più competitive le esportazioni e raggiungere l’equilibrio esterno. La svalutazione in questo caso fa anche aumentare l’occupazione. Se immaginiamo invece una situazione di piena occupazione con surplus della bilancia dei pagamenti, la rivalutazione del tasso di cambio finalizzata all’equilibrio esterno andrebbe accoppiata a politiche fiscali e monetarie lievemente espansive. Infatti la rivalutazione del cambio determina una diminuzione delle esportazioni e quindi occorre una politica che stimoli la domanda interna (Cp + Ip + G).
7. Il controllo dei cambi e la politica valutaria
La collaborazione internazionale fu intensa nel periodo tra il 1870 e il 1914, si affievolì enormemente nel periodo tra le due guerre mondiali quando ciascun Paese, seguendo politiche ispirate all’egoismo nazionale, cercava di avere quel cambio che gli garantisse la piena occupazione all’interno, anche se ciò danneggiava le altre nazioni. Diversi Paesi per espandere le esportazioni svalutavano il cambio e cercavano di ridurre le importazioni mediante misure protezionistiche e altri strumenti definiti di politica valutaria. Questi provvedimenti determinarono un controllo dei cambi da parte dei Governi. Si ha un sistema di cambi controllati quando i cambi non sono determinati dalla domanda e dall’offerta di valuta che si formano liberamente sul mercato, ma sono controllati dai Governi attraverso le misure di politica valutaria. Tra le misure di politica valutaria ricordiamo:
gli interventi della banca centrale sui mercati valutari volti ad acquistare valuta (nazionale) o a venderla per influire sul livello del cambio; questi interventi vengono fatti quasi sempre dalle banche centrali per evitare che i cambi subiscano variazioni troppo brusche;
l’obbligo per gli importatori che richiedono valuta estera di ottenere l’autorizzazione dalla banca centrale che può fare una selezione tra i beni da importare e quindi negare in alcuni casi l’autorizzazione o ritardarla;
le limitazioni delle somme concesse ai cittadini che vogliono recarsi all’estero per turismo o per altri scopi;
il divieto o le limitazioni alle esportazioni di capitali;
il controllo sulle operazioni valutarie delle banche; oggi
le banche italiane non sono tenute a versare alla Banca d’Italia la valuta
estera di cui entrano in possesso, mentre in passato
gli accordi di compensazione valutaria (clearings), accordi solitamente bilaterali che mirano a pareggiare la bilancia commerciale di entrambi eliminando o riducendo al minimo i movimenti di valuta. In ognuno dei due Paesi gli importatori invece di pagare direttamente i loro fornitori devono versare ad una “cassa” speciale, in moneta nazionale, il controvalore delle merci importate; poi da questi fondi la “cassa” preleva le somme necessarie a pagare gli esportatori nazionali per i beni che essi hanno spedito nell’altro Paese, purché gli importatori stranieri abbiano già versato alla propria “cassa” le somme dovute; in tal modo gli esportatori ricevono moneta nazionale in pagamento e non valuta estera, con questo sistema viene evitato ogni trasferimento di valuta tra i due Paesi;
le compensazioni mercantili, ovvero il Governo autorizza l’importazione di una partita di merce solo quando è stata trovata una esportazione di eguale valore (equivale al baratto);
la politica dei cambi multipli, che consiste nel fissare prezzi diversi per le valute estere a seconda dell’uso che l’acquirente ne vuol fare; questa politica è stata adottata da diversi Paesi in via di sviluppo.
Molte di queste misure furono largamente adottate negli anni Trenta e ciò allontanò sempre più la collaborazione tra le nazioni; il protezionismo aumentò e verso la fine del decennio si trasformò in autarchia, ovvero la tendenza di alcuni Paesi a cercare di produrre tutto ciò di cui avevano bisogno in modo da non dover dipendere dalle altre economie e quindi dagli andamenti sfavorevoli di queste.
Cap. XXXI – L’evoluzione delle relazioni monetarie internazionali dopo gli accordi di Bretton Woods
1. Dalla scarsità di dollari in Europa alla fine del sistema di Bretton Woods
La seconda guerra mondiale aveva distrutto quasi completamente gli impianti industriali dei Paesi europei e del Giappone, mentre l’economia americana non aveva subito nessun danno. Allora gli Stati Uniti fecero dei piani per la ricostruzione di queste economie (l’E.R.P. European Recovery Program, o piano Marshall) che prevedevano l’erogazione di forti aiuti in dollari (donazioni). I dollari quindi affluivano in Europa, ma gli europei li utilizzavano per comprare generi alimentari e impianti industriali negli Stati Uniti, poiché era l’unico paese in grado di produrli. Quindi i dollari regalati ai Paesi europei riaffluivano negli Stati Uniti e l’Europa aveva il problema della scarsità dei dollari. In questo periodo la bilancia dei pagamenti americana aveva un deficit assai limitato mentre la bilancia commerciale era in surplus, dato che le esportazioni eccedevano largamente le importazioni. Alla fine degli anni Cinquanta le economie europee e giapponese recuperavano forza e competitività sui mercati internazionali per cui importavano meno dagli Stati Uniti ed esportavano di più verso il resto del mondo. Il surplus della bilancia statunitense quindi diminuiva e il deficit della bilancia dei pagamenti aumentava anche a causa delle spese militari degli Stati Uniti all’estero e degli investimenti delle imprese americane in Europa. Aumentava la quantità di dollari fuori dagli Stati Uniti, posseduti solo in parte dalle banche centrali, infatti grandi quantità di essi venivano utilizzate direttamente dalle banche ordinarie e dalle imprese per le transazioni commerciali e finanziarie tra i Paesi occidentali. Si sviluppa il mercato degli eurodollari, costituito da tutti i dollari che sono fuori degli Stati Uniti e che non sono posseduti dalle banche centrali. Ovviamente non si tratta solo di banconote ma anche di depositi bancari e di titoli a breve termine. Il continuo aumento del disavanzo della bilancia dei pagamenti americana fece sì che il volume dei dollari fuori dal Paese fosse molto maggiore rispetto alla quantità d’oro posseduta da questo. Nella seconda metà degli anni Sessanta era in grado di convertire sulla base della parità vigente non più di 1/5 dell’ammontare totale di dollari fuori dagli Stati Uniti. I Governi europei allora iniziarono a chiedere al Tesoro americano la conversione in oro dei dollari che possedevano, poiché gli Stati Uniti erano l’unico Paese ad avere il privilegio di poter acquistare merci all’estero con la propria moneta senza doverla convertire in oro e quindi potendola emettere in misura illimitata. Gli americani ribattevano che il disavanzo era dovuto alle spese militari e al protezionismo della CEE che gli impediva di esportare beni agricoli ed ostacolava l’ingresso in Europa dei prodotti giapponesi, che si riversavano sul mercato americano. In questo periodo prevalse comunque il principio che la creazione di liquidità internazionale, ovvero mezzi di pagamento per le transazioni internazionali, dovesse essere sganciata dal disavanzo della bilancia dei pagamenti americana; infatti l’ammontare dei dollari disponibili per le transazioni internazionali dipende dall’entità del deficit della bilancia dei pagamenti che a sua volta dipende dalla politica economica seguita negli Stati Uniti. Le politiche fiscali e monetarie negli Stati Uniti però sono finalizzate ad esigenze interne, mentre l’ammontare della liquidità internazionale dovrebbe crescere secondo le esigenze del volume degli scambi mondiali. Tutto ciò è possibile solo se, oltre al dollaro, si crea un nuovo strumento di liquidità internazionale. L’oro non poteva tornare, perché esiste un limite tecnico alla sua estrazione, quindi furono creati nel 1969 i diritti speciali di prelievo (Special Drawing Rights, SDR) cioè crediti multilaterali gestiti dal Fondo Monetario. Sono mezzi di pagamento internazionali, aggiuntivi rispetto alla liquidità esistente, creati dal Fondo Monetario secondo regole di approvazione concordate tra i Paesi membri. Si arriva quindi alla creazione del doppio mercato dell’oro. Fino al 1968 il prezzo dell’oro era di 35 dollari per oncia. Infatti gli Stati Uniti intervenivano sul mercato dell’oro comprando quando il prezzo scendeva e vendendo quando il prezzo saliva al di sopra di questo. In questo modo il prezzo di mercato dell’oro coincideva sempre con quello ufficiale. Negli anni Sessanta però tutti iniziano a perdere fiducia nel dollaro a causa del disavanzo della bilancia dei pagamenti americana al punto che gli Stati Uniti non erano più in grado di convertire i dollari in oro, così molti iniziarono ad acquistare oro cedendo dollari. Per mantenere il prezzo ufficiale dell’oro, gli Stati Uniti dovevano venderlo. I Paesi europei vennero incontro agli Stati Uniti e nel 1968 vi fu un accordo tra i Paesi aderenti al FMI e fu creato il doppio mercato dell’oro: un mercato ufficiale (per fini monetari) riservato alle banche centrali che si impegnavano a scambiare il metallo al prezzo ufficiale; un mercato libero per i privati dove il prezzo sarebbe stato determinato dalla domanda e dall’offerta. Con questo accordo l’oro diventava una componente congelata (non mobilizzabile) delle riserve valutarie. Da allora il prezzo dell’oro sul mercato libero aumentò fino ad arrivare a 190 dollari per oncia nel 1975. Il disavanzo estero americano cresceva, l’inflazione aumentava in quasi tutti i Paesi, diminuiva la fiducia nelle monete e tutti compravano oro. Questa situazione creava molti problemi ai Paesi europei che esponevano le loro economie a improvvisi afflussi o deflussi di dollari, che comportavano rispettivamente inflazione o deflazione. Questi inconvenienti vennero ridotti dall’adozione di un sistema di cambi flessibili: se aumenta la domanda di moneta, la banca centrale non interviene vendendo, così la quantità di moneta in circolazione non aumenta e non si genera inflazione; d’altra parte la rivalutazione del cambio rende meno conveniente l’acquisto di moneta e ne smorza la domanda. Per evitarlo le banche centrali hanno ridotto i loro interventi sui mercati valutari e hanno lasciato fluttuare i cambi delle loro monete rispetto al dollaro al di là del limite stabilito dagli accordi di Bretton Woods. Si passava da un sistema di cambi fissi ad un sistema di cambi flessibili. Dagli inizi degli anni Settanta i prezzi delle merci cominciavano a crescere in modo differente nei vari Paesi e quindi i cambi delle monete non potevano rimanere fissi, inoltre ciò è previsto dalla teoria della parità dei poteri d’acquisto. In questo modo però crollava uno dei pilastri del sistema di Bretton Woods. Nell’agosto del 1971 il Presidente americano Nixon dichiarava la inconvertibilità del dollaro. Le banche centrali non potevano più portare dollari al Tesoro americano e chiederne la conversione in oro; crollava così anche l’altro pilastro di Bretton Woods. Successivamente Nixon svalutava due volte la parità del dollaro rispetto all’oro, portando il prezzo ufficiale del metallo a 42 dollari l’oncia, anche se ciò non aveva molto significato dopo la dichiarazione di inconvertibilità. Infatti i Governi europei sostenevano che l’esistenza di una parità del dollaro rispetto all’oro non aveva più senso e chiedevano agli Stati Uniti che il mercato ufficiale dell’oro venisse abolito, in modo che le banche centrali potessero vendere oro sul mercato libero. Già a partire dal 1973 i Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale si misero su questa strada e con l’accordo raggiungo a Giamaica nel gennaio del 1976, decisero l’abolizione del prezzo ufficiale dell’oro e quindi del doppio mercato dell’oro. Inoltre questo accordo autorizzava il FMI a restituire una parte dell’oro in suo possesso ai Paesi che lo avevano versato come quota di adesione e a vendere un’altra parte dell’oro. In tal modo l’oro perde il suo ruolo di fondamento del sistema monetario internazionale. Nel 1979 il prezzo dell’oro superava i 600 dollari per oncia. Ovviamente il sistema attuale di relazioni monetarie internazionali non si poteva più chiamare sistema a cambio aureo (gold exchange standard) ma diventa un sistema basato esclusivamente sul dollaro (dollar standard) in cui i pagamenti per le operazioni commerciali e finanziarie internazionali vengono fatti in dollari inconvertibili. Già agli inizi degli anni Settanta dunque il sistema di Bretton Woods era finito. Ma il fatto che ogni Paese lasci fluttuare la propria moneta rispetto alle altre non esclude che la sua banca centrale intervenga sul mercato dei cambi per smorzare le fluttuazioni. Ci troviamo quindi in regime di fluttuazione sporca.
2. L’evoluzione recente delle relazioni monetarie internazionali
Il disordine nelle relazioni monetarie internazionali veniva accresciuto dalla crisi energetica (o crisi del petrolio). I Paesi produttori di petrolio nel 1973, avendo raggiunto un accordo di tipo monopolistico, decisero di aumentare enormemente il prezzo. I Paesi industrializzati registrarono forti disavanzi di bilancia dei pagamenti. I Governi dei Paesi industrializzati furono quindi costretti ad adottare politiche monetarie e fiscali restrittive, generando una riduzione degli investimenti, della produzione e dell’occupazione, causando a loro volta una diminuzione della domanda di petrolio e quindi frenarono l’aumento del suo prezzo. Inoltre i Paesi industrializzati, attraverso politiche di restrizione della domanda interna e di aumento della produttività, accrebbero le loro esportazioni, ciò permise di pagare il petrolio importato ai nuovi prezzi, ovvero di pagare la cosiddetta tassa o bolletta petrolifera. Nel 1973 gli Stati Uniti, per poter comprare la stessa quantità di petrolio ai nuovi prezzi, hanno attuato una politica monetaria espansiva, immettendo dollari nel sistema monetario internazionale e attraverso il deficit della bilancia dei pagamenti. Inoltre i Paesi produttori di petrolio depositavano i loro introiti in dollari presso banche occidentali, facendo espandere il mercato dell’eurodollaro. Questi mercati facevano riaffluire questi dollari come prestiti ai Paesi industrializzati, i quali potevano finanziare i disavanzi delle loro bilance dei pagamenti. L’aumento dell’offerta di dollari provoca inflazione negli Stati Uniti e quindi un aumento dei prezzi dei prodotti manufatti. Nell’arco di quattro anni le ragioni di scambio tra prodotti manufatti e prodotti petroliferi (il rapporto tra i prezzi) sono tornate alla situazione precedente il 1973.
A
partire dal 1978 aumenta nuovamente il prezzo del petrolio e i Paesi produttori
cercano di introdurre un meccanismo di indicizzazione, per evitare la
situazione del 1973-1977, agganciando il prezzo del petrolio ai prezzi dei
prodotti manufatti o al saggio di crescita del reddito dei Paesi
industrializzati. Questa ondata di aumento si è esaurita in poco tempo. Negli
Stati Uniti l’amministrazione Reagan perseguiva tre obiettivi di politica
economica interna: ridurre la spesa pubblica, diminuire le imposte, ridurre la
regolamentazione pubblica dell’attività economica privata. Queste misure nel
quadro dell’economia dell’offerta avevano lo scopo di stimolare gli
investimenti privati e la crescita della produzione, riducendo anche
l’inflazione. L’amministrazione Reagan non riuscì a ridurre la spesa pubblica,
avendo aumentato le spese militari e non avendo ridotto in misura adeguata
quelle sociali; inoltre la deregolamentazione non ha prodotto effetti
significativi sugli investimenti. Questi fenomeni e la riduzione delle imposte
hanno portato un’espansione del disavanzo pubblico, ma le autorità statunitensi
si sono rifiutate di finanziare il disavanzo mediante l’espansione dell’offerta
di moneta, mantenendo fermo il principio del divorzio tra Tesoro e Federal Reserve (la banca centrale degli
Stati Uniti), cioè di una politica monetaria restrittiva allo scopo di ridurre
il tasso di inflazione. Ciò ha determinato una forte ascesa dei tassi di
interesse che a loro volta hanno determinato un enorme aumento della domanda di
titoli del Tesoro di quel Paese e in generale di obbligazioni denominate in
dollari. Inoltre l’aumento dei tassi di interesse, che ha colpito anche il
mercato dell’eurodollaro, ha determinato un enorme aggravamento degli oneri
finanziari sia per i Paesi in via di sviluppo sia per i diversi Paesi ad
economia pianificata (es. Ungheria) che erano pesantemente indebitati con il
sistema bancario occidentale. L’effetto negativo dell’aumento di interesse
andava a sommarsi a quello dell’apprezzamento del dollaro, valuta in cui è
denominata la gran parte dell’indebitamento dei Paesi in via di sviluppo. Molti
di questi Paesi si sono trovati a metà degli anni Ottanta sull’orlo del
collasso finanziario; successivamente questa prospettiva si è temporaneamente
allontanata ad opera dell’azione intrapresa da alcune grandi banche, dalle
istituzioni internazionali e dal Governo degli Stati Uniti. L’elevato tasso di
cambio del dollaro rispetto alle altre valute ha determinato una diminuzione
delle esportazioni e un aumento delle importazioni americane, cioè un ampio
disavanzo della bilancia commerciale degli Stati Uniti. Mentre
3. Dal sistema monetario europeo all’euro
I
Paesi della CEE già alla fine degli anni Settanta hanno cercato di porre un
limite alle oscillazioni dei cambi delle loro monete creando il sistema
monetario europeo. Il sistema monetario
europeo (SME) o serpente monetario europeo è entrato in vigore nel 1979 e
mirava a realizzare cambi fra le monete dei Paesi della Comunità Europea non
fissi ma oscillanti entro limiti ristretti e predeterminati. Vi hanno aderito
tutti i Paesi membri della CEE e gradualmente anche i Paesi che di recente sono
entrati a far parte dell’Unione Europea. L’elemento centrale dello SME era lo scudo,
traduzione della parola francese “écu”,
corrispondente alle iniziali dell’espressione inglese “European currency unit” cioè unità monetaria europea. Lo scudo era
una moneta fittizia e aveva un tasso di conversione con ciascuna moneta
nazionale, detto tasso centrale o corso centrale. Questo tasso di conversione
per ciascuna moneta era stato fissato mediante un accordo tra i Governi dei
Paesi della Comunità Europea e poteva essere modificato solo in base ad un
successivo accordo tra i Governi. Successivamente al 1979 ci furono molte
modifiche dei tassi centrali. Poiché ogni moneta aveva un tasso centrale con lo
scudo, attraverso questi si determinavano immediatamente i tassi centrali
bilaterali tra le diverse monete. Se 1 scudo = 1000 lire e 1 scudo = 2 marchi
allora 2 marchi = 1000 lire cioè 1 marco = 500 lire. Ogni Paese poteva far
fluttuare il tasso di cambio della propria moneta rispetto ad ogni altra del
2,25% al di sopra e al di sotto del tasso centrale. Le banche centrali dovevano
intervenire comprando o vendendo moneta tutte le volte che questa si stava
svalutando o rivalutando al di là di questi limiti consentiti. Per alcuni Paesi
era stata prevista in via transitoria una fascia o banda di oscillazione più
ampia, pari al 6%, e di questo regime transitorio hanno usufruito diversi Paesi
come l’Italia, l’Inghilterra,
Parte V: L’intervento pubblico
Cap. XXXII – L’intervento pubblico nel sistema economico: ottimo paretiano, concorrenza pura e fallimenti del mercato
1. Il sistema di libertà naturale di A. Smith
Adam Smith è considerato il fondatore dell’economia politica ma anche il campione del liberismo economico o “laissez faire”, secondo cui lo Stato deve ridurre al minimo i suoi interventi nella vita economica e sociale. Secondo Smith esisteva un ordine naturale che dà i massimi benefici alla collettività, mentre le istituzioni umane sono per loto natura imperfette. Per Smith ogni individuo, perseguendo il proprio interesse, è spinto da una mano invisibile a promuovere un fine che non era stato previsto dalle sue intenzioni, cioè l’interesse della collettività. Se ogni individuo opera in modo da massimizzare il suo utile personale, si realizzerà il bene comune. Gli interventi delle autorità pubbliche nella vita economica sono dannosi e lo Stato deve limitare la sua attività a pochi compiti essenziali come la difesa nazionale, l’amministrazione della giustizia, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche quali ponti, strade, ecc. che non potrebbero essere affidati ad un singolo per mancanza di profitto adeguato. La compravendita per Smith realizza la soddisfazione contemporanea degli interessi del compratore e del venditore; infatti se entrambi non traessero vantaggio dalla compravendita, non la effettuerebbero. Smith condannava l’adozione dei dazi o l’introduzione di altri ostacoli alle importazioni; infatti se un bene può essere acquistato all’estero ad un prezzo inferiore a quello che costerebbe produrlo all’interno del Paese, sarebbe un errore ostacolarne l’importazione, perché in tal modo le risorse interne verrebbero impiegate in modo meno efficiente. Smith condannava anche gli incentivi alla produzione e all’esportazione che finiscono per orientare gli investimenti verso i settori meno remunerativi e, facendo diminuire il profitto individuale, fanno diminuire anche il profitto della collettività, cioè il benessere sociale. Smith condannò tutte le leggi che regolamentavano i salari e gli altri aspetti dell’organizzazione del lavoro perché il Governo non doveva creare nessuno speciale privilegio a vantaggio di nessuna categoria, anzi doveva eliminare ogni posizione monopolistica che si fosse creata sul mercato. La fede di Smith nella mano invisibile era basata sugli aspetti positivi che l’interagire delle forze spontanee avrebbe determinato sull’ampliamento del mercato e sull’espansione della divisione del lavoro con conseguenze benefiche sull’accumulazione e sull’aumento del reddito. Smith riconobbe che le esigenze di natura politica potevano indurre a comportamenti in contrasto con i canoni del liberismo economico: ad esempio definì l’Atto di Cromwell (le Navigation Laws), che riservava i trasporti in esclusiva alla flotta inglese, come il più saggio dei regolamenti commerciali dell’Inghilterra. Pur riconoscendo gli inconvenienti economici di tale atto lo valutò positivamente perché la difesa è più importante della prosperità. Egli ammise in alcuni casi la necessità di una politica di rappresaglie nella sfera doganale allo scopo di ottenere revoca di dazi imposti da altri Paesi e giustificò l’introduzione di dazi per proteggere le industrie nascenti. Ma queste politiche ovviamente rappresentavano provvedimenti eccezionali. Smith vedeva il motore dello sviluppo economico e del progresso non nell’azione del Governo ma nell’iniziativa individuale, stimolata dall’interesse personale, che finisce per realizzare la prosperità pubblica e privata, compensando gli effetti dannosi che derivano dalla stravaganza del Governo e dagli errori della pubblica amministrazione. Quindi l’azione di governo non doveva regolare i processi economici di produzione e distribuzione della ricchezza, ma doveva soltanto creare un quadro istituzionale entro il quale l’attività dei privati avrebbe prodotto il massimo benessere per la collettività, ovvero il progresso della società generato dal sistema della libertà naturale, cioè dalle forze di mercato che il Governo deve lasciare libere di esplicare i loro benefici effetti. Smith si opponeva al pensiero corrente dell’epoca, dei mercantilisti, che promuoveva una politica economica attiva, volta a stimolare le esportazioni mediante sussidi, a ridurre le importazioni mediante l’introduzione di dazi e ad accrescere l’occupazione mediante la realizzazione di opere pubbliche. Il mercato di concorrenza per Smith realizza l’efficienza produttiva, cioè il miglior utilizzo delle risorse e il massimo volume possibile di produzione e la soddisfazione di tutti gli individui. Smith ritiene che il mercato rappresenti la sintesi dell’interesse personale e della giustizia, infatti lo scambio si verifica quando è vantaggioso per entrambi i concorrenti. L’efficienza, intesa come il miglior utilizzo delle risorse, e la giustizia sono concepite come indissolubili e realizzate dal meccanismo del mercato; gli interventi dello Stato, creando inefficienze nell’uso delle risorse, producono anche delle ingiustizie. Dunque le diseguaglianze sono il risultato delle libere scelte degli individui e pertanto non rappresentano delle ingiustizie, quindi non bisogna porsi il problema di correggerle. Infatti Smith considera solo la giustizia commutativa, realizzata dal mercato, e ignora completamente il problema della giustizia distributiva, legato alla questione della posizione di partenza di ciascun soggetto, cioè alle diseguaglianze che finiscono per rappresentare degli ostacoli insormontabili.
2. La concorrenza pura e l’ottimo di Pareto
L’idea di Adam Smith secondo cui l’organizzazione economica basata sulla concorrenza pura realizzi una situazione di massimo vantaggio per tutti gli individui ha percorso tutta la storia del pensiero economico ma è l’economista italiano Vilfredo Pareto (1848–1923) che ne dà una dimostrazione rigorosa. Pareto tentò di definire un obiettivo cui gli interventi di politica economica dovrebbero tendere. Si supponga che la collettività si trovi in una determinata situazione e che, mediante un intervento di politica economica, sia possibile portarla in una nuova situazione in cui nessun individuo risulta danneggiato ma almeno uno è avvantaggiato; secondo Pareto si può affermare che la nuova situazione è migliore della precedente per l’intera collettività, dato che nessuno viene danneggiato mentre alcuni registrano un aumento della propria utilità. Affermare che la nuova situazione è migliore della precedente non comporta un confronto fra le utilità di individui diversi. Pertanto gli interventi di politica economica dovrebbero tendere a portare la collettività in una situazione dalla quale non è possibile allontanarsi senza danneggiare almeno un individuo, a tale posizione è stato dato il nome di ottimo paretiano. L’idea di base della dottrina di Pareto è che le utilità di individui diversi non possano essere confrontate sulla base di un principio scientifico ma solo mediante un giudizio etico e politico. Se ad esempio un provvedimento di politica economica riduce anche solo lievemente il reddito di un individuo ricchissimo e aumenta quello di parecchi individui poveri, secondo Pareto quel provvedimento non migliora il benessere della collettività, o meglio lo si può affermare sulla base di un principio etico ma non di un principio scientifico. Quindi il criterio di Pareto non consente di dire quale sia una giusta distribuzione del reddito ma riguarda solo il volume della produzione e le preferenze dei consumatori. Qualunque intervento di politica economica che fa aumentare il volume del reddito nazionale senza alterarne la distribuzione porta la collettività in una situazione migliore, infatti nella nuova situazione alcuni individui hanno più beni a disposizione rispetto a prima ma nessuno a meno beni di prima. Pertanto l’ottimo paretiano si identifica con una situazione in cui, data una certa distribuzione del reddito nazionale, il volume di quest’ultimo è massimo, cioè non può essere ulteriormente aumentato; in questo caso si ha una situazione di efficienza produttiva (o allocativa) ovvero di ottimo paretiano dal punto di vista della produzione. Potrebbe accadere che alcuni individui che dispongono di certi beni ne preferiscano altri al posto di questi, in questo caso gli individui possono effettuare degli scambi (volontari) di beni tra loro in modo che alcuni si trovino in una posizione migliore senza che nessuno venga a trovarsi in una posizione peggiore. Si realizza una situazione di ottimo paretiano non solo dal punto di vista della produzione ma anche dello scambio. Questo è il concetto pieno di ottimo paretiano. Il criterio di Pareto è comunque debole perché non permette di valutare un provvedimento che danneggia anche una sola persona e non consente di confrontare situazioni caratterizzate da una diversa distribuzione del reddito perché ciò richiederebbe il confronto tra le utilità di diversi individui. Quindi il criterio di Pareto individua una posizione di ottimo relativo e non di ottimo assoluto, perché non esiste un’unica posizione di ottimo ma un numero infinito di tali posizioni, una per ogni diversa distribuzione del reddito nazionale tra gli individui che compongono la collettività.
3. Analisi diagrammatica dell’ottimo paretiano
a) il criterio di ottimo relativo alla produzione
Il
criterio di ottimo paretiano, sia relativo alla produzione sia allo scambio,
possono essere rappresentati graficamente. Il criterio relativo alla produzione,
detto criterio di efficienza produttiva o allocativa, può essere rappresentato
mediante l’uso della frontiera delle
possibilità di produzione. 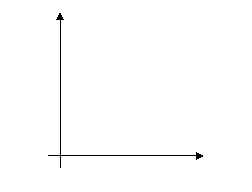
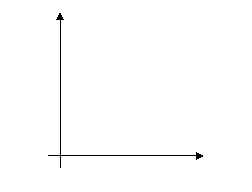
Nel primo diagramma è rappresentata una frontiera concava, nel secondo una lineare.
Consideriamo nel primo diagramma un punto esterno alla frontiera, ad esempio A. Il punto A è un punto impossibile perché con le risorse disponibili nel sistema economico non è possibile produrre le quantità di burro e cannoni corrispondenti alle coordinate del punto A. Tutti i punti situati all’esterno della frontiera sono impossibili. Consideriamo invece un punto situato all’interno della frontiera, ad esempio B. Questo è un punto possibile ma inefficiente. Se infatti ci spostiamo al punto C, anch’esso possibile, vediamo che in C si produce una maggiore quantità di cannoni e la stessa quantità di burro rispetto a B, pertanto con le stesse risorse abbiamo una produzione maggiore; se il sistema economico è nel punto B vuol dire che le risorse sono utilizzate male. Analogamente se ci spostiamo da B a D aumenta la produzione di burro senza che diminuisca quella di cannoni, e se ci spostiamo in qualsiasi punto situato sulla frontiera tra C e D aumentiamo le quantità prodotte di entrambi i beni rispetto a B. Quando è possibile aumentare la produzione di un bene senza diminuire quella di un altro bene il sistema economico è in un punto inefficiente. Invece un punto efficiente è un punto in cui non è possibile aumentare la produzione di un bene senza diminuire quella di un altro bene. Tutti i punti situati all’interno della frontiera sono possibili ma inefficienti; tutti i punti situati sulla frontiera sono possibili ed efficienti. Se ci si sposta da C ad un altro punto lungo la frontiera, ad esempio D, aumenta la quantità di burro ma diminuisce quella di cannoni. Quindi i punti efficienti sono inconfrontabili tra di loro perché per decidere di quale bene aumentare la quantità occorre una scelta di carattere etico o politico. Se il sistema economico è in B si può dire su una base puramente economica che occorre utilizzare meglio le risorse e quindi bisogna andare in C o in D o in un punto della frontiera tra questi due. Ma la scelta tra C e D e gli altri punti può essere fatta solo su una base etica o politica. Ovviamente l’analisi è identica anche per la frontiera lineare.
b) il criterio di ottimo relativo allo scambio
Se
consideriamo due beni, mele e arance, che sono disponibili in quantità date: ad
es.
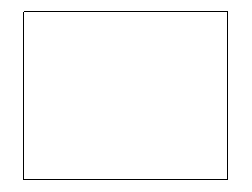
Consideriamo un punto qualunque all’interno del rettangolo, ad esempio D. Le coordinate di D rispetto all’origine OT rappresentano le quantità di arance e di mele possedute da Tizio, mentre rispetto all’origine OC rappresentano le quantità di arance e di mele possedute da Caio. Ogni punto all’interno del rettangolo rappresenta una certa distribuzione dei due beni tra i due individui. Il punto E situato al centro del rettangolo rappresenta una distribuzione perfettamente egualitaria, in cui ognuno dei due individui possiede la metà della quantità disponibile di ciascun bene. I gusti dei due individui sono rappresentati da due mappe di curve di indifferenza, quella di Tizio disegnata rispetto ai lati che hanno origine OT e quella di Caio disegnata rispetto ai lati che hanno origine OC.
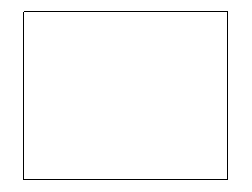
Supponiamo
che il sistema economico sia costituito esclusivamente dai due individui, Tizio
e Caio, e che il reddito nazionale, semplicemente reddito, sia costituito da
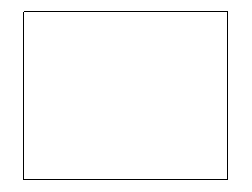
Infatti all’interno di quell’area passano sia curve di indifferenza di Tizio sia curve di Caio. Quelle di tizio sono più alte di α rispetto all’origine OT e quelle di Caio sono più alte di β rispetto all’origine OC. Pertanto in qualunque punto all’interno dell’area aumenta il benessere sia di Tizio che di Caio rispetto al punto A. Lo spostamento da A verso un punto interno all’area racchiusa tra le curve α e β avverrà attraverso scambi volontari tra i due individui: Tizio troverà conveniente vendere mele in cambio di arance perché andrà in una curva superiore e viceversa per Caio. Le coordinate in qualunque punto interno all’area comportano rispetto ad A meno mele e più arance per Tizio e più mele e meno arance per Caio. Consideriamo il punto B del grafico precedente: se Tizio si sposta muovendosi lungo la curva γ, verso destra o verso sinistra, non risulta danneggiato, ma Caio si troverà su di una curva inferiore e quindi sarà danneggiato; di conseguenza Caio non troverà conveniente lo scambio e questo non verrà effettuato. Analogamente se Caio si sposta da B lungo la sua curva β verrà danneggiato Tizio e quindi lo scambio, non essendo conveniente per quest’ultimo, non verrà compiuto. In conclusione qualunque punto di intersezione tra una curva di indifferenza di Tizio e una curva di indifferenza di Caio non è un punto di ottimo paretiano perché da esso ci si può spostare avvantaggiando entrambi gli individui o avvantaggiando uno senza danneggiare l’altro. Invece qualunque punto di contatto (o tangenza) tra una curva di Tizio e una di Caio è un punto di ottimo paretiano, perché da esso non è possibile spostarsi senza danneggiare almeno un individuo. Congiungiamo ora tutti i punti di contatto con una curva, detta curva dei contratti perché è costituita dai punti che vengono raggiunti mediante gli scambi volontari tra i due individui. Infatti gli individui si sposteranno dai punti di intersezione e, mediante gli scambi convenienti per entrambi, raggiungeranno i punti di contatto dai quali non si sposteranno perché in un punto di contatto lo scambio non è più conveniente per entrambi.
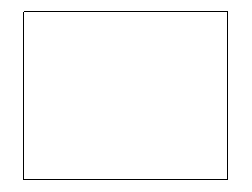
Consideriamo ora i punti M e B: entrambi sono punti di ottimo, però la distribuzione del reddito nei due punti è diversa. In M Tizio è più povero mentre Caio è più ricco. Quanto più un punto di ottimo è situato verso l’origine OT tanto più Tizio è povero e Caio è ricco, e viceversa. Quindi vi è un numero infinito di punti di ottimo paretiano, ciascuno caratterizzato da una diversa distribuzione del reddito tra gli individui. Tali punti sono inconfrontabili tra loro nel senso che il criterio di Pareto non ci consente di affermare quale sia la migliore distribuzione del reddito, ciò può essere fatto solo sulla base di un criterio etico.
4. Il teorema fondamentale dell’economia del benessere
L’analisi economica ha dimostrato che, se nel sistema economico vi sono condizioni di concorrenza pura si realizza automaticamente una situazione di ottimo paretiano. Questo risultato è noto anche come il teorema fondamentale dell’economia del benessere (quella branca dell’economia politica che tenta di definire un concetto di benessere sociale e di individuare i mezzi per raggiungerlo). La concorrenza induce le imprese ad utilizzare (o allocare) i fattori produttivi in modo efficiente e quindi fa ottenere nel sistema economico il massimo volume possibile di produzione di beni e servizi. In concorrenza pura il prezzo di ciascun bene o fattore produttivo, essendo determinato dall’equilibrio tra la domanda e l’offerta di quel bene o fattore, ne misura la scarsità; cioè se il bene è scarso, quindi la domanda supera l’offerta, il suo prezzo sarà alto, mentre se il bene è abbondante, quindi l’offerta supera la domanda, il suo prezzo sarà basso. I prezzi quindi misurano la scarsità relativa delle risorse produttive, ne assicurano l’uso efficiente perché inducono le imprese ad usare con maggiore parsimonia le risorse scarse e con minore parsimonia quelle abbondanti. In tal modo viene evitato ogni spreco di risorse per cui si ottiene il massimo volume possibile di produzione e quindi una situazione di efficienza produttiva (o allocativa) ossia di ottimo paretiano dal punto di vista della produzione. Tali considerazioni però sono valide solo in un regime di concorrenza pura perché soltanto in questo caso i prezzi delle risorse produttive riflettono la loro scarsità. Inoltre la concorrenza fa sì che la composizione del prodotto nazionale sia determinata dalle preferenze dei consumatori e quindi realizza pienamente l’ottimo paretiano; per le imprese è indifferente quale prodotto produrre quindi si adeguano agli interessi dei consumatori. Infine mediante scambi volontari gli individui raggiungono una posizione di ottimo paretiano.
5. I fallimenti del mercato: 1) l’esistenza di monopoli
a) il fenomeno della concentrazione produttiva
Alcuni economisti, sulla base di un’economia in concorrenza pura che realizza una situazione di ottimo paretiano, hanno riproposto la visione secondo cui lo Stato deve limitarsi a compiere gli interventi essenziali nella vita economica descritti da A. Smith: garantire il quadro concorrenziale evitando la formazione di monopoli; assicurare alcuni servizi essenziali come la difesa esterna, l’ordine pubblico e l’amministrazione della giustizia; modificare eventualmente l’assetto distributivo. Numerosi studiosi hanno messo in evidenza come vi sono delle situazioni in cui l’operare delle forze di mercato non determina la realizzazione del massimo volume di produzione perché è necessario un intervento pubblico; queste situazioni prendono il nome di fallimenti del mercato. Le principali tipologie di fallimenti di mercato sono: l’esistenza di situazioni di monopolio o comunque di insufficiente concorrenza; le esternalità; i beni pubblici; la carenza di informazione; l’incompletezza dei mercati; la disoccupazione; alcuni problemi legati alla distribuzione del reddito o a comportamenti irrazionali degli individui.
Esaminiamo le situazioni in cui vi è scarsa concorrenza. La concorrenza perfetta si può avere solo in presenza di condizioni che difficilmente si verificano nella realtà dei mercati, tra queste la più importante è l’esistenza di un numero elevato di imprese produttrici, tutte di dimensioni limitate, e di acquirenti di un dato bene, in modo che nessuno possa influenzarne il prezzo. Esiste inoltre la possibilità concreta per qualunque nuova impresa di entrare nel mercato perché, essendo tutte le imprese di piccole dimensioni, per entrare nel settore non occorrono né grandi capitali né conoscenze tecniche particolari. Ma perché questa situazione possa rimanere nel tempo è necessario che le imprese restino di dimensioni limitate, ma già dalla seconda metà del secolo scorso si è sviluppato un processo di crescita e di concentrazione tra le imprese in numerosi settori. Dovuto soprattutto alle economie interne o di scala, cioè al fenomeno per cui un’impresa, quando espande la produzione, è in grado di ridurre i costi marginali e medi, realizzando una maggiore efficienza nell’organizzazione e una più ampia divisione del lavoro, introducendo tecnologie più avanzate, cose che una piccola impresa non può fare. Oggi in numerosi settori prevalgono condizioni di monopolio o oligopolio e, quando un bene è prodotto solo da poche grandi imprese, queste possono accordarsi tra di loro in modo da influenzarne il prezzo di vendita. Quindi l’esistenza dei monopoli danneggia i consumatori e dunque la collettività, mentre la concorrenza realizza il massimo benessere sociale. Numerosi economisti, però, hanno rilevato che la moderna produzione di massa spesso richiede stabilimenti di grandi dimensioni e attrezzature e macchinari tecnologicamente avanzati, che possono essere posseduti solo da grandi imprese. Questo ha determinato il processo di concentrazione economica e finanziaria con la conseguente formazione di grandi imprese oligopolistiche in numerosi settori, che ha consentito però di ridurre i costi di produzione. La grande impresa inoltre è un’entità complessa, non un’entità individuale come invece ipotizza la teoria tradizionale, è un’organizzazione cioè un complesso di individui e di centri di potere, i quali perseguono ciascuno un proprio obiettivo. La grande impresa quindi non è un soggetto ma un’organizzazione complessa che non è programmata e controllata pienamente dai massimi dirigenti, anche se sono questi a prendere le decisioni ultime, tali decisioni dipendono dalle informazioni che essi ricevono e dalle azioni e dai comportamenti di numerosi soggetti. I neoistituzionalisti R.H. Coase e J. Williamson hanno sottolineato che l’impresa come organizzazione complessa, strutturata gerarchicamente, nasce proprio perché riesce a ridurre i costi rispetto alla piccola impresa del mercato concorrenziale. Se è così, lo stesso principio paretiano secondo cui un mercato concorrenziale, costituito da un grandissimo numero di agenti economici determina l’ottima allocazione delle risorse produttive non risulta più vero. Sul ruolo dell’intervento pubblico c’è stata un’evoluzione del pensiero: inizialmente in diversi Paesi industrializzati si ritiene sia necessario emanare un’apposita legislazione antimonopolistica per evitare la formazione di monopoli e oligopoli. Il primo esempio è lo “Sherman Act” promulgato negli Stati Uniti nel 1890. Successivamente si riconosce che il processo di concentrazione produce dei vantaggi; la crescita delle imprese genera economie di scala e quindi abbassa i costi però dà all’impresa un potere di mercato. Quindi bisogna lasciar esistere le grandi imprese per avere i vantaggi derivanti dalla riduzione dei costi e dall’innovazione tecnologica , però bisogna che tali vantaggi vadano a beneficio dei consumatori cioè della collettività. Lo Stato dovrebbe almeno controllare i prezzi delle imprese monopolistiche, impedendo loro di fissare prezzi di vendita dei beni troppo elevati. La legislazione antimonopolistica in questa visione consiste in sostanza nella disciplina delle concentrazioni, che deve adattare le esigenze di conservazione dei benefici del mercato concorrenziale con le esigenze di riduzione dei costi delle imprese.
b) I costi di transazione e il mercato di concorrenza pura
Un altro fenomeno che rende inefficiente la piccola impresa del mercato di concorrenza pura e determina lo sviluppo della grande impresa è: i costi di transazione. Questi nascono da due fenomeni noti come razionalità limitata e opportunismo. Gli agenti economici (imprese e consumatori) agiscono razionalmente perché hanno una perfetta informazione sul mercato. In realtà la loro razionalità è limitata perché essi incontrano molte difficoltà nel raccogliere le informazioni che sono complesse e nel formulare e risolvere i problemi facendo uso di tali informazioni. Per ognuno di questi problemi deve individuare la soluzione più efficiente, cioè la meno cara e per fare ciò ha bisogno di numerose informazioni che è difficile e costoso procurarsi. Una grande impresa può riuscire a raccogliere ed elaborare le informazioni meglio di una piccola impresa. Il fenomeno dell’opportunismo consiste nel fatto che a volte l’agente economico persegue il proprio interesse maliziosamente e ciò può non portare il sistema economico in una posizione di ottimo. Per una grande impresa è più facile raccogliere informazioni e capire che la controparte si comporta maliziosamente mostrando di saper fare il lavoro meglio di un’altra, piuttosto che una piccola impresa. Più in generale i fenomeni della razionalità limitata e dell’opportunismo generano costi di transazione, prevalentemente costi di informazione. Questi possono essere più o meno alti e riguardano soprattutto la raccolta delle informazioni necessarie per individuare la controparte adeguata in un contratto. Quando vi sono notevoli costi di transazione, un sistema di scambi decentrati e istantanei, cioè un mercato di concorrenza, non produce risultati efficienti. Infatti l’impresa come organizzazione complessa, strutturata gerarchicamente, nasce proprio perché riesce a ridurre i costi di transazione rispetto all’impresa atomistica dei mercati concorrenziali. La natura e l’entità dei costi di transizione determinano il sistema più efficiente di allocazione delle risorse dal punto di vista della collettività. Nelle situazioni in cui tali costi sono nulli o molto bassi, il sistema più efficiente è un meccanismo decentrato di scambi come quello della concorrenza atomistica. Quando invece i costi sono elevati, sono preferibili formule organizzative diverse, che comportano diversi gradi di accordo e di collaborazione tra le imprese, come la cooperazione, i consorzi, ecc. Anche l’integrazione verticale tra produttore e distributore, la creazione di vincoli a lungo termine tra le imprese, i contratti di esclusiva e perfino i cartelli classici (gli accordi tra alcune grandi imprese per svolgere una comune politica di mercato) possono essere degli strumenti di riduzione dei costi di transazione. La cooperazione tra le imprese così come la cooperazione all’interno dell’impresa possono condurre a risultati più efficienti di quelli in concorrenza.
c) il dibattito sull’utilità sociale di una legislazione antimonopolistica
Si
deve rivedere l’affermazione secondo cui il solo meccanismo della concorrenza
porta il sistema economico in una situazione di ottimo paretiano. Una
legislazione antimonopolistica non può partire dalla premessa secondo cui la
concorrenza atomistica è il sistema più efficiente dal punto di vista della
collettività, anzi il sistema migliore potrebbe essere uno basato su una certa
combinazione di cooperazione e concorrenza. Alcuni economisti sostengono che i
soggetti capaci di individuare quale sia la combinazione migliore di
cooperazione e concorrenza sono le imprese. Occorre quindi lasciarle libere di
organizzarsi come meglio ritengono perché individueranno le formule
organizzative più efficienti e l’efficienza delle singole imprese comporterà
l’efficienza del sistema economico nel suo complesso. Le imprese che riducono i
costi prevarranno sulle altre e ciò determinerà un aumento del benessere
sociale, le imprese inefficienti falliranno e saranno, quindi, espulse dal
mercato, questo si rivela come il migliore meccanismo di selezione. I
sostenitori di questa tesi ritengono che la legislazione anti-monopolistica
limita la libertà di azione delle imprese e si traduce in uno strumento di
alterazione della concorrenza e di protezione delle imprese più deboli dato che
il mercato seleziona le imprese meglio di quanto possa fare un qualsiasi organo
amministrativo o giurisdizionale. Anche le barriere all’ingresso nei mercati
oligopolistici per le imprese che volessero accedervi non sono in realtà così
elevate e in ogni caso non hanno efficacia nel lungo periodo. Se le imprese che
operano in un settore percepiscono degli extraprofitti, ciò attrarrà altre
imprese nel settore che finiranno per entrarvi. Un’impresa che volesse entrare
in un settore in cui si realizzano elevati profitti troverà sempre, attraverso
l’emissione di azioni o di obbligazioni o il ricorso al credito bancario, la
quantità di capitali necessaria. Monopoli e cartelli non potranno resistere a lungo.
Alcuni autori sostengono che il potere monopolistico di un’impresa non può
durare a lungo e quindi non rappresenta un problema sociale rilevante. I
sostenitori della tesi opposta affermano che non è detto che le imprese
scelgano la formula organizzativa più efficiente dal punto di vista della
collettività, anzi le imprese si potrebbero organizzare in modo da ridurre al
minimo la concorrenza, consolidando le proprie posizioni di potere
monopolistico sul mercato; inoltre le barriere tecnologiche e finanziarie nella
realtà sono significative. Secondo alcuni autori il valore da difendere non è
la concorrenza ma il “sistema di libertà naturale” di Adam Smith, cioè la
libertà di azione nella sfera economica. Pertanto la legislazione dovrebbe
assicurare la libertà di iniziativa economica, o meglio la libertà di accesso
ai mercati, e questa libertà può essere limitata solo se danneggia la
collettività o svantaggia i compratori. Attività come l’uso della violenza e
della frode, il boicottaggio, diverse forme di pratiche predatorie e
discriminatorie possono essere vietate dalla legge. E’ difficile però
giustificare la maggior parte delle norme che si trovano nelle legislazioni
antimonopolistiche dei Paesi industrializzati. Ad es. le norme che vietano la
creazione di cartelli e la collusione tra le imprese consistono nell’imporre
agli operatori economici l’obbligo della rivalità. Questi divieti sono
difficili da giustificare se si vuole garantire la libertà d’azione della sfera
economica, infatti la libertà di iniziativa economica comporta anche la libertà
di cooperare tra imprese. Gli autori favorevoli al liberismo economico temono
che le legislazioni antimonopolistiche finiscano per attribuire poteri
discrezionali a qualche organo di carattere amministrativo o giurisdizionale.
Poiché non è possibile vietare tutti gli accordi, le acquisizioni e le fusioni
e in generale i processi che portano alla concentrazione e all’ingrandimento
delle imprese, si finirà per ammetterne alcuni che siano riconosciuti
vantaggiosi per la collettività. Per legge si prevederanno dei criteri di
ammissibilità ma poi l’applicazione ai casi concreti sarà domandata ad un
organo di carattere amministrativo o giurisdizionale. Ad es. il Trattato di
Roma, che nel 1957 istituì
d) la legislazione antimonopolistica dell’Italia
Una legge a tutela della concorrenza è stata emanata in Italia solo nel 1990, con notevole ritardo rispetto ai principali Paesi industrializzati. Vieta le intese tra imprese che limitano la libertà di concorrenza, l’abuso di posizione dominante da parte di un’impresa all’interno del mercato nazionale e, in determinati casi, la concentrazione di imprese. La legge ha inoltre istituito l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il compito di verificare l’esistenza di infrazioni a tali divieti. Essa può agire sulla base degli elementi in suo possesso e di quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse; ha inoltre il potere di procedere, d’ufficio o su richiesta del Ministro dell’Industria, ad indagini conoscitive di natura generale riguardanti quei settori economici in cui da alcune circostanze si potrebbe presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata; può indicare i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato; qualora lo ritenga opportuno, può esprimere un parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può rendere pubbliche le proprie opinioni; inoltre le viene attribuita la facoltà di esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi attinenti alla concorrenza e al mercato. La filosofia di questa legge ha l’obiettivo di evitare che si determinino abusi di posizione dominante da parte delle grandi imprese e non quello di combattere qualsiasi forma di concentrazione e di monopolio. Infatti la legge italiana prevede la possibilità di adattare l’applicazione della normativa antimonopolistica alle caratteristiche di alcuni settori “critici” per i quali prevalgono obiettivi di grande rilevanza sociale, ovvero stabilisce che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Attività produttive, può formulare i criteri sulla base dei quali l’Autorità può autorizzare, in via eccezionale e per rilevanti interessi generali dell’economia nazionale nell’ambito dell’integrazione europea, operazioni di concentrazione che altrimenti sarebbero vietate (sempreché non comportino una riduzione della concorrenza superiore a quella giustificata e che venga stabilito un termine per il ripristino delle condizioni di piena concorrenza).
6. I fallimenti del mercato: 2) le esternalità
a) le esternalità e l’intervento pubblico
Uno dei casi principali di fallimento del mercato è costituito dal fenomeno delle esternalità o effetti esterni. Il primo a compiere un’analisi sistematica del fenomeno fu A.C. Pigou (1877 – 1959) e consideriamo i suoi esempi:
Esempio 1: una fabbrica di prodotti industriali che con i suoi residui inquina l’aria e l’acqua di un fiume non considera tali danni tra i suoi costi, ma questi danni rappresentano dei costi per la collettività; in questo caso i costi sociali sono maggiori dei costi privati e l’investimento che consiste nella creazione di quella fabbrica genera una diseconomia esterna, cioè esterna alla fabbrica ma interna al sistema economico, ovvero un’esternalità negativa.
Esempio 2: la costruzione di una ferrovia in un’area poco sviluppata, che va dall’interno alla costa, dà un profitto assai basso all’impresa che la costruisce perché il traffico è scarso, però incentiva la nascita di aziende industriali all’interno rendendo possibile il trasporto dei prodotti fino alla costa; in questo caso il vantaggio sociale derivante dalla costruzione della ferrovia è maggiore del vantaggio privato immediato e l’investimento che consiste nella costruzione della ferrovia genera un’economia esterna cioè un’esternalità positiva.
In queste situazioni Pigou trova che sia necessario l’intervento dello Stato che nel primo esempio penalizzi l’impresa mediante un’imposta, addossandole così i costi sociali, e nel secondo incentivi l’impresa con un sussidio che le riduca i costi di costruzione della ferrovia. Concentriamoci sul primo caso: l’introduzione di un’imposta che addossi i costi sociali all’impresa inquinante induce questa ad aumentare il prezzo di vendita del bene che produce e ciò determinerà una diminuzione della domanda e della produzione del bene. L’equilibrio dell’impresa comporterà un prezzo più alto e un livello di produzione più basso, ma ciò sarà efficiente dal punto di vista della collettività perché il nuovo equilibrio è determinato tenendo conto del costo sociale. Lo Stato poi potrà destinare il gettito dell’imposta a riparare il danno derivante dall’inquinamento. Un’altra possibile soluzione è che lo Stato venda all’asta alle imprese l’autorizzazione a produrre la diseconomia, in tal modo lo Stato percepisce una somma che può essere equivalente al costo sociale dell’inquinamento, lasciando che sia la concorrenza tra le imprese a determinarla anziché fissarla direttamente. Questo metodo dà al Governo il vantaggio di poter fissare la quantità di inquinamento desiderata al momento della vendita, mentre con l’introduzione dell’imposta il Governo non sa a priori quale sarà esattamente il livello di produzione di equilibrio delle imprese e quindi la quantità di inquinamento che creeranno.
b) la critica di Coase e la possibilità di un accordo contrattuale
Alcuni economisti hanno sostenuto che l’intervento pubblico non è lo strumento adatto per risolvere i problemi delle esternalità, infatti le misure correttive degli effetti esterni comportano a loro volta dei costi, perché determinano una crescita della burocrazia e un’interferenza eccessiva nelle decisioni delle imprese, quindi ostacolano l’iniziativa privata. R.H. Coase sostiene che bisogna considerare sempre anche il costo dei provvedimenti volti a correggere gli effetti esterni, infatti il problema dovrebbe essere risolto mediante accordi tra le parti in conflitto, ad esempio l’impresa che inquina e i soggetti danneggiati dall’inquinamento. Queste potrebbero sempre individuare un prezzo per il risarcimento del danno, che dia loro reciproca soddisfazione, rendendo superfluo l’intervento pubblico e i connessi costi burocratici. Porre ostacoli ad un accordo spontaneo di questo tipo significherebbe interferire nei diritti di proprietà degli individui e quindi indebolirli. Si parla quindi non di fallimenti del mercato ma di fallimento dell’intervento pubblico. Altri studiosi affermano che in ben pochi casi gli accordi spontanei potrebbero risolvere il problema delle esternalità, perché i costi di transazione, cioè i costi degli accordi, sarebbero così alti per i singoli che difficilmente essi verrebbero realizzati e quindi risulta sempre necessario l’intervento pubblico. Se il problema riguarda poche persone, la soluzione contrattuale è possibile ed anche efficiente, ma quando il problema riguarda molte persone, la soluzione contrattuale è assai costosa e quindi inefficiente se non addirittura impossibile. Se consideriamo l’esempio dei proprietari di automobili che inquinano i cittadini, gli edifici, i monumenti, un accordo di tipo contrattuale sarebbe praticamente impossibile; invece l’intervento pubblico potrebbe consistere nel tassare gli automobilisti che inquinano e con il gettito di tale imposte lo Stato potrebbe riparare i danni causati dall’inquinamento. Un altro strumento potrebbe consistere nell’imporre per legge l’uso delle marmitte catalitiche, di carburanti meno inquinanti, ecc. e questa è una soluzione basata sulla regolamentazione. Coloro che sono contrari all’intervento pubblico rilevano che, se i diritti di proprietà fossero ben definiti, molti dei casi non si verificherebbero. Facciamo un esempio: la ricerca scientifica è vantaggiosa per il sistema produttivo di un Paese ma l’impresa privata spesso non ha un incentivo sufficiente ad investire perché non riesce ad avere una remunerazione adeguata e in molti casi nemmeno a coprire i costi; supponiamo che un’impresa farmaceutica dopo anni di ricerche e spese inventi un nuovo farmaco, per poter recuperare tali spese dovrebbero venderlo ad un certo prezzo per un dato numero di anni; però altre imprese possono appropriarsi gratuitamente dei risultati della ricerca e copiare il farmaco e venderlo ad un prezzo assai più basso dato che devono sostenerne solo i costi di produzione e non il costo di invenzione. Alcuni economisti rilevano che, attraverso un’adeguata legislazione sui diritti di proprietà intellettuale, si può stabilire che l’impresa che ha inventato il farmaco lo brevetti; occorre quindi che esista un ufficio brevetti che attesti che la proprietà intellettuale del farmaco è di questa impresa. La legge può stabilire che per un certo numero di anni nessun’altra impresa possa produrlo a meno che non acquisti il diritto di farlo dall’impresa che ne ha la proprietà intellettuale, cioè il brevetto. Una legislazione adeguata sui brevetti quindi può rendere conveniente per le imprese private effettuare attività di ricerca. L’esempio precedente mostra l’estrema difficoltà di compiere l’attribuzione dei diritti di proprietà nel caso dell’inquinamento atmosferico. In altri casi invece l’attribuzione dei diritti di proprietà ai privati è possibile, ma non attuabile per ragioni di natura etica. Ad esempio, se un’impresa ha addestrato dei lavoratori, quindi ha affrontato una spesa, e questi lavoratori dopo un certo tempo lo abbandonano e si fanno assumere da un’altra impresa concorrente. Questo produce certamente una diseconomia esterna per la prima impresa, ma correggerla mediante l’attribuzione a quest’ultima di un diritto di proprietà sui lavoratori sarebbe eticamente inaccettabile. Allora le imprese non effettueranno spese per la formazione professionale perché temono di non avere un profitto adeguato, quindi è necessario l’intervento pubblico che dia un sussidio alle imprese per stimolarle a investire nella formazione professionale. Si potrebbe pensare che sia possibile inserire nei contratti di lavoro una clausola secondo cui il lavoratore che è stato addestrato da un’impresa, se decide di licenziarsi per andare a lavorare in un’altra azienda, debba indennizzare la prima ripagandole le spese dell’addestramento, ma anche tale soluzione crea problemi etici. La legge potrebbe stabilire che l’impresa B che assume il lavoratore già addestrato dall’impresa A, indennizzi quest’ultima ma anche questa soluzione è discutibile.
c) le esternalità e lo strumento della regolamentazione
Un altro possibile strumento per correggere il fenomeno delle esternalità è rappresentato dalla regolamentazione. Questa soluzione è molto adottata in pratica quando si vogliono stabilire dei livelli massimi, non superabili, per l’inquinamento e quindi si vietano delle attività che generano un livello di inquinamento superiore. Un esempio riguarda l’uso di risorse comuni scarse: la circolazione delle automobili nei centri storici potrebbe portare ad un livello di paralisi totale del traffico, per cui i cittadini potrebbero mettersi d’accordo per limitare la circolazione nel centro storico mediante una regolamentazione attuata dallo Stato o dal Comune. Infatti ogni automobile che circola nel centro storico riduce lo spazio per le altre, genera cioè una diseconomia esterna per le altre, che origina dal fatto che il centro storico è un bene comune scarso. Le autorità potrebbero adottare la soluzione dell’imposizione fiscale, facendo pagare a tutte le automobili un pedaggio per accedere al centro sufficientemente alto da scoraggiare molti automobilisti; in tal modo però solo i ricchi potrebbero accedervi e ciò avrebbe delle implicazioni negative sulla distribuzione del reddito.
d) le economie esterne
Oltre alle diseconomie esterne esistono anche le economie esterne. Le imprese private non effettueranno numerosi investimenti che producono un vantaggio sociale rilevante, perché questi non sono sufficientemente remunerativi per il privato. Come l’esempio della costruzione di una ferrovia o di una diga. Magari la diga porterebbe molti vantaggi ma un privato potrebbe non avere convenienza a costruirla, ma poiché questa produce per la collettività benefici maggiori di quelli del privato investitore, è opportuno un intervento dello Stato volto a sussidiare l’impresa affinché costruisca la diga. Altri autori infine ritengono che lo Stato debba produrre direttamente quei beni che generano economie esterne, come ad esempio le infrastrutture.
7. I fallimenti del mercato: 3) i beni pubblici
Il concetto di bene pubblico fu già intuito da D. Hume (1711-1776) e A. Smith. Entrambi sostenevano che gli individui non si metteranno mai d’accordo per costruire opere di interesse collettivo o per organizzare la difesa nazionale, perché è troppo costoso per il singolo e tali accordi sarebbero in ogni caso difficili, dato l’elevato numero di partecipanti agli stessi. Però tali opere ed attività danno beneficio a tutti e quindi è necessario che le realizzi il Governo. I beni pubblici hanno due caratteristiche fondamentali: la fruizione del servizio del bene pubblico da parte di un individuo addizionale non genera alcun costo; è difficile o impossibile escludere gli individui dalla fruizione del servizio. Gli esempi più frequenti sono quelli della difesa nazionale e del faro. Organizzare la difesa militare di un Paese con un tot di abitanti ha lo stesso costo se si aggiunge un abitante in più; inoltre se riuscisse ad evitare un attacco, tutti i cittadini ne beneficeranno perciò non è possibile escludere un singolo cittadino da tali benefici. Analogamente tutte le navi che passano a largo possono vedere la luce del faro su di una scogliera ed evitare di naufragare sugli scogli, perciò una nave in più non comporta un costo addizionale; ovviamente non si possono escludere dalla fruizione di tali servizi chi ne usufruisce e si rifiuta di pagarli. Nessun privato avrà la convenienza a produrre questi tipi di beni ed è quindi necessario un intervento dello Stato per produrli. Il concetto di bene pubblico si contrappone a quello di bene privato, che non ha quelle due caratteristiche, infatti i beni privati vengono prodotti dalle imprese che hanno convenienza a farlo.
8. I fallimenti del mercato: 4) la carenza di informazione e l’incompletezza dei mercati
Esistono diverse situazioni in cui non vi è una perfetta informazione sul mercato per tutti i soggetti o il livello di informazione è molto maggiore per il venditore dei beni e servizi che non per il compratore. Colui che ha minori informazioni, cioè il cliente, deve fidarsi cioè non sa come scegliere l’altro contraente (ad es. un medico). In questi casi di contratti con informazione incompleta e asimmetrica, l’azione individuale non consente al singolo di raggiungere una posizione di ottimo, è necessario o un accordo generale o un intervento dello Stato che, mediante una legge, ancori l’azione individuale ad un codice morale di comportamento più ricco del codice di moralità mercantile di cui parlava A. Smith. Occorre un codice kantiano di etica professionale, altrimenti il perseguimento dell’utile individuale da parte di ciascun soggetto non porta la collettività ad una posizione di ottimo paretiano. Il problema potrebbe essere risolto mediante una regolamentazione pubblica, ovvero lo Stato dovrebbe distribuire l’informazione gratuitamente a tutti i cittadini, dato che il mercato privato spesso non produce un’offerta di informazione adeguata, perché questa ha la natura di bene pubblico. Infine vi sono situazioni di incompletezza dei mercati, quando i mercati privati non offrono un bene o un servizio nonostante che il suo costo di produzione sia inferiore al prezzo che i consumatori sarebbero disposti a pagare. Ad esempio per i mercati assicurativi e finanziari, per cui è necessario un intervento pubblico. Il mercato privato non offre polizze di assicurazione per molti importanti rischi affrontati dagli individui, nonostante che sia fortemente sviluppato negli ultimi anni. Un altro esempio di incompletezza dei mercati è rappresentato dall’inesistenza di mercati complementari. Per sviluppare una città ad esempio occorre un coordinamento tra le imprese che realizzano le reti fognarie, le reti idriche, ecc. Solo l’autorità pubblica può svolgere tale funzione di coordinamento, che non potrebbe essere realizzata dal mercato.
9. Fallimenti del mercato e fallimenti dell’intervento pubblico
Molti studiosi hanno concluso che l’intervento pubblico è necessario e inoltre non può consistere solo nell’introduzione di imposte o di sussidi o nella regolamentazione. L’intervento pubblico infatti può consistere anche nella creazione di enti statali che producono e gestiscono beni pubblici e nella determinazione di criteri per distribuire tra i cittadini l’onere del pagamento di tale produzione e gestione, nell’emanazione di leggi che obblighino le imprese a dare informazioni precise a tutela del consumatore, ecc. Non è certo che l’intervento pubblico sia in grado di realizzare a costi ragionevoli ciò che il meccanismo del mercato non riesce ad ottenere, infatti pure i Governi sono organizzazioni intrinsecamente imperfette. Anche dell’attività di governo va analizzata l’efficienza, studiando le preferenze dei soggetti, i processi di formazione delle decisioni degli organi, dei politici, ecc. Gli enti pubblici, creati per raggiungere obiettivi di interesse generale, tendono a perseguire obiettivi interni, che riguardano i costi e benefici dell’ente stesso prima ancora che l’obiettivo politico. I politici tenderanno ad assumere numerosi dipendenti in questi enti, a stipendi elevati, ecc. Inoltre il Governo è costretto ad operare, come i privati, attraverso i mercati esistenti, che sono imperfetti e incompleti; dovrebbe cercare di renderli perfetti e completi, fornendo a tutti i cittadini la massima informazione possibile, ma ciò non è facile e può comportare costi elevati. L’intervento statale non deve consistere nella produzione e gestione diretta di beni e servizi pubblici, ma piuttosto nell’affidamento di tale produzione e gestione a imprese private operanti in regime di concorrenza, da cui lo Stato dovrebbe acquistare tali beni e servizi per fornirli ai cittadini. Altri autori rilevano che è vero che gli enti pubblici tendono ad esercitare influenza sulle decisioni politiche e ciò può creare costi per la collettività, cioè costi sociali, chiamati in questo caso costi di influenza. Ma anche le grandi imprese private e le loro associazioni tendono ad esercitare analoghe influenze, acquistando un potere monopolistico e privilegi vari, quindi producono anch’essi costi di influenza. In entrambi i casi occorre confrontare questi ultimi con i benefici sociali. Quando i benefici sociali derivanti dalla creazione di un ente pubblico sono superiori ai costi di influenza che lo stesso può produrre, tale creazione è socialmente utile. Diversi autori però chiedono che l’area entro cui può svolgersi l’intervento pubblico sia delimitata dalle leggi e anche da vincoli costituzionali.
10. Le imprese pubbliche e le privatizzazioni
a) intervento pubblico e produzione pubblica di beni e servizi
In diversi casi di fallimento del mercato è necessario un intervento pubblico, ma non che questo debba consistere nel fatto che lo Stato si faccia esso stesso imprenditore producendo dei beni; anche nel caso di beni pubblici questi potrebbero essere prodotti da imprese private su commessa dello Stato. In molti Paesi però lo Stato produce diversi beni e servizi attraverso enti pubblici o imprese pubbliche appositamente istituiti a tale scopo. Lo Stato in molti Paesi gestisce direttamente l’istruzione, la sanità, l’amministrazione delle giustizia, i trasporti, ecc. Esistono però anche scuole private, cliniche private, ecc. Si discute molto se siano più efficienti le imprese pubbliche o quelle private ed è difficile dare una risposta univoca, valida in tutte le situazioni storiche. Diverse indagini mostrano che le imprese pubbliche registrano costi più elevati delle imprese private e più bassa produttività, ma ciò non è sempre vero. Vi sono settori in cui la produzione richiede grandi risorse finanziarie, da impiegare anche a fini di ricerca e sviluppo, ma tali massicci investimenti comportano anche rischi, pertanto i privati difficilmente si impegnano in tali produzioni, specie in Paesi di dimensioni limitate. In diverse nazioni industrie strategiche che comportavano massicci investimenti si sono sviluppate per iniziativa dello Stato, in quanto difficilmente i privati sarebbero in grado di fornire i giusti capitali o attrezzature. Dunque non sempre le imprese pubbliche producono risultati peggiori delle imprese private. Alcuni autori sostengono che la competizione tra imprese private in alcuni settori può portare anche ad investimenti eccessivi e che i costi di informazione sono così alti che è auspicabile un intervento pubblico. Altri economisti invece rilevano che le grandi imprese private già attuano tale orientamento o programmazione mediante accordi e che lo Stato non sempre riesce a svolgere bene questa funzione. Le imprese pubbliche hanno due caratteristiche rispetto a quelle private: non possono fallire; spesso agiscono in situazione di monopolio o per lo meno sono protette dalla concorrenza. Il rischio del fallimento induce gli amministratori delle imprese private sicuramente ad una gestione più oculata ed efficiente, mentre le imprese pubbliche spesso operano in perdita anche per periodi molto lunghi, inoltre oppongono minore resistenza alle richieste di aumenti salariali da parte dei sindacati. Gran parte della Pubblica Amministrazione svolge la sua attività senza essere soggetta alla concorrenza, per cui gli individui non possono scegliere tra il servizio pubblico e quello fornito da un altro soggetto. Inoltre quando non è possibile l’abbandono del produttore da parte del cliente, rimane solo la possibilità della protesta, che però non può essere un metodo efficace per far funzionare meglio il settore pubblico. Infatti sarebbe auspicabile che lo Stato non gestisca mai un servizio in situazione di monopolio, di modo che i cittadini possano operare un confronto e scegliere tra diverse alternative. Negli enti pubblici di solito c’è la sicurezza del posto di lavoro, in genere si tende a costituire una burocrazia indipendente dal potere politico e quindi le si garantisce l’inamovibilità. Le retribuzioni nei posti più elevati nel settore pubblico però sono di norma più basse che nel settore privato. La sicurezza del posto di lavoro, le più basse retribuzioni e i minori incentivi all’efficienza determinano il comportamento dei burocrati, che è diverso da quello dei managers delle imprese private, cioè tendono alla conservazione invece che al cambiamento. Gran parte della Pubblica Amministrazione svolge attività amministrativa, cioè produttrice di servizi più che di beni, e spesso rende difficile il confronto con l’attività delle imprese private. Inoltre l’aumento dell’occupazione nel settore pubblico spesso non determina un aumento della produzione, ma l’occupazione viene creata dai politici solo per fini clientelari, di potere o semplicemente per creare posti di lavoro. Diversi autori sostengono che la burocrazia tende a moltiplicare se stessa, cioè i burocrati tendono a far crescere la dimensione del loro ente perché in tal modo possono accrescere il loro potere e il loro stipendio, quindi ogni settore della Pubblica Amministrazione cerca di avere più fondi. I burocrati spesso hanno una maggiore informazione rispetto ai politici, quindi presentano i problemi in modo tale da ottenere stanziamenti maggiori del necessario e sottostimeranno i costi dei loro programmi perché, una volta che il programma è stato approvato, otterranno ugualmente i fondi per portarlo a termine. Quindi la gestione pubblica genera distorsioni non meno gravi dei fallimenti del mercato, inoltre i dirigenti di enti e imprese pubbliche devono adottare procedure particolari e devono seguire delle regole che mirano ad evitare la corruzione e che garantiscano l’imparzialità del comportamento e queste regole possono ridurre l’efficienza del settore pubblico. Anche le grandi imprese private funzionano con criteri non molto diversi e non possono avere la flessibilità delle piccole e medie imprese. Infine alcuni autori rilevano che nelle moderne economie i beni e i servizi sono prodotti da diversi soggetti: famiglie, imprese private, imprese cooperative, enti e imprese pubbliche, associazioni senza fini di lucro. Occorre approfondire vantaggi e costi di ciascuno di questi soggetti, ognuno con un codice etico e un meccanismo di funzionamento tipico della propria categoria.
b) le imprese pubbliche
Le imprese pubbliche sono imprese controllate dallo Stato o dagli enti pubblici, in genere forniscono servizi di pubblica utilità, in origine erano private e sono state successivamente nazionalizzate. Il fenomeno ha assunto dimensioni diverse da Paese a Paese, ma negli ultimi anni in molte nazioni è prevalsa la tendenza a privatizzare le imprese pubbliche, cioè a trasferire la proprietà ai privati. Le ragioni che giustificano l’esistenza delle imprese pubbliche sono diverse. La prima è di evitare che si formino monopoli privati, certe attività di produzione di beni e servizi si svolgono inevitabilmente in regime di monopolio (monopolio naturale) e in questi casi l’impresa privata che gestisce tali servizi avrebbe una posizione di monopolio e fisserebbe quel prezzo che le dà il massimo profitto. E’ quindi opportuno che, dovendovi essere un monopolio, questo sia un monopolio pubblico. La seconda ragione è costituita dall’esistenza di beni pubblici o di esternalità e da esigenze di carattere redistributivo. Le imprese pubbliche possono produrre beni e servizi sia perché questi possono generare esternalità positive, stimolando la nascita di attività economiche private in quelle zone, sia per scopi sociali, cioè di redistribuzione del reddito, a vantaggio delle popolazioni che altrimenti non avrebbero tali servizi. Tali considerazioni, se giustificano l’intervento pubblico, non giustificano necessariamente la creazione dell’impresa pubblica, perché l’intervento dello Stato potrebbe prendere la forma di una commessa o di un sussidio all’impresa privata. Un’altra ragione è la necessità di sviluppare zone che tendono a rimanere arretrate. Infatti se lo sviluppo è affidato esclusivamente all’iniziativa privata ed alle forze del mercato, le imprese nascono solo in certe zone, dove le condizioni ambientali sono più adatte e gli investimenti più redditizi. L’obiettivo dello sviluppo delle regioni depresse può essere raggiunto anche con altri strumenti: con politiche di incentivazione finanziaria a favore delle imprese private, piccole e grandi, disposte a compiere investimenti nelle aree depresse, o con politiche di creazione di infrastrutture da parte dello Stato che, generando economie esterne, attraggono gli investimenti delle imprese private.
c) le imprese pubbliche in Italia
In
Italia, prima delle privatizzazioni, iniziate nel 1992, il fenomeno
dell’esistenza delle imprese pubbliche aveva dimensioni maggiori che negli
altri Paesi europei. Troviamo sia imprese sotto il pieno controllo pubblico
sia le Partecipazioni Statali.
Esempi delle prime sono l’ENEL (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) e le
Ferrovie dello Stato, che sono stati privatizzati, e gli enti pubblici
economici, come l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). Invece le
Partecipazioni Statali erano un sistema mediante il quale lo Stato, fino al
1992, assumeva partecipazioni azionarie in imprese private; sistema che è stato
successivamente smantellato. Il sistema delle Partecipazioni Statali era
costituito dal Ministero delle Partecipazioni Statali, che forniva l’indirizzo
generale e presentava ogni anno al Parlamento una relazione sull’attività del
sistema stesso, e da tre enti pubblici: l’Istituto per
d) le privatizzazioni
Sulla base dell’esigenza di procurare entrate allo Stato allo scopo di ridurre il debito pubblico, in diversi Paesi nel corso degli anni Ottanta si è proceduto a programmi di privatizzazione o dismissione, cioè di trasferimento ai privati della proprietà delle imprese pubbliche. Le vie sono state le seguenti: il collocamento delle azioni delle imprese in borsa, cioè la vendita a numerosi piccoli risparmiatori; la vendita diretta di tali imprese ad altre imprese private; la vendita di tali imprese ai propri dipendenti (management-buy-out). Per incentivare l’acquisto delle azioni in alcuni Paesi il Governo ha deciso alcune agevolazioni fiscali a favore di coloro che sottoscrivono queste azioni e le detengono per un certo numero di anni. Ad esempio in Gran Bretagna il Governo ha cercato di stimolare le famiglie all’acquisto delle azioni di quelle imprese che erogano servizi di pubblica utilità, le public utilities; così la prosperità di queste imprese viene frazionata fra numerosissimi azionisti e queste imprese vengono dette public companies. Un pericolo è che un’impresa privatizzata, allo scopo di abbassare i costi di produzione, riduca la qualità dei servizi erogati, oppure aumenti eccessivamente il prezzo di tali servizi, oppure rinunci ad un programma di investimenti necessario allo sviluppo dell’impresa. Per evitare questi rischi il Governo decide di mantenere alcuni diritti all’interno dell’impresa, attraverso il possesso di alcune azioni privilegiate (golden share) che consentono di influenzare la politica e i programmi dell’impresa privatizzata. Dal 1992 è iniziato un vasto processo di riduzione della presenza delle imprese pubbliche nell’economia italiana, tale processo è consistito nel trasferire ai privati la proprietà di larga parte di queste imprese pubbliche. Le motivazioni sono di due tipi: procurare entrate allo Stato per ridurre il disavanzo e il debito pubblico; restituire alle regole di mercato settori in cui le imprese pubbliche operavano in regime di monopolio o comunque in situazione privilegiata. Il Governo ha trasformato in società per azioni imprese che prima erano sotto il pieno controllo pubblico, come l’Ente Ferrovie dello Stato e l’ENEL. A partire dal 1992 il Governo ha abolito il Ministero delle Partecipazioni Statali, ha trasformato in società per azioni l’IRI e l’ENI ed ha messo in liquidazione l’EFIM. Ha poi attribuito al Ministero del Tesoro, divenuto Ministero dell’Economia e delle Finanze, la proprietà delle azioni delle società risultanti da tali trasformazioni e lo ha incaricato di amministrarle provvisoriamente fino alla loro vendita ai privati, successivamente realizzata. L’IRI è stato poi soppresso e molte delle sue società sono state vendute ai privati e sono quotate in Borsa. Anche una larga parte delle azioni dell’ENI è stata venduta ai privati ed è quindi quotato in Borsa, però il Ministero dell’Economia e delle Finanze resta l’azionista di controllo e può quindi imporre le sue scelte.
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025