|
|
| |
Laboratorio di fisica
424h75e
Scopo della relazione.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...
Strumenti.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......................
Descrizione dell'esperienza.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......................
Sistema di supporto pendolo.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....................
Dati raccolti.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...................
Considerazioni teoriche preliminari all'analisi dei dati.......... ..... ...... .......... ..... ...... .........
Elaborazione dati.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ........
Grafico.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .........................
Conclusioni.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .................
L'esperienza di laboratorio è servita per la determinazione dell'accelerazione di gravità attraverso rilevamenti sperimentali.
Durante l'esperienza di laboratorio abbiamo utilizzato i materiali forniti:
Personal computer Olivetti PCS286
Software dedicato
Fotocellula per la determinazione dei tempi
Pendolo, costituito da una sfera di ottone sospesa ad un filo di nylon
Supporto per il pendolo
La sessione di laboratorio è stata aperta, come consuetudine, da una spiegazione dell'argomento trattato da parte dei coadiutori che hanno illustrato esaurientemente i fondamenti teorici della ricerca.
La parte riguardante i calcoli è risultata più snella rispetto alla precedente esperienza di laboratorio della caduta del grave; questo grazie alla minore complessità dei calcoli da eseguire, anche se è comunque stata mantenuta la possibilità di utilizzare parte delle complesse formule usate nella precedente relazione.
L'analisi del moto del pendolo è molto interessante, in particolare le approssimazioni necessarie per semplificare la descrizione del movimento; infatti nonostante queste piccole irregolarità matematiche, le leggi risultano straordinariamente aderenti alla realtà.
L'elaboratore è stato ancora una volta il nostro strumento di rilevazione, grazie alla fotocellula interfacciata al computer sono stati rilevati i periodi delle oscillazioni del pendolo.
La fotocellula era costituita da un emettitore laser di forma cilindrica, lungo circa 40 cm. soggetta ad un forte innalzamento termico durante l'uso.
Ovviamente il pendolo è l'oggetto che attirava maggiormente l'attenzione, supportato da un braccio di alluminio alto circa un metro, pendeva un sottile, ma allo stesso tempo molto resistente, filo di nylon.
Questo filo trasparente consentiva il mantenimento della traiettoria del pendolo, inoltre la sua lunghezza poteva essere variata agendo sul sistema di supporto.
Combinando adeguatamente i vari parametri settabili (lunghezza filo, spostamento rispetto alla posizione verticale) si sono testate varie situazioni; in particolare si è potuto verificare un moto con angolo ridotto oppure esagerare volutamente, ricreando angoli superiori ai 45°.
La sferetta metallica, cioè il pendolo vero e proprio, era decisamente soggetto a moti poco favorevoli all'esperimento.
Il lancio doveva essere effettuato con la massima cura per fare sì che il pendolo si muovesse perpendicolarmente alla fotocellula.
Per garantire la massima precisione possibile i lanci sono stati effettuati dalla medesima persona, nonostante questo il moto non avveniva perfettamente.
Effettuate le rilevazioni abbiamo ceduto l'elaboratore a dei compagni di corso e ci siamo allontanati dal laboratorio.
Abbiamo effettuato differenti prove di oscillazione, regolando la lunghezza del filo a tre diverse ampiezze.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nella precedente esperienza di laboratorio (misurazione di g tramite la caduta di un grave) i risultati ottenuti sono stati solo parzialmente soddisfacenti; in questa seconda prova sfrutteremo, sempre per il medesimo scopo, le conoscenze teoriche acquisite nello studio del moto armonico e del pendolo semplice.
Esso consiste in un punto materiale appeso tramite un filo inestensibile e di massa trascurabile ad un certo luogo geometrico dove avviene il moto oscillatorio, ovviamente anche questo snodo è ritenuto privo di attrito.

Ricercando il diagramma delle forze agenti su p possiamo subito notare che la posizione di equilibrio statico è quella verticale: in questo caso la forza peso di P è equilibrata dalla tensione del filo Tf=mg .
Spostando il punto dalla verticale esso inizia ad oscillare attorno a questa lungo un arco di circonferenza di raggio L su di un piano verticale. In assenza di attrito le forze agenti su p sono sempre il peso e la tensione del filo : la seconda legge di Newton risulterà essere:
![]()
Le componenti lungo la traiettoria sono date dalle relazioni:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ricordando dallo studio del moto circolare le formule sull'accelerazione angolare e centripeta si ha:
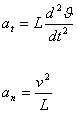
![]()
![]()
Andando a sostituire nella (1) e nella (2) si ha:
![]()
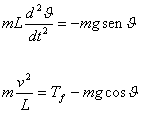
![]()
La prima è l'equazione differenziale del moto del pendolo la cui soluzione fornisce la legge oraria del moto; essa può anche essere scritta così:
![]()
![]()
Tenendo conto dello sviluppo di McLaurin del seno possiamo affermare che per piccole oscillazioni (~7°) l'equazione differenziale è:
![]()
![]()
La legge oraria del moto
![]()
![]()
dove
![]()
e J (ampiezza dell'oscillazione) e j (fase) sono due costanti dipendenti dalle condizioni iniziali del moto.
La (9) è una funzione periodica di periodo:
![]()
![]()
il quale è indipendente dall'ampiezza delle oscillazioni stesse (isocronismo delle piccole oscillazioni).
Elevando i membri della (10) al quadrato si ottiene:
![]()
![]()
![]()
ponendo:
si ricava che:
![]()
Definiamo A medio come:

Otteniamo quindi che:
![]()
inoltre:
![]()
e
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Procediamo col calcolo dell'accelerazione di gravità:
g50=9.62799 m/s2
g60=9.74528 m/ s2
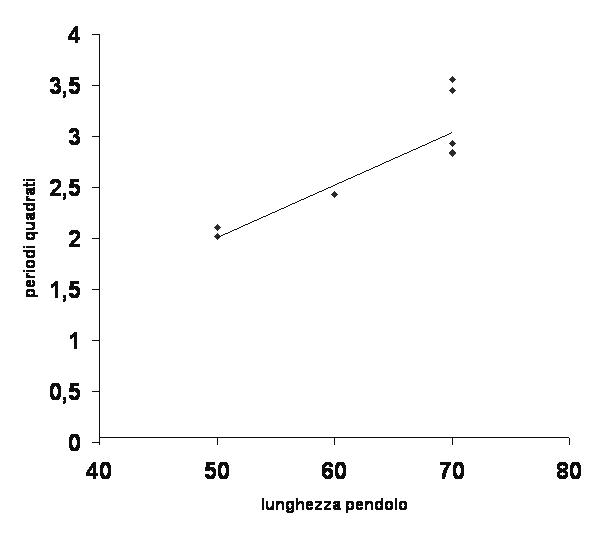
La buona riuscita dell'esperimento era basata sulle rilevazioni accurate e sulle approssimazioni matematiche delle formule utilizzate per i conti.
Come nel precedente esperimento di laboratorio il moto dell'oggetto esaminato ha creato diversi grattacapi: in particolare non è stato semplice garantire una traiettoria efficace al pendolo che non si muoveva su un piano perpendicolare alla fotocellula.
Nonostante ciò ad occhio le rilevazioni parevano sostanzialmente corrette e soprattutto simili.
Ebbene, queste impressioni non sono state confermate dalle rilevazioni strumentali, in particolare sono strane le variazioni nei tempi dei periodi.
Le oscillazioni di uno stesso lancio non sono numericamente ordinate come si potrebbe supporre, la seconda oscillazione è la più rapida, mentre la prima e la terza sono più lunghe; evidentemente le precauzioni prese dall'elaboratore prima di rilevare i tempi (cioè attendere un certo numero di passaggi del pendolo prima di rilevare i tempi) non sono state sufficienti.
Un cenno particolare merita una delle rilevazioni con lunghezza del filo 70cm.,in questo caso il periodo rilevato è stato realmente superiore rispetto agli altri valori in pari condizioni. Evidentemente quel passaggio è stato falsato da una qualche imprecisione come il moto del pendolo, o un riflesso che ha ingannato il rilevatore.
Si è potuto osservare che le ampie oscillazioni fanno risaltare esageratamente gli errori dovuti alle approssimazioni matematiche (vedi L=70 e ampiezza =40).
Abbiamo calcolato due g separati, relativi a due gruppi di misure, temendo una grave discrepanza sul secondo g, cosa che si è verificata dal momento che si sono dilatati gli intervalli di incertezza entro i quali cadono i valori di g.
Possiamo infine rilevare che utilizzando piccoli angoli di oscillazione si ottengono risultati realmente più soddisfacenti rispetto alla misurazione effettuata tramite la caduta di un grave.
Dal grafico si evince che la linea di tendenza approssima al meglio i valori in corrispondenza di lunghezze 50cm. e 60cm., mentre con 70cm. i punti sono più lontani dalla riga.
Questo fatto è da imputare alla grande oscillazione relativa alla combinazione L=70cm. e ampiezza=40cm.
Infatti eliminando i valori relativi a questa combinazione la linea è decisamente più aderente ai punti.
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025