|
|
| |
IMMANUEL KANT
Kant fu un grande pensatore. Visse e morì a K nigsberg (ora in Russia, un tempo nella Prussia orientale) conducendo una vita regolare e ordinaria, senza alcun fatto significativo.
Diede le basi della filosofia del XIX secolo. Non si può comprendere il pensiero di Kant se non si
conoscono la rivoluzione scientifica e l'empirismo.
Scrisse tantissimo sin da giovane. Le tre opere più significative sono:
CRITICA DELLA RAGION PURA, pubblicata nel 1781. E' un'opera di gnoseologia (dottrina della conoscenza umana). Kant spiega come l'uomo arriva alla conoscenza e indica alcuni limiti oltre i quali la conoscenza umana non può andare.
CRITICA DELLA RAGION PRATICA, 1788. Opera di etica o morale.
CRITICA DEL GIUDIZIO, 1790. Opera di estetica. Kant indica a quali condizioni si può parlare del bello (teoria del sublime).
Il pensiero maturo di Kant prende il nome di criticismo Kantiano, che è anche la filosofia di queste tre opere.
Altre opere di Kant sono:
"Risposta alla domanda: cos'è l'Illuminismo?", 1784
"Per la pace perpetua", 1795
"La religione nei limiti della sola ragione", 1794. Quest'opera fu censurata (censura religiosa). Kant rispose con il "Conflitto delle Facoltà"(1795), 252j95c che rappresenta la più importante difesa del diritto di pensiero.
"Prolegomeni: ad ogni futura metafisica che si presenterà come una scienza"1783. E' una sintesi della "Critica della ragion pura" perchè alcuni lettori avevano confuso alcuni suoi concetti.
Nel 1787 Kant ripubblicò la "Critica della ragion pura" cambiando completamente alcune parti che avevano dato luogo a dei fraintendimenti.
CRITICA DELLA RAGION PURA"
Kant attribuisce a se stesso il merito di avere compiuto una "rivoluzione copernicana" (in senso metaforico); ha operato quindi un grande cambiamento: ha posto l'uomo (l'IO) al centro del processo conoscitivo, mentre prima vi era il mondo.
Quando Kant parla di conoscenza indica la scienza, che per lui corrisponde alla fisica newtoniana; quindi: CONOSCENZA = SCIENZA = FISICA NEWTONIANA. Tutto ciò è al di fuori dell'IO.
Prima di Kant la conoscenza era indagare il mondo estrapolandone le leggi, che scienziati e filosofi pensavano gli appartenessero. Kant non è affatto d'accordo: secondo lui è l'IO che studia il mondo, e le leggi della natura sono le leggi che l'IO dà al mondo. Quindi: IO = LEGISLATORE DELLA NATURA.
Nella "Critica della ragion pura" Kant vuole studiare come funziona la nostra ragione nel processo della conoscenza, svolge quindi un'analisi particolareggiata della ragione quando produce conoscenza: vuole sottoporre la ragione all'analisi della ragione. Scopre così che essa, nel processo conoscitivo, ha dei limiti oltre i quali non può più produrre conoscenza. Questi limiti sono posti dall'esperienza sensibile.
Oltre i limiti la ragione produce qualcosa che sembra conoscenza, ma non lo è: si tratta della pseudo-conoscenza.
Secondo Kant, per secoli gli uomini hanno creduto di produrre conoscenza mentre in realtà era solo pseudo-conoscenza: la metafisica ( = ciò che hanno prodotto gli uomini credendo di produrre conoscenza). La vera conoscenza è quella che rimane entro i limiti dell'esperienza sensibile.
Secondo Kant, noi siamo strutturati in modo tale che la conoscenza del mondo ne è condizionata. Il mondo e le sue regole li percepiamo perchè siamo fatti in un certo modo. Quindi il nostro modo di vedere il mondo è condizionato da come siamo fatti. Un cane vede il mondo in modo diverso da noi, perchè il suo IO (mente, sensi, ecc..) è strutturato in modo diverso.
Anche il modo di conoscere è condizionato da come siamo fatti. Noi dobbiamo rinunciare al tentativo di conoscere il mondo per come è davvero, dovremmo essere diversi da come siamo per farlo.
Noi abbiamo la possibilità di conoscere solo il mondo fenomenico, cioè così come esso ci appare.
Il mondo noumenico ( = il mondo per come è davvero) non lo potremo mai conoscere, solo Dio può farlo.
Potrebbe essere che il mondo fenomenico corrisponda al mondo noumenico, ma noi questo non lo potremo mai sapere. Per saperlo dovremmo essere fatti in modo diverso, ma è impossibile. Dobbiamo accontentarci di una conoscenza fenomenica del mondo.
Nella "Critica della ragion pura" Kant fa una netta distinzione tra ragione e intelletto. La mente umana può operare sotto forma di intelletto oppure di ragione.
La mente umana opera in quanto intelletto quando produce conoscenza:
opera in quanto ragione quando produce metafisica.
CONOSCENZA = SCIENZA
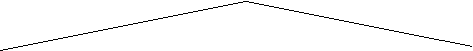
materia: esperienza forma: categorie pure
![]()
![]() dell'intelletto
dell'intelletto
(sono 12)
materia forma:
flusso caotico intuizioni pure della
costituito da sensibilità: spazio (lì)
impressioni tempo (ora)
sensibili (sono elementi trascendentali
senza i quali non ci sarebbe
l'esperienza e quindi la
conoscenza)
* trascendentali: a priori (che vengono prima dell'esperienza), puri, innati (ci appartengono, non ci vengono dati dall'esterno), universali (tutti noi li possediamo), necessari.
Per conoscere servono l'esperienza e l'intelletto. E' necessario che tutto ciò che apprendiamo sia ordinato e sistemato. E' l'intelletto che ordina l'esperienza attraverso altri elementi trascendentali che si trovano al suo interno: le categorie pure dell'intelletto. Una di esse è la causalità, e fa sì che noi istituiamo una relazione di causa-effetto tra due fatti che avvengono uno di seguito all'altro (es. fuoco e pentolino con l'acqua --> l'acqua bolle).
La conoscenza umana è soggettiva, perchè abbiamo in noi gli elementi trascendentali, e universale perchè gli elementi trascendentali si trovano in tutti noi.
La "critica della ragion pura" è divisa in tre parti:
estetica trascendentale: studio dell'esperienza;
analitica trascendentale: studio delle categorie pure dell'intelletto. Kant ha ripreso le categorie pure dell'intelletto dall' "Organon" di Aristotele (A. affermava che le categorie erano nello stesso tempo oggettive e soggettive);
dialettica trascendentale: studio della nostra mente in quanto ragione, pensare senza avvalersi dei dati dell'esperienza.
Si credeva che la metafisica fosse cosmologia razionale (studio del mondo), teologia razionale (studio di Dio), psicologia razionale (studio dell'anima). Era convinzione dei metafisici che alle più grandi verità ci si potesse arrivare solo attraverso la ragione, ecco perchè l'uso della parola "razionale".
Non si può parlare di mondo, Dio e anima in termini scientifici ("è un problema di fede", come diceva Pascal). Kant le considera tre idee innate.
Kant è convinto che la metafisica possa essere una scienza, purchè sia diversa da quella che è stata in passato.
Di che cosa dovrà occuparsi la metafisica per essere una scienza? Degli elementi trascendentali del conoscere e dell'agire umani.
Le affermazioni a cui arrivano i metafisici su mondo, Dio e anima sono contraddittorie. Su questi argomenti l'uomo ragiona con i dati fornitegli dall'esperienza, formulando affermazioni antitetiche.
Kant è un sicuro credente, ma dell'esistenza di Dio non si può dare alcuna dimostrazione.
Non ci è possibile conoscere Dio, l'anima e il mondo. Le prove date in passato sono pseudo-prove, non hanno nessun fondamento scientifico. Kant con questo non intende dire che Dio non esiste, solo che non si può dare nessuna dimostrazione di tipo scientifico. DIO = PROBLEMA DI FEDE
Epistemologia: studio della scienza.
Kant ha compiuto una rivoluzione epistemologica; la conoscenza umana è una collaborazione, un intreccio, tra esperienza e intelletto.
"CRITICA DELLA RAGION PRATICA"
Etica: l'agire buono, ai fini di una vita buona e giusta.
Kant non lo dice esplicitamente, ma compie una rivoluzione copernicana anche sul campo della morale. Secondo lui, gli uomini pongono al centro del loro agire etico realtà esterne all'uomo e all'IO, come fonti di ciò che è bene e di ciò che è male. Gli uomini tengono questa fonte (religione, Dio, stato, natura) fuori di sé.
La rivoluzione copernicana nell'etica consiste nel porre l'IO al centro di essa.
Secondo Kant, l'uomo ha dentro di sé un imperativo categorico (= comando) che gli suggerisce ciò che deve fare per fare il bene. La rivoluzione sta nel non porre fuori dall'uomo la fonte che gli dice ciò che deve e che non deve fare (come dicevano anche Democrito, Socrate, Cartesio, gli Stoici; erano razionalisti etici).
L'uomo è autonomo: dal punto di vista morale/etico è autosufficiente. È in grado di darsi da solo le regole per vivere bene. ( --> etica dell'eteronomia: etica secondo la quale dev'essere un altro a dare le regole da seguire per vivere bene).
L'uomo non è costituito solo da ragione e pensiero, l'uomo è anche corporeità e sensibilità: è ricco quindi di passioni e istinti.
L'agire bene è una delle cose più difficili, perchè dentro di noi abbiamo istinti e passioni che ci inducono a fare altre cose.
È un'etica della responsabilità, perchè nel momento in cui facciamo del male, non possiamo usare la scusa di non conoscere il bene; è un'etica molto rigorosa.
L'agire etico è:
soggettivo, perchè l'imperativo categorico è dentro di noi;
universale, perchè l'imperativo categorico è uguale in tutti gli uomini.
L'etica kantiana è un'etica del disinteresse : egli non considera azione buona il fare con un secondo fine, fare il bene con la speranza di trarne qualche vantaggio. L'agire etico è quello per cui facciamo bene per fare bene.
(Es.: fare il bene per fare piacere a Dio --> NO!! L'agire etico è fare il bene quando nessuno ci vede).
È un'etica formalistica, non di contenuti: non è fatta di elenchi di azioni che non dobbiamo compiere, ma ci indica come dobbiamo agire per fare del bene, ci dice in che forma dobbiamo agire.
Due massime:
AGISCI SEMPRE IN MODO TALE CHE CIO' CHE FAI POSSA DIVENTARE UNA NORMA UNIVERSALE (non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te);
AGISCI SEMPRE IN MODO TALE DA CONSIDERARE OGNI ALTRO UOMO ANCHE COME FINE E MAI SOLO COME UN MEZZO (agire sempre all'insegna del rispetto, della dignità delle altre persone; anche le autorità devono rispettare questa regola).
Se l'uomo ha dentro di sé questo comandamento vuol dire che può scegliere se rispettarlo oppure no --> L'UOMO è LIBERO! Agire etico = libertà dell'uomo
Postulati della ragion pratica:
(postulato: qualcosa che dobbiamo ammettere come vero anche se non riusciamo a dimostrarlo)
libertà, perchè l'uomo agisca eticamente dobbiamo dimostrare che è libero
esistenza di Dio
immortalità dell'anima
La perfezione morale non è raggiungibile in questo mondo, proprio perchè l'uomo è anche corpo; la si può raggiungere solo al di là di questo mondo, nell'anima che continuerà a vivere dopo la nostra morte.
Funzione di Dio: non premiare chi agisce bene solo per trarre vantaggi.
Etica dell'autonomia:
agonistica: non è facile fare il bene, è una lotta
rigorosa, l'uomo è responsabile del proprio agire.
Ne "La religione nei limiti della sola ragione" Kant afferma che l'autentica fede è quella che si manifesta nell'obbedienza alle massime dell'imperativo categorico, il resto è SUPERSTIZIONE. L'autentica religione è fare il bene per fare bene e trattare le persone rispettando la loro dignità. Secondo le religioni rivelate questa era bestemmia, perchè se fosse veramente come afferma Kant, Dio non esisterebbe più. Se noi ci affidassimo alla nostra ragione, di conseguenza non ascolteremmo più ciò che dice Dio. Ma per Kant non è Dio che ci dice ciò che l'uomo deve o non deve fare, perchè abbiamo già dentro di noi le massime dell'imperativo categorico.
Dio non è il legislatore morale dell'uomo, l'uomo sa già ciò che è giusto o sbagliato.
"CRITICA DEL GIUDIZIO"
Estetica: parte della filosofia che si occupa dell'arte e del bello della natura
Anche qui Kant opera una rivoluzione copernicana, ma non lo afferma. Il bello della natura non esiste in sé e per sé, la bellezza non è un dono che la natura fa a noi, è un dono che NOI facciamo alla natura. La bellezza non è una proprietà oggettiva della natura e delle cose, così come non lo erano le leggi ("Critica della ragion pura").
È attraverso un contatto dell'esperienza con la natura che noi esprimiamo un giudizio.
"Non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace... ma non tutto ciò che piace è bello!"
Il piacere deve essere disinteressato: una cosa non è bella solo perchè è utile, giusta o vera. Una cosa è bella quando suscita piacere a prescindere dalle sue qualità, quando ha in sé un piacere disinteressato.
Il giudizio di bellezza è soggettivo (passa necessariamente attraverso il soggetto che giudica) ma anche universale (è bello solo ciò che piace a tutti, perchè siamo fatti tutti nello stesso modo).
Quando una cosa non piace a tutti allora non è bella.
LA FINALITA' DELL'ARTE E' IL BELLO FINE A SE STESSO.
IL SUBLIME
Schiller: "Si chiama sublime un oggetto alla cui rappresentazione la nostra natura fisica sente dei
limiti, siamo fisicamente deboli"
Il sublime può essere matematico (es. l'universo, grande ma fermo) o dinamico (quello che noi sentiamo dinanzi a forze infinitamente potenti; qualcosa di grande, di potente, in movimento).
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025