|
|
| |
La base dell'economia è la competizione esistente a livello mondiale.
Le persone e le istituzioni necessitano strumenti adatti per prendere decisioni economiche giuste per la società e devono conoscere la situazione e chi gli sta intorno. L'economia è quindi funzione della persona e nasce come scienza morale, ponendo in relazione risorse scarse a bisogni crescenti: deve quindi individuare le risorse più importanti, accrescere le risorse e capire come distribuirle. A questo punto si può iniziare a parlare di economicità: cercare di perseguire nel tempo un equilibrio economico a favore delle persone che lavorano negli istituti, sapendo che ogni istituto opera in un ambiente mutevole e quindi essendo consci di dover fare previsioni e scelte esatte.
Abbiamo quindi capito che l'attività economica è svolta dalle persone e per le persone; persone che si uniscono in società umane. Inoltre ogni teoria economica è fortemente influenzata dalle ipotesi circa la natura delle persone e dei gruppi di persone. Esse inseguono dei fini, in quanto la ricchezza deve essere utile al benessere sociale; su questo punto in particolare possiamo distinguere due teorie: la teoria collettivista (comunista) e la teoria liberalista (mercato libero). Attualmente la Nostra società è a cavallo tra questi due modelli, dove lo stato ha un ruolo fondamentale ma non dominante, pur non demandando tutto al mercato.
In questo complesso sistema non dimentichiamo le persone, che perseguendo i loro fini suscitano i bisogni: si definisce bisogno l'esigenza di un bene necessario agli scopi di vita. Tradizionalmente, distinguiamo due grandi classi di bisogni: bisogni naturali e bisogni sociali. I primi sono suscitati dalla componente biologica delle persone (bisogno di alimentarsi, riposare, ripararsi dal freddo etc. etc.), mentre gli altri sono suscitati dalla sfera spirituale delle singole persone e dal fatto che esse interagiscono con altre persone raggruppate in insiemi, i quali formano le società umane.
I bisogni sociali possono essere a loro volta distino in bisogni essenziali (primari) e bisogni voluttuari (secondari), questi ultimi fortemente influenzati (talora creati) da processi imitativi e dimostrativi connessi al fenomeno delle mode.
la teoria economica trae da altre discipline e dottrine le conoscenze sui bisogni delle persone e ne elabora gli aspetti rilevanti per l'attività economica di produzione e di consumo.
Per l'analisi economica sono quindi rilevanti le dinamiche dei bisogni. I bisogni delle persone si dispongono in una gerarchia: c'è una scelta (priorità) nei bisogni a seconda del reddito del singolo; man mano che i redditi disponibili crescono si accede a determinati consumi, a cui non si può accedere se il reddito è più basso. Questa gerarchia è però a volte alterata dai modelli di consumo che tendono a creare dei falsi bisogni, variando così la gerarchia: a fronte di bisogni le scelte delle persone sono soggette a processi di apprendimento.
Il soddisfacimento dei bisogni richiede, tra l'altro, la disponibilità di beni. Distinguiamo due grandi classi di beni: beni economici e beni non economici. Sono beni economici le merci ed i servizi utili per il soddisfacimento dei bisogni delle persone e scarsi (pochi) rispetto alle loro esigenze. Sono beni non economici (o beni liberi) i beni non soggetti al limite di scarsità, ossia liberamente disponibili in quantità e qualità più che sufficienti rispetto alle esigenze di tutte le persone che ne sentono il bisogno. Per soddisfare i loro bisogni le persone consumano sia beni economici che non economici.
Altre classi di beni sono beni primari e beni voluttuari (in corrispondenza dei bisogni), beni complementari, ovvero che hanno un uso funzionale l'un l'altro al fine di soddisfare un unico bisogno, e beni fungibili, ovvero beni diversi che soddisfano un unico bisogno senza però mai interagire tra loro, beni differenziabili (diversi da altri) e beni non differenziabili (commodities - con caratteristiche uguali), beni di consumo (immediati) e beni strumentali, ovvero utili per produrre altri beni, beni ad utilizzo singolo (usa e getta) e beni durevoli, beni a consumo individuale e beni a consumo collettivo. Per concludere, un'altra classificazione fondamentale di beni è quella che distingue i beni privati dai beni pubblici.
Dopo aver definito le varie classi di beni possiamo affermare che con la loro produzione e il loro consumo abbiamo tre operazioni differenti:
· 131j93b ; Trasformazione tecnica: si svolge sia per la produzione che per il consumo
in tutti gli ordini di istituto. Sono operazioni di
trasformazione fisica, logica e spaziale delle
materie prime, degli impianti, dei dati e delle
conoscenze.
· 131j93b ; Negoziazioni: le negoziazioni sono strettamente complementari alle attività
interne di trasformazione e caratterizzano fortemente sia i
sistemi economici nei quali essi operano (per soddisfare le mie
finalità sono costretto ad acquistare ciò che non produco). Le
negoziazioni si classificano essenzialmente in ragione
dell'oggetto scambiato.
· 131j93b ; Configurazione dell'assetto istituzionale: per completare le opere di
trasformazione e negoziazione
tutti gli istituti svolgono attività
relative al proprio governo (come
organizzazione e gestione xsonale,
e operazione di rilevazione e
informazione).
Abbiamo quindi capito che l'attività economica di produzione si attua tramite l'impiego di determinate condizioni di produzione, che includono ogni elemento o circostanza che direttamente o indirettamente contribuiscono a rendere possibile, a facilitare, od ostacolare, la produzione economica d'impresa. Tra esse vi sono le condizioni primarie di produzione, definite secondo un duplice criterio:
1. 131j93b ; sono fondamentali per ogni impresa
2. 131j93b ; sono tali da suscitare nelle persone che le conferiscono interessi economici primari nei confronti dell'impresa
Queste condizioni non sono altro che il lavoro ed il capitale. Esse fanno a capo a due categorie di persone che compongono il soggetto economico d'impresa, ossia l'insieme di persone che hanno interessi economici primari nell'impresa e che di conseguenza hanno il diritto/dovere di governarla.
Come già detto, ogni teoria economica è caratterizzata dalle persone, dai gruppi di persone e dai loro comportamenti; a questo proposito dovremo contrapporre due figure che rappresentano l'essenza dell'essenza dell'attività economica e che si contrappongono l'un l'altra:
|
Homo oeconomicus |
Persona umana |
|
Autonomo |
Membro società umana |
|
Egoista |
Svolge l'attività economica come mezzo e non come fine |
|
Motivato solo da redditi e ricchezza |
Opera secondo razionalità limitata |
|
In grado di valutare tutto secondo razionalità assoluta |
Da valore a solidarietà, realtà e progresso |
Adottare una visione ampia della persona umana significa sviluppare un'analisi economica più compiuta che tenga conto della storia delle persone, dei gruppi, e delle loro interazioni sociali.
Fatta questa distinzione dobbiamo ricordare che le persone agiscono per massimizzare il proprio benessere individuale, e che il loro comportamento è razionale ed è previdente e coerente nel tempo. Le loro scelte sono influenzate da
· 131j93b ; esperienza, consumi e abitudini (passate e presenti)
· 131j93b ; dipendenze individuali (capitale personale, ovvero le conoscenze)
· 131j93b ; caratteristiche delle persone o dei gruppi di persone con i quali si interagisce (capitale sociale)
L'attività economica comporta continue scelte e decisioni. La teoria dei processi decisionali degli attori economici è perciò una parte rilevante della teoria economica. Abbiamo quindi tre modelli utili per capire come le persone attuano le loro decisioni:
· 131j93b ; modello delle scelte individuali secondo razionalità assoluta
· 131j93b ; modello delle scelte individuali secondo razionalità limitata
· 131j93b ; modelle delle scelte di più attori all'interno di complessi organizzati, sempre secondo razionalità limitata
|
Razionalità assoluta |
Razionalità limitata (Simon) |
|
Problemi e obbiettivi chiari |
Il decisore parte da un insieme di attese iniziali |
|
Informazioni disponibili subito e gratuitamente |
Una prima ricerca esplorativa porta ad individuare qualche possibile soluzione |
|
Futuri certi e conosciuti |
Il decisore esamina e valuta una prima possibile soluzione |
|
Alternative chiare e valutate simultaneamente |
In base ala prima analisi il decisore modifica le sue attese |
|
Decisore unico e isolato |
Il decisore esamina altre possibili soluzioni alternative e le valuta una ad una in sequenza |
|
Il decisore sceglie l'alternativa migliore e unica |
Il soggetto sceglie la soluzione che gli sembra più logica ed esatta (soddisfacente) |
Leggendo la tabella ci possiamo rendere conto che il primo modello è utopico/assurdo nell'ambito dell'attività economica.
Il terzo modello tratta scelte a più attori in contesti organizzati, quindi di processi decisionali collettivi. Ogni giorno le imprese prendono decisioni di svariato tipo (aprire un nuovo stabilimento, lanciare un nuovo prodotto, scegliere il canale pubblicitario più adatto etc. etc.). le decisioni da prendere devono esser tra loro coordinate e coerenti, ma sono anche in concorrenza tra loro e ciò dipende da due fattori:
· 131j93b ; ogni processo decisionale richiede l'impegno di risorse tra le quali tempo ed energia della persona o delle persone che devono decidere; tali risorse sono scarse, così può accadere che alcuni processi decisionali iniziano e vengono subito conclusi, mentre altri si arenino senza neanche iniziare
· 131j93b ; le scelte effettuate scaturiscono da processi decisionali che implicano l'impiego di risorse che come già detto sono limitate e, di conseguenza, una scelta può essere incompatibile ed in concorrenza con altre.
Non solo le decisioni ma anche le soluzioni sono in concorrenza tra loro: uno stesso problema può trovare infatti più soluzioni diverse sostenute da uno o più soggetti ed i decisori dovranno decidere quale sia la più soddisfacente.
Nelle occasioni di decisione le persone portano i problemi ai quali ciascuno attribuisce differente priorità; il problema viene affrontando cercando concretamente una soluzione se tutti i partecipanti attribuiscono al problema una criticità elevata. Una certa scelta si compie se una soluzione viene presentata in modo compiuto e convincente come risposta ad un problema percepito come rilevante ed urgente. Concludendo, i processi decisionali delle imprese sono dunque solo parzialmente strutturati con meccanismi di razionalità e le loro strutture organizzative sono influenzate nelle scelte da regole organizzative, procedure e routine.
Come abbiamo visto, per il perseguimento dei fini, le persone interagiscono tra loro sia occasionalmente che all'interno di gruppi o società umane. L'azione individuale integrata all'interno della società umana produce benefici individuali e benefici collettivi di vario ordine e il loro ottenimento richiede comportamenti appropriati, sempre influenzati dal capitale sociale del singolo o del gruppo. Inoltre attorno ad ogni persona che occupa una certa posizione (ruolo) all'interno della collettività umana si forma un diverso sistema di attese comportamentali, che influenzano molto la persona al centro di queste attese. (vedere schema pag. 31 del libro:-"Corso di economia aziendale" scritto da Airoldi, Brunetti, Coda).
La ragion d'essere delle società umane e la condizione essenziale per il loro efficace funzionamento è la cooperazione tra le persone che vi fanno parte, la quale produce la "rendita organizzativa" che spetta a tutti coloro che cooperano. L'imperfetta conoscibilità degli input, dei comportamenti de capitale sociale, degli output porta ad una mancata cooperazione che da inizio ad una serie di comportamenti opportunistici, che porteranno a loro volta sfiducia nel capitale personale.Al contrario, la fiducia nasce da ripetuti comportamenti leali e cooperativi.
Le persone attuano inoltre comportamenti altruistici, funzionali alla massimizzazione del benessere personale; ciò porterà l'individuo ad avere buone relazioni sociali, bassi costi di transazione, ideali di giustizia, equilibrio e progresso.
N.b.: le imprese che guadagnano maggiormente sono quelle in ci esiste un clima positivo, in quanto la persona si realizza, produce di più ed il profitto complessivo aumenta. Non esiste un'organizzazione che tragga profitto da situazioni conflittuali.In base a ciò ho due teorie, qui di seguito schematizzate:
Ipotesi
negative sulla natura umana Ipotesi
positive sulla natura umana

Comportamenti realmente opportunistici Organizzazioni
prescritte e coercitive Conferma e
rinforzo ipotesi x


Conferma e
rinforzo ipotesi y Organizzazioni
responsabili


![]()

Comportamenti
leali e cooperativi
Le scienze economiche si articolano in due rami: l'economia aziendale e l'economia politica. La prima studia l'economia di ogni singola istituzione e come migliorarla, mentre la seconda studia l'economia degli aggregati (ad es. non si occupa di un ospedale ma considera e cerca di migliorare la spesa pubblica globale).
Cap. 2, 3.1, 3.2:-"La specializzazione economica e le combinazioni economiche d'istituto"
Per comprendere la natura degli istituti nei quali si svolge l'attività economica è necessario rispondere ad alcune fondamentali domande:
1. 131j93b ; Perché l'attività economica non è totalmente svolta all'interno delle famiglie?
Perché la specializzazione fa si che ci siano cose più convenienti da fare, quindi anziché effettuare più cose in breve tempo è meglio specializzarsi in poche e bene. Ci sono quindi più istituti perché la famiglia, essendo specializzata in determinate categorie di beni, non riuscirà a soddisfare tutti i suoi bisogni, che verranno quindi soddisfatti dalle aziende o dalle altre istituzioni che producono beni.
2. 131j93b ; Perché le persone tendono ad aggregarsi in istituti anzichè operare indipendentemente scambiandosi lavoro, beni e capitali?
I meccanismi di mercato non sempre sono particolarmente efficienti, infatti il passaggio attraverso il mercato comporta costi di transazione, ossia costi sostenuti per negoziare e per concludere un apposito contratto per ciascuna operazione che si svolge all'interno del mercato. In questi casi conviene passare ad una differente forma di integrazione tra le parti; le parti concordano di aggregarsi sotto una stessa autorità entrando a far parte di uno stesso istituto, dove i costi di integrazione sono più bassi rispetto a quelli del mercato.
3. 131j93b ; Perché l'attività economica non si svolge nell'ambito di un intero istituto (o organizzazione) centrale?
In passato c'è stato il caso dell'economia di tipo collettivista che ha dimostrato l'impossibilità di questa opzione, in quanto un'organizzazione così complessa per essere gestita rischia di essere troppo lenta rispetto al dinamismo ambientale che la circonda, e quindi non compatibile con lo stesso.
4. 131j93b ; Perché gli istituti si differenziano in quattro grandi classi?
Perché insieme si può dire che sono la struttura dell'attività economica: le aziende sono efficienti e innovative e operano sul mercato stimolate dalla concorrenza. Tuttavia le aziende non sono in grado di soddisfare il fabbisogno pubblico, quindi deve intervenire lo Stato; a ciò si aggiunge il fine altruistico delle aziende non profit. Infine vi sono le famiglie, che si preoccupano sia di produrre che consumare beni.
5. 131j93b ; Perché all'interno di ogni macroclasse abbiamo realtà diverse?
Perché il continuo dinamismo ambientale e del mercato e la conseguente innovazione fanno si che all'interno dello stesso settore si formino realtà e situazioni diverse.
Esistono anche quattro modelli alternativi:
· 131j93b ; Modello dell'autoconsumismo: il sistema economico e sociale è formato
soltanto da famiglie, che si trovano in
sostanziale autonomia rispetto a gruppi
analoghi. Ogni prodotto di ogni gruppo
primario è riservato esclusivamente
all' autoconsumo. In tale situazione manca
la specializzazione economica ma è
comunque presente una ripartizione dei
compiti.
· 131j93b ; Modello atomistico: esistono soltanto persone singole che svolgono in
autonomia la propria attività di lavoro
specializzata, senza raggrupparsi in imprese. Le
loro attività sono correlate alle leggi di mercato.
· 131j93b ; Modello della gerarchia totale: esiste un'organizzazione di stato centrale
che pianifica l'intera attività economica.
· 131j93b ; Modello della pluralità degli istituti centralizzati, ovvero il nostro modello.
Una delle basi di quest'ultimo modello è che vi sia la specializzazione, in quanto la risposta più efficiente nel produrre beni per soddisfare bisogni è specializzare gli istituti l soddisfare un determinato bisogno, quindi differenziare gli istituti. Gli elementi che ci portano a questa differenziazione sono:
· 131j93b ; Processi di apprendimento: se continuo a fare una stessa cosa arrivo ad una
performance, quindi col passare del tempo riduco
tempo e costi
· 131j93b ; Impiego ottimale delle risorse produttive
· 131j93b ; Attitudini manageriali, ovvero fare in modo che ogni persona sia impiegato
nel settore per cui è più portato
· 131j93b ; Riduzione dei costi (derivati dalla razionalizzazione delle fasi di produzione)
· 131j93b ; Specializzazione dei macchinari: più l'impianto di produzione è grande minore
sarà la spesa per l'azienda, in quanto il costo
si ridistribuisce sulle unità prodotte
· 131j93b ; Motivazione, dovuta al giusto impiego delle attitudini individuali
Detto tutto ciò, possiamo affermare che si viene a formare un modello globale:
Investimenti in sviluppo della conoscenza
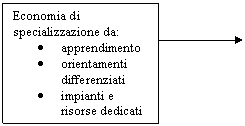
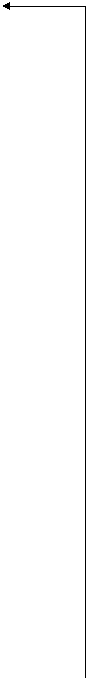
![]()
![]()
![]()
![]()
Ampiezza delle conoscenze utilizzabili per la
produzione Ampiezza dei mercati: volumi di produzione
vendibili
![]()
![]()
![]()
SPECIALIZZAZIONE DEL LAVORO E DEGLI IMPIANTI
|
|
Complessità dei compiti; interdipendenze; dinamismo e imprevedibilità
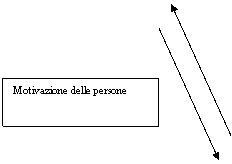
Investimenti in strumenti di coordinamento e governance: Problemi di integrazione tra soggetti:


![]()
![]()

![]()
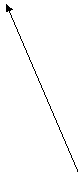
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Definito un modello globale per le quattro classi di istituti, dobbiamo studiare i modelli interpretativi della realtà estesi alle quattro classi. Qui entrano in gioco le combinazioni economiche, ovvero l'insieme delle attività che caratterizzano il funzionamento di un'azienda per raggiungere le sue finalità istituzionali.
Le combinazioni economiche si distinguono in coordinazioni parziali e combinazioni parziali.
Le coordinazioni parziali
Le coordinazioni parziali sono un insieme di processi caratterizzati da una funzione (ad esempio ideare e sviluppare prodotti) e da un insieme di competenze specialistiche applicate l loro svolgimento (ad esempio competenze di fabbricazione) Possono essere classificate nelle seguenti operazioni:
· 131j93b ; Configurazione dell'assetto istituzionale: determina i modelli di governo e
origine delle aziende.
N.b.: l'assetto istituzionale è l'insieme delle persone che definiscono il bene
Comune e delle modalità con cui lo fanno
· 131j93b ; Gestione: è l'insieme di operazioni attraverso le quali l'impresa attua la
la produzione economica.
Le operazioni di gestione si dividono in:
1. 131j93b ; gestione caratteristica (dell'azienda), che a sua volta si divide in cinque sezioni:
· 131j93b ; ricerca&sviluppo (innovazione)
· 131j93b ; Approvvigionamento
· 131j93b ; Commercializzazione
· 131j93b ; Logistica (organizzazione del processo produttivo)
· 131j93b ; Fabbricazione
2. 131j93b ; Gestione finanziaria, ovvero l'insieme delle attività che si occupano della situazione monetaria. Questo tipo di gestione si divide in:
· 131j93b ; Gestione del capitale a rischio
· 131j93b ; Gestione dei debiti di prestito
3. 131j93b ; Gestione assicurativa (stipula contratti assicurativi)
4. 131j93b ; Gestione tributaria (tasse)
5. 131j93b ; Gestione patrimoniale (immobili).
In corrispondenza delle scelte di investimento, la gestione patrimoniale si attua attraverso vari tipi di negoziazioni:
· 131j93b ; Negoziazioni di capitali di prestito (investimenti a basso rischio-bot)
· 131j93b ; Negoziazioni di capitali di rischio (investimenti in azioni)
· 131j93b ; Negoziazioni di beni privati (opere d'arte e beni rivalutabili)
· 131j93b ; Organizzazione: è l'insieme di operazioni che si occupa dello svolgimento
dell'attività lavorativa. In queste operazioni risultano
fondamentali i meccanismi operativi che analizzano le
le leve motivazionali dei dipendenti.
· 131j93b ; Rilevazione: è il settore che si occupa dei bilanci e dei sistemi contabili e che
Realizza quindi il rendiconto, fondamentale per le decisioni.
Cap. 2, 3.1, 3.2:-"La specializzazione economica e le combinazioni economiche d'istituto"
Per comprendere la natura degli istituti nei quali si svolge l'attività economica è necessario rispondere ad alcune fondamentali domande:
6. 131j93b ; Perché l'attività economica non è totalmente svolta all'interno delle famiglie?
Perché la specializzazione fa si che ci siano cose più convenienti da fare, quindi anziché effettuare più cose in breve tempo è meglio specializzarsi in poche e bene. Ci sono quindi più istituti perché la famiglia, essendo specializzata in determinate categorie di beni, non riuscirà a soddisfare tutti i suoi bisogni, che verranno quindi soddisfatti dalle aziende o dalle altre istituzioni che producono beni.
7. 131j93b ; Perché le persone tendono ad aggregarsi in istituti anzichè operare indipendentemente scambiandosi lavoro, beni e capitali?
I meccanismi di mercato non sempre sono particolarmente efficienti, infatti il passaggio attraverso il mercato comporta costi di transazione, ossia costi sostenuti per negoziare e per concludere un apposito contratto per ciascuna operazione che si svolge all'interno del mercato. In questi casi conviene passare ad una differente forma di integrazione tra le parti; le parti concordano di aggregarsi sotto una stessa autorità entrando a far parte di uno stesso istituto, dove i costi di integrazione sono più bassi rispetto a quelli del mercato.
8. 131j93b ; Perché l'attività economica non si svolge nell'ambito di un intero istituto (o organizzazione) centrale?
In passato c'è stato il caso dell'economia di tipo collettivista che ha dimostrato l'impossibilità di questa opzione, in quanto un'organizzazione così complessa per essere gestita rischia di essere troppo lenta rispetto al dinamismo ambientale che la circonda, e quindi non compatibile con lo stesso.
9. 131j93b ; Perché gli istituti si differenziano in quattro grandi classi?
Perché insieme si può dire che sono la struttura dell'attività economica: le aziende sono efficienti e innovative e operano sul mercato stimolate dalla concorrenza. Tuttavia le aziende non sono in grado di soddisfare il fabbisogno pubblico, quindi deve intervenire lo Stato; a ciò si aggiunge il fine altruistico delle aziende non profit. Infine vi sono le famiglie, che si preoccupano sia di produrre che consumare beni.
10. 131j93b ; 131j93b ; 131j93b ; 131j93b ; 131j93b ; 131j93b ; 131j93b ; Perché all'interno di ogni macroclasse abbiamo realtà diverse?
Perché il continuo dinamismo ambientale e del mercato e la conseguente innovazione fanno si che all'interno dello stesso settore si formino realtà e situazioni diverse.
Esistono anche quattro modelli alternativi:
· 131j93b ; Modello dell'autoconsumismo: il sistema economico e sociale è formato
soltanto da famiglie, che si trovano in
sostanziale autonomia rispetto a gruppi
analoghi. Ogni prodotto di ogni gruppo
primario è riservato esclusivamente
all' autoconsumo. In tale situazione manca
la specializzazione economica ma è
comunque presente una ripartizione dei
compiti.
· 131j93b ; Modello atomistico: esistono soltanto persone singole che svolgono in
autonomia la propria attività di lavoro
specializzata, senza raggrupparsi in imprese. Le
loro attività sono correlate alle leggi di mercato.
· 131j93b ; Modello della gerarchia totale: esiste un'organizzazione di stato centrale
che pianifica l'intera attività economica.
· 131j93b ; Modello della pluralità degli istituti centralizzati, ovvero il nostro modello.
Una delle basi di quest'ultimo modello è che vi sia la specializzazione, in quanto la risposta più efficiente nel produrre beni per soddisfare bisogni è specializzare gli istituti l soddisfare un determinato bisogno, quindi differenziare gli istituti. Gli elementi che ci portano a questa differenziazione sono:
· 131j93b ; Processi di apprendimento: se continuo a fare una stessa cosa arrivo ad una
performance, quindi col passare del tempo riduco
tempo e costi
· 131j93b ; Impiego ottimale delle risorse produttive
· 131j93b ; Attitudini manageriali, ovvero fare in modo che ogni persona sia impiegato
nel settore per cui è più portato
· 131j93b ; Riduzione dei costi (derivati dalla razionalizzazione delle fasi di produzione)
· 131j93b ; Specializzazione dei macchinari: più l'impianto di produzione è grande minore
sarà la spesa per l'azienda, in quanto il costo
si ridistribuisce sulle unità prodotte
· 131j93b ; Motivazione, dovuta al giusto impiego delle attitudini individuali
Detto tutto ciò, possiamo affermare che si viene a formare un modello globale:
Investimenti in sviluppo della conoscenza
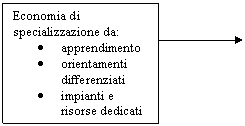
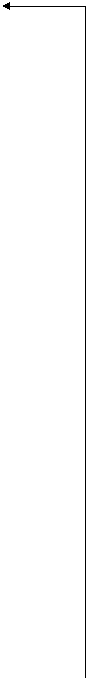
![]()
![]()
![]()
![]()
Ampiezza delle conoscenze utilizzabili per la
produzione Ampiezza dei mercati: volumi di produzione
vendibili SPECIALIZZAZIONE
DEL LAVORO E DEGLI IMPIANTI Costi di coordinamento: Costi di rigidità:
![]()
![]()
![]()
Complessità dei compiti; interdipendenze; dinamismo e imprevedibilità
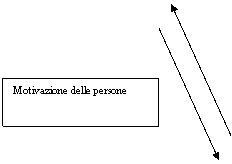
Investimenti in strumenti di coordinamento e
governance: Problemi di integrazione tra soggetti:


![]()
![]()

![]()
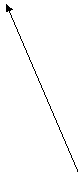
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Definito un modello globale per le quattro classi di istituti, dobbiamo studiare i modelli interpretativi della realtà estesi alle quattro classi. Qui entrano in gioco le combinazioni economiche, ovvero l'insieme delle attività che caratterizzano il funzionamento di un'azienda per raggiungere le sue finalità istituzionali.
Le combinazioni economiche si distinguono in coordinazioni parziali e combinazioni parziali.
Le coordinazioni parziali
Le coordinazioni parziali sono un insieme di processi caratterizzati da una funzione (ad esempio ideare e sviluppare prodotti) e da un insieme di competenze specialistiche applicate l loro svolgimento (ad esempio competenze di fabbricazione) Possono essere classificate nelle seguenti operazioni:
· 131j93b ; Configurazione dell'assetto istituzionale: determina i modelli di governo e
origine delle aziende.
N.b.: l'assetto istituzionale è l'insieme delle persone che definiscono il bene
Comune e delle modalità con cui lo fanno
· 131j93b ; Gestione: è l'insieme di operazioni attraverso le quali l'impresa attua la
la produzione economica.
Le operazioni di gestione si dividono in:
6. 131j93b ; gestione caratteristica (dell'azienda), che a sua volta si divide in cinque sezioni:
· 131j93b ; ricerca&sviluppo (innovazione)
· 131j93b ; Approvvigionamento
· 131j93b ; Commercializzazione
· 131j93b ; Logistica (organizzazione del processo produttivo)
· 131j93b ; Fabbricazione
7. 131j93b ; Gestione finanziaria, ovvero l'insieme delle attività che si occupano della situazione monetaria. Questo tipo di gestione si divide in:
· 131j93b ; Gestione del capitale a rischio
· 131j93b ; Gestione dei debiti di prestito
8. 131j93b ; Gestione assicurativa (stipula contratti assicurativi)
9. 131j93b ; Gestione tributaria (tasse)
10. 131j93b ; 131j93b ; 131j93b ; 131j93b ; 131j93b ; Gestione patrimoniale (immobili).
In corrispondenza delle scelte di investimento, la gestione patrimoniale si attua attraverso vari tipi di negoziazioni:
· 131j93b ; Negoziazioni di capitali di prestito (investimenti a basso rischio-bot)
· 131j93b ; Negoziazioni di capitali di rischio (investimenti in azioni)
· 131j93b ; Negoziazioni di beni privati (opere d'arte e beni rivalutabili)
· 131j93b ; Organizzazione: è l'insieme di operazioni che si occupa dello svolgimento
dell'attività lavorativa. In queste operazioni risultano
fondamentali i meccanismi operativi che analizzano le
le leve motivazionali dei dipendenti.
· 131j93b ; Rilevazione: è il settore che si occupa dei bilanci e dei sistemi contabili e che
Realizza quindi il rendiconto, fondamentale per le decisioni.
Cap. 3.2, 3.3:-"Le combinazioni economiche parziali e le combinazioni economiche di Stato"
Durante l'ultima lezione abbiamo analizzato le coordinazioni economiche parziali; ora ci apprestiamo a conoscere le combinazioni economiche parziali. Questo tipo di operazioni viene tendenzialmente attuato dalle gradi aziende che decidono di compiere mosse di diversificazione, ponendo sul mercato linee di prodotti con caratteristiche diverse rispetto a quelli offerti fino a quel momento.
La combinazione economica parziale è una combinazione prodotto-mercato con caratteristiche diverse rispetto alle altre combinazioni prodotto-mercato attuate dalla stessa impresa. Le imprese che attuano più combinazioni economiche parziali sono dette imprese diversificate.
Le combinazioni economiche delle imprese sono riconducibili ai seguenti insiemi di operazione:
· 131j93b ; operazioni che servono ad eseguire gli input necessari per la produzione
· 131j93b ; operazioni che servono per trasformare gli input in output
· 131j93b ; operazioni che servono per cedere ai clienti i beni offerti dall'impresa
· 131j93b ; operazioni di impostazione e governo della complessiva attività aziendale: assetto istituzionale aziendale, assetto organizzativo e di gestione del personale, operazioni di rilevazione e informazione
Lo Stato svolge un ruolo essenziale nei sistemi economici, intervenendo secondo pià modalità: producendo direttamente alcuni beni sia pubblici che privati, regolamentando la produzione e il consumo di altri beni, imponendo tributi di varia specie, ridistribuendo la ricchezza.
Per analizzare le combinazioni economiche dello Stato occorre capire quali sono le ragioni di intervento dello Stato in campo economico. Innanzitutto lo Stato interviene nei processi di produzione e consumo di beni economici quando si presentano congiuntamente due condizioni:
1. 131j93b ; Il bene economico in oggetto è giudicato politicamente critico, ovvero è tale che i governati giudicano che deve essere accessibile a certe categorie di cittadini con un certo contenuto qualitativo garantito.
2. 131j93b ; Lo Stato giudica che lasciando la produzione di quel bene a famiglie di privati operanti secondo le regole di mercato si otterrebbero esiti non positivi dal punto di vista politico.
N.b.: esistono beni pubblici che non presentano il criterio di non escludibilità, e quindi possono essere sottoutilizzati imponendo una tariffa; per evitare ciò vengono effettuati una serie di finanziamenti ma in questo caso può avvenire il fenomeno del free-riding, ovvero persone che non partecipano ad un finanziamento di un bene pubblico del tipo sopra descritto sapendo che potranno comunque usufruire.
1. 131j93b ; subentrando direttamente nella produzione
L'intervento dello Stato può compiersi in varie forme di relazione a seconda delle situazioni che si trova ad affrontare. Le modalità fondamentali di intervento sono:
· 131j93b ; La produzione diretta o indiretta di beni
· 131j93b ; L'emanazione di leggi e regolamenti
· 131j93b ; I trasferimenti di mezzi monetari in forme varie
Circa le modalità di produzione di beni pubblici si hanno situazione diversificate a seconda di come si combinano i seguenti elementi:
· 131j93b ; Quale tipo di soggetto svolge l'attività di produzione (se è lo Stato di parla di produzione diretta, altrimenti di produzione indiretta)
· 131j93b ; Le modalità di copertura dei relativi costi che variano da bene a bene
L'emanazione di leggi e regolamenti può essere invece considerata l'attività essenziale degli istituti pubblici
Una parte rilevante della "spesa pubblica" si attua tramite trasferimenti di mezzi monetari, ossia assegnando una parte dei mezzi monetari raccolti dallo Stato ad istituti che non fanno parte della pubblica amministrazione, principalmente famiglie ed imprese. Un'altra consistente parte è invece riservata alla pubblica amministrazione. I trasferimenti si possono distinguere in:
· 131j93b ; Trasferimenti volti direttamente a riattuare una ridistribuzione della ricchezza
· 131j93b ; Trasferimenti volti a finanziare attività o comportamenti di interesse pubblico
Lo Stato ha la caratteristica, unica, di svolgere due gestioni tributarie: non solo paga i tributi (gestione passiva) ma li raccoglie (gestione attiva).
La gestione attiva è il complesso di determinazione, accertamento e riscossione dei tributi da parte delle aziende composte pubbliche e può essere considerata parte della gestione caratteristica delle stesse
La gestione patrimoniale dello Stato è anch'essa composta da azioni di investimento e disinvestimento e presuppone risparmio o comunque risorse eccedenti utili alla gestione caratteristica
La gestione finanziaria è fondamentale all'interno delle aziende composte pubbliche, ma la realtà del nostro Paese in cui domina il ricorso alla emissione di titoli del debito pubblico fa si che questo continui ad autoalimentarsi, tanto che il debito pubblico dovrebbe corrispondere al 60% del PIL ed invece siamo circa al 110% .
Lo Stato svolge complessi ruoli politici, etici e sociali ed è quindi impiegato in diverse operazioni che hanno per oggetto la configurazione del suo assetto istituzionale. Di regola gli assetti istituzionali statali si evolvono in base alle risposte date ai seguenti punti:
· 131j93b ; In quali aree intervenire, a favore di che e con quali strumenti
· 131j93b ; Con quali forme dirette ed indirette intervenire sulla produzione e l'erogazione di beni pubblici
· 131j93b ; Quando e come interagire con le altre forme ed istituti della pubblica amministrazione
· 131j93b ; Come impostare il sistema fiscale in modo tale che sia equo, efficiente e corretto
· 131j93b ; Quali tipi di rapporti istaurare con i conferenti di capitale di prestito
· 131j93b ; Quali rapporti instaurare con i conferenti di lavoro ed i loro rappresentanti sindacali
· 131j93b ; Come strutturare le relazioni con i cittadini
Per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione del personale in sostanza valgono le stesse regole impresarie, con la conservazione di due principi fondamentali:
· 131j93b ; Conservare il rapporto stretto tra organi politici ed amministrativi,ovvero l'assetto istituzionale, cioè l'insieme di persone nell'interesse delle quali viene gestita l'azienda: bisogna quindi trovare l'assetto più funzionale per rappresentare l'interesse dei cittadini.
· 131j93b ; Conservare e preservare il principio di legalità: se lo stato ha come obbligo la legalità, l'imprese ha l'economicità
Le operazioni di rilevazione e informazione devono rappresentare anche le dimensioni politiche e sociali degli obbiettivi. La rilevazione è l'insieme delle strumentazioni contabili atti a rilevare i singoli bilanci per crearne uno unico.
N.b.: uno dei problemi di oggi è passare da una rilevazione tradizionale (entrate e uscite) ad una simile a quella delle imprese (molto più complessa).
L'organo che svolge i controlli sulle amministrazioni pubbliche è la Corte dei Conti.
Cap. 3.4, 3.5, 3.6:-"Le combinazioni economiche delle famiglie, delle aziende non profit e lo scambio"
L'articolazione delle combinazioni economiche all'interno delle famiglie
Le famiglie sono tra i protagonisti essenziali dell'attività economica e sono aziende patrimoniali (acquisisce redditi) di consumo (beni).
La gestione caratteristica delle aziende familiari è composta essenzialmente da:
· 131j93b ; Attività di produzione di redditi mediante lavoro esterno
· 131j93b ; Attività di lavoro interno alla famiglia
· 131j93b ; Attività di consumo
La gestione patrimoniale è da considerarsi parte della gestione caratteristica, in quanto è nella natura dell'azienda familiare produrre risparmio e il suo conseguente investimento al fine di produrre redditi
La fonte primaria di reddito delle aziende familiari è il lavoro esterno, ossia il lavoro prestato dai membri di una famiglia in aziende di produzione. Esso è solo una parte del lavoro espresso dai membri della famiglia, in quanto tutti i membri prestano anche lavoro interno.
La seconda fonte di reddito è data dalla gestione patrimoniale, che si attua nell'ambito di una vasta gamma di operazioni:
· 131j93b ; Operazioni di investimento
· 131j93b ; Operazioni di impiego amministrazione degli investimenti
· 131j93b ; Operazioni di negoziazione di rischi particolari connessi agli investimenti
· 131j93b ; Operazioni conesse ai servizi pubblici
· 131j93b ; Operazioni di donazione e di lasciti/ricezioni di eredità
L'attività di consumo si attua con lo svolgimento di una grande varietà di operazioni e processi; l'insieme delle operazioni di consumo sono un complesso insieme di operazioni di produzione a cui viene applicato un notevole lavoro interno. Le principali operazioni volte al consumo sono
· 131j93b ; Negoziazioni di acquisto de beni di consumo
· 131j93b ; Operazioni di trasformazione tecnica i beni di consumo
· 131j93b ; Negoziazioni di beni pubblici
· 131j93b ; Operazioni di pagamento connesse alle varie attività
La famiglia è nel suo insieme una fabbrica di beni complessi, che sono contemporaneamente prodotti e consumati dalla famiglia stessa
La gestione finanziaria è data dalle operazioni di negoziazione di credito e/o di prestito con le conseguenti formazioni di debiti o riscossioni di interessi
La gestione tributaria delle famiglie si compone delle operazioni di accertamento, di liquidazione e di pagamento dei tributi nelle loro differenti forme
In quanto istituto naturale e sociale primario, la famiglia non comporta fondamentali scelte di configurazione dell'assetto istituzionale.
Le combinazioni naturali delle aziende non profit
Le aziende non profit si sviluppano per far fronte al mercato e all'intervento pubblico. Non sono strutturate come imprese perché non hanno la finalità di massimizzare il reddito; inoltre non possono essere considerate aziende composte pubbliche perché hanno un proprietario privato.
Le aziende non profit nascono negli Stati Uniti per far fronte ai fallimenti di mercato; nell'ambito pubblico, invece, nascono dal fallimento dello Stato che accade quando le uscite sono maggiori delle entrate, quindi avviene l'indebitamento. Dopo il 1992 le entrate iniziarono ad aumentare me il debito pubblico era ormai talmente alto che gli interessi su questo lo fecero lievitare ancora: l'Italia non era riuscita a rispondere ai bisogni del paese in modo economicamente sufficiente. Nascono quindi gli istituti non profit, i quali hanno due finalità diverse: mercato e intervento pubblico.
N.b: non profit significa che vi può essere bilancio positivo ma che questo non può essere ripartito tra i soci.
La gestione caratteristica può essere di tre tipi, in funzione delle finalità dell'azienda:
· 131j93b ; Azienda non profit che funziona come azienda di produzione
· 131j93b ; Azienda non profit che funziona da azienda di produzione e consumo
· 131j93b ; Azienda non profit che funziona come azienda di pura erogazione
Un aspetto fondamentale di tutti e tre i tipi è il found-raising, ovvero la raccolta di fondi.
Un altro aspetto delle aziende non profit sono le fondazioni bancarie, che rappresentano un settore di risparmio dell'economia; nascono quando nelle casse pubbliche di risparmio valgono separate gestione e proprietà (legge Amato del '90).
Le aziende di consumo cedono lavoro a 2, 3, 4
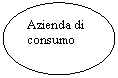
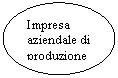 ed hanno in loro tutti
ed hanno in loro tutti
![]()
![]() i tipi di negoziazione.
i tipi di negoziazione.
Le aziende composte
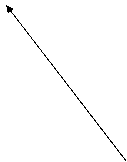
![]()
![]()
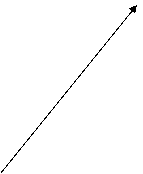
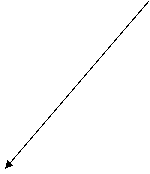
![]()
![]() pubbliche
cedono
pubbliche
cedono
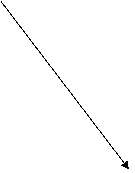 servizi
a 4, 1, 2.
servizi
a 4, 1, 2.
Le aziende di consumo
possono fare prestiti a 4
pagano tasse a 3 e
possono mettere
capitale nelle 2
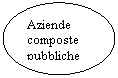
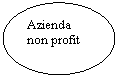 Le
2 negoziano con 1
Le
2 negoziano con 1
![]()
![]() beni
di consumo
beni
di consumo
Le 4 possono cedere attività lavorative alle
3
Possono fare tutte
negoziazioni di
prestiti.
Le combinazioni economiche delle 4 classi studiate si articolano quindi in un insieme di negoziazioni, regolate dallo scambio, tradizionalmente monetario. Ciò perché lo scambio è una caratteristica della specializzazione, che porta, come già sappiamo, ad una pluralità di istituti. Questa porta a sua volta alla proprietà privata e a sua volta questa ci dirige verso lo scambio monetario, in quanto all'interno del mercato viene definito un prezzo, che rileviamo come proprietà da incassare/cedere a seconda se vendiamo/compriamo.
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025