|
|
| |
MISURA DELL'EQUIVALENTE IN ACQUA DI UN CALORIMETRO
MISURA DEL CALORE SPECIFICO DI UNA SOSTANZA
SCOPO DELL'ESPERIENZA
L'esperienza si articola in due fasi:
1) Misura dell'equivalente in acqua di un calorimetro, cioè della massa d'acqua avente capacità termica uguale a quella del calorimetro stesso;
2) Misura del calore specifico di una sostanza incognita introdotta nel calorimetro e unita a una massa d'acqua sfruttando il processo dell'equilibrio termico.
DESCRIZIONE DELL'APPARATO DI MISURA
Per questa esperienza si è utilizzato un calorimetro, cioè un contenitore le cui pareti interne sono riflettenti per evitare dispersioni di calore all'esterno.
Nel calorimetro c'è un agitatore che consente di raggiungere la temperatura di equilibrio fra le sostanze introdotte in minor tempo possibile.
Nel calorimetro si introduce anche un termometro della sensibilità di 0,2°C per misurare la temperatura di equilibrio.
Per misurare il volume delle masse d'acqua si utilizza un cilindro graduato. L'errore assoluto che si considera sulle masse d'acqua è di 1g; poiché il peso campione (ottone) di cui si deve calcolare il calore specifico è uno strumento di laboratorio, si considera trascurabile l'errore sulla sua massa.
DESCRIZIONE DELL'ESPERIENZA
Equivalente i 212i83c n acqua:
Per misurare l'equivalente in acqua del calorimetro, si devono mescolare nel calorimetro stesso due masse d'acqua a temperature diverse. Sfruttando il fatto che il calore acquistato dalla massa d'acqua più fredda è uguale al calore ceduto da quella più calda, si imposta un'equazione, dove la massa equivalente è l'incognita ed è aggiunta alla massa d'acqua più fredda.
Quindi:
Q1 = Q2
c m1 (T1- Teq) = c(m2 + me)(Teq - T2)
Calore specifico:
Per misurare il calore specifico di un corpo, si determina la massa d'acqua e si introduce nel calorimetro rilevandone la temperatura col termometro.
Si scalda il peso incognito in un recipiente contenente acqua a 100°C e si trasferisce velocemente nel calorimetro, per evitare il più possibile dispersioni di calore.
Si agita l'acqua e il peso con l'agitatore, finché non si raggiunge la temperatura di equilibrio.
Si imposta così l'equazione Qceduto = Qacquistato, dove cioè il calore acquistato dalla somma della massa d'acqua e dell'equivalente in acqua del calorimetro è uguale al calore ceduto dal pesetto.
DATI SPERIMENTALI
Ognuna delle due misure è stata ripetuta due volte.
Dati sperimentali per la misura dell'equivalente in acqua
I MISURA
|
m1(Kg) |
T1 (°C) |
m2 (Kg) |
T2 (°C) |
Teq (°C) |
|
|
|
|
|
|
II MISURA
|
m1 (Kg) |
T1 (°C) |
m2 (°C) |
T2 (°C) |
Teq (°C) |
|
|
|
|
|
|
Dati sperimentali per la misura del calore specifico
I MISURA
|
m1 (Kg) |
T1 (°C) |
m2 (Kg) |
T2 (°C) |
Teq (°C) |
|
|
|
|
|
|
II MISURA
|
m1 (Kg) |
T1 (°C) |
m2 (Kg) |
T2 (°C) |
Teq (°C) |
|
|
|
|
|
|
ELABORAZIONE DEI DATI SPERIMENTALI
Misura dell'equivalente in acqua
Si imposta l'equazione Q1 = Q2, dove cioè, come già detto, si eguaglia il calore ceduto dall'acqua più calda al calore acquistato dall'acqua più fredda, a cui si aggiunge la massa equivalente che rappresenta l'incognita.
Pertanto
m1c(T1 - Teq) = (me + m2)c(Teq - T2)
Si risolve quindi l'equazione:
me = m1T1 - m1Teq - m2Teq + m2T2
Teq - T2
A questo punto, per ogni misura effettuata, si va a sostituire i dati letterali con quelli numerici, calcolando, oltre alla massa equivalente, anche il suo errore assoluto.
I MISURA
me1 = m1T1 - m1Teq - m2Teq + m2T2 = 0,023 Kg
Teq - T2
Per calcolare l'errore relativo Dme1/ me1, si applica la proprietà distributiva del rapporto:
![]() me1 = m1(T1 -
Teq) - m2(Teq - T2)
me1 = m1(T1 -
Teq) - m2(Teq - T2)
![]() Teq - T1 Teq - T2
Teq - T1 Teq - T2
Si indica con la lettera K m1(T1 - Teq)
Teq - T2
Si indica con la lettera B T1 - Teq
Teq - T2
Dme1 = DK + Dm2
Dm2 = 0,001 Kg
DK = K (Dm1/m1 + DB/B)
K= 0,072 Kg
Dm1
m1
DB = BMAX - BMIN
B 2B
BMAX = T1 - Teq + 2DT = 0,73
Teq - T2 + DT
BMIN = T1 - Teq - 2DT = 0,71
Teq - T2 + 2DT
B = T1 - Teq = 0,72
Teq - T2
DB
B
DK = (0,01 + 0,014) X 0,072 Kg = 0,002 Kg
Dme = (0,002 + 0,001)Kg = 0,003 Kg
me1 = (0,023 ± 0,003)Kg
II MISURA
Si ripete l'intero procedimento per calcolare la seconda massa equivalente.
me2 = m1 (T1 - Teq) - m2 (Teq - T2) = 0,024 Kg
Teq - T2
K = 0,074 Kg
Dm1
m1
Dm2 = 0,001 Kg
BMAX = 0,75
BMIN = 0,72
DB = 0,015
B = 0,74
DB
B
DK = 0,002 Kg
Dm2 = 0,001 Kg
Dme2 = (0,002 + 0,001)Kg = 0,003Kg
me2 = (0,024 ± 0,003) Kg
Misura del calore specifico
Si imposta l'equazione Q1 = Q2, dove cioè il calore ceduto dalla sostanza incognita è uguale al calore acquistato dalla somma della massa d'acqua m1 e dall'equivalente in acqua me.
Per ognuna delle due misure effettuate si calcola il valore di c sia con la prima massa equivalente che con la seconda.
(me + m1) c1(Teq - T1) = m2 c (T2 - Teq)
c = c1 (me + m1)(Teq - T1)
m2 (T2 - Teq)
I MISURA
c' = c1 (me1 + m1)(Teq - T1) = 441,8 J/KgK
m2 (T2 - Teq)
Per calcolare l'errore assoluto su c si applica di nuovo la proprietà distributiva del rapporto. L'errore assoluto sul calore specifico dell'acqua e della massa del pesetto m2 si considerano trascurabili.
Si indica con B Teq - T1
T2 - Teq
Dc Dm1 + Dme1 + DB
c m1 + me1 B
B = Teq - T1 = 0,09
T2 - Teq
BMAX = (Teq + DT) - (T1 - DT) = 0,10
(T2 - DT) - (Teq + DT)
BMIN = (Teq - DT) - (T1 + DT) = 0,09
(T2 - DT) - (Teq + DT)
DB
B
Dm1 + Dme = 0,018
m1 + me1
Dc'= (0,018 + 0,05) X 441,8 J/KgK = 32,2 J/KgK
c' = (441,8 ± 32,0) J/KgK
Si ripete lo stesso procedimento per trovare gli altri valori di c.
c'' = c1(m1 + me2) (Teq - T1) = 443,7 J/KgK
m2 ( T2 - Teq)
DB
B
Dm1 + Dme2 = 0,018
m1 + me2
Dc'' = (0,018 + 0,05) x 443,7 = 30,2 J/KgK
c'' = (443,7 ± 30,2) J/KgK
II MISURA
c''' = c1 (me1 + m1)(Teq - T1) = 438,9 J/KgK
m2 ( T2 - Teq)
DB = 0,1
B
Dme1+ Dm1 = 0,018
me1 + m1
Dc''' = (0,018 + 0,1) x 438,9 J/KgK = 51,7 J/KgK
c''' = (438,9 ± 51,7) J/KgK
c''''= c1 (me + m1)(Teq - T1) = 440,8 J/KgK
m2(T2 - Teq)
DB = 0,1
B
Dm1 + Dme = 0,018
m1 + me
Dc''''= (0,018 + 0,1) x 440,8 J/ KgK = 52,0 J/KgK
c''''= (440,8 ± 52,0) J/KgK
RISULTATI SPERIMENTALI
L'esperienza aveva due scopi:
1) Calcolare l'equivalente in acqua di un calorimetro, mescolando due masse d'acqua a temperature diverse; alla massa d'acqua con minore temperatura è stata aggiunta la massa equivalente me, che era l'incognita dell'equazione Qceduto = Qacquistato.
La misura è stata ripetuta due volte. I risultati sperimentali ottenuti sono:
me1 = (0,023 ± 0,003) Kg
me2 = (0,024 ± 0,003) Kg
Attraverso una rappresentazione grafica, si può constatare che i risultati sperimentali trovati sono compatibili:
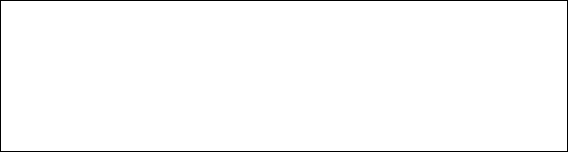
2) Calcolare il calore specifico di una sostanza incognita (ottone) mescolata nel calorimetro con una massa d'acqua a diversa temperatura.
La misura è stata ripetuta due volte; per ogni rilevazione si è calcolato il calore specifico, considerando ognuna delle due masse d'acqua equivalenti calcolate in precedenza, attraverso l'equazione Qceduto = Qacquistato.
I quattro risultati pervenuti sono:
c'= (441,8 ± 30,0) J/KgK
c''= (443,7 ± 30,2) J/KgK
c'''= (438,9 ± 51,7) J/KgK
c'''' = (440,8 ± 52,0) J/KgK
Attraverso la rappresentazione grafica si può constatare che i valori di c calcolati sono compatibili tra loro, ma non lo sono con il valore esatto delcalore specifico dell'ottone.
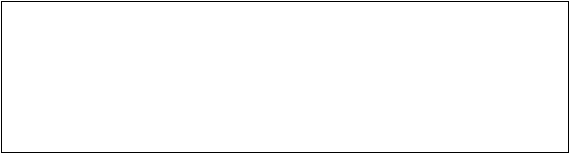
Inverosimilmente, questa incompatibilità è dovuta al fatto che nel calcolo è stato considerato l'equivalente in acqua del calorimetro che, invece di rendere più preciso il valore del calore specifico calcolato, ha fatto si che il suo intervallo non si intersecasse col valore esatto dello stesso.
Si calcola allora il calore specifico senza considerare l'equivalente in acqua.
m1c1(Teq - T1) = m2c2(T2 - Teq)
I MISURA
c2 = m1 c1 (Teq - T1) = 396,2 J/KgK
m2 (T2 - Teq)
Dc2 Dm1 DB
c2 m1 B
Dc2 = 21,8 J/KgK
c2 = (396,2 ± 21,8) J/KgK
II MISURA
Si ripete lo stesso procedimento per la seconda misura
c2= 393,6 J/KgK
Dc2 = 41,3 J/KgK
c2 = (393,6 ± 41,3) J/KgK
Come si può constatare dalla rappresentazione grafica, i due nuovi valori di c sono compatibili tra loro e con il valore esatto del calore specifico dell'ottone.
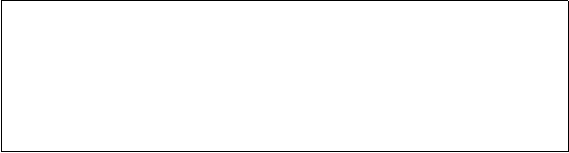
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2026