|
|
| |
Possono essere divisi in due gradi gruppi:
- le affezioni a carattere addensante,
- la affezioni a carattere demineralizzante.
OSTEOPETROSI PRECOCE
A carattere autosomico recessivo.
Si manifesta nelle prime settimane di vita per un interessamento delle condizioni generali, con pallore e turbe oculari.
Sono presenti: ipotrofia importante, pallore cutaneo e delle mucose, talvolta turbe di tipo emorragico quali ecchimosi o porpora.
L'anemia è severa con piastrinopenia e neutropenia.
Il midollo è ipoplasico o addirittura aplasico.
Gli occhi sono ipermobili e asinergici; il nistagmo è frequente.
L'esame del fondo dell'occhio dimostra una atrofia.
Presenti pure epato e splenomegalia.
L'evoluzione è particolarmente severa con decesso nei primi anni di vita in un quadro di ipotrofia e anemia severa, di emorragie, scatenate più frequentemente da una infezione intercorrente.
RADIOLOGIA
L'esame radiografico mostra un caratteristico addensamento di tutto lo scheletro, con metafisi allargate.
TRATTAMENTO
Può giovarsi di un trapianto midollare.
OSTEOPETROSI TARDIVA
A carattere autosomico dominante.
La scoperta avviene abitualmente nella seconda infanzia o nell'adolescenza, in occasione di un esame radiografico praticato per una frattura.
Le complicazioni, in età adulta, sono:
1) compressione dei nervi cranici,
2) osteite della mandibola,
3) osteonecrosi della mandibola.
La fragilità ossea è meno severa dell'osteogenesi imperfetta. La prognosi è varia, condizionata dall'insorgenza delle complicanze. Il trattamento è puramente sintomatico.
PICNODISOSTOSI
E' affezione caratterizzata oltre che dall'aumentata densità delle ossa senza difetto di modellamento, dalla bassa statura (circa 145 cm.) con arti brevi ed estremità particolarmente corte.
La prognosi è favorevole.
OSTEOMESOPICNOSI
Malattia che interessa unicamente la densità ossea del rachide, aumentata, senza rilevanza clinica.
OSTEOPECILIA
Si tratta più di una curiosità radiologica che di una malattia.
La scoperta è occasionale, per una indagine radiologica effettuata per altri motivi.
Il quadro radiografico è caratterizzato da aree di ad densamento a modo di lenticchie, disseminate alle regioni metafisarie ed epifisarie.
OSTEOGENESI IMPERFETTA PRECOCE
E' scoperta alla nascita e nelle forme più gravi, non è compatibile con la vita.
Il neonato appare affetto da nanismo severo, con brevità e deviazioni multiple degli arti.
Il cranio è largo, il torace ristretto.
Gli arti appaiono particolarmente flessibili con la possibilità di apprezzare crepitii nei tentativi di mobilizzazione.
La volta cranica, per la scarsa ossificazione, è depressibile.
RADIOLOGIA
L'esame radiografico dimostra, oltre a una diffusa e grave demineralizzazione dello scheletro, arti corti, a contorni ondulati in corrispondenza di calli di frattura multipli, responsabili dell'aspetto a bambù.
La ristrettezza del torace è la causa di morte, in poche ore, per insufficienza respiratoria.
Una forma meno grave, con sintomatologia clinica e quadro radiografico simile, ma meno esacerbato, consente la sopravvivenza alla nascita.
In tal caso la morte potrà sopravvenire durante il primo anno di vita, per una infezione respiratoria.
Una forma più benigna, che si manifesta alla nascita con brevità degli arti e incurvamento delle ossa, associato a un difetto dell'ossificazione del cranio, potrà consentire la sopravvivenza, evolvendo negli anni verso una forma di tipo tardivo.
OSTEOGENESI IMPERFETTA TARDIVA (morbo di Lobstein o Osteopsatirosi)
Una frattura provocata da un traumatismo minimo all'inizio della deambulazione o delle fratture a ripetizione sono l'esordio che fa pensare a una fragilità ossea.
La diagnosi inizialmente può essere difficile, perché le deformità sono discrete e l'esame radiografico è talvolta poco significativo.
L'esame attento del bambino potrà mettere in evidenza un lieve allargamento del cranio, talvolta una iperlassità legamentosa, una tinta azzurrina delle sclere o un aspetto traslucido dei denti.
Lo studio radiografico dovrà essere completo.
Successivamente le anomalie ossee diventano rapidamente più evidenti, e la diagnosi si pone con facilità.
Le fratture si ripetono per traumatismi minimi, talvolta insignificanti.
Gli arti inferiori sono quelli più interessati.
Il soggetto è di bassa statura, con arti inferiori incurvati.
Il tronco è corto come conseguenza dell'appiattimento dei corpi vertebrali, con lo sterno proiettato in avanti.
La muscolatura è poco sviluppata.
La trasmissione è autosomica dominante.
La patogenesi incerta.
TRATTAMENTO
La calcitonina di salmone ha dimostrato una dubbia utilità.
Osteotomie multiple di allineamento agli arti inferiori, con inchiodamento endomidollare, a fine crescita possono consentire la stazione eretta.
OSTEOPOROSI GIOVANILE
Si rivela fra gli 8 e gli 11 anni, secondariamente a una frattura per un traumatismo minimo o a rachialgia.
Clinicamente il dato più evidente è la cifosi dorsale che si accompagna a lieve riduzione di altezza del tronco con proiezione dello sterno in avanti.
Le fratture prediligono le metafisi.
I tempi e le modalità di guarigione sono normali, possono tuttavia residuare delle deformità.
RADIOLOGIA
L'esame radiologico dimostra una diffusa osteoporosi,le eventuali deformità derivate dalle fratture e, a livello del rachide, corpi vertebrali schiacciati e a forma lenticolare o cuneiforme.
L'evoluzione negli anni è favorevole. L'eziologia non è nota. Non esiste allo stato attuale alcun trattamento.
Riuniscono quelle affezioni responsabili di un disordine dello sviluppo delle cartilagini che assicurano la crescita delle ossa lunghe, delle vertebre, delle ossa delle mani, della clavicola, della scapola, del bacino e della base del cranio.
Queste malattie rappresentano un gruppo molto complesso che può essere suddiviso in diversi sottogruppi.
Una prima divisione possibile è fra:
- letali,
- compatibili con la vita.
Delle forme letali non ci occuperemo perchè non hanno interesse clinico.
Il secondo gruppo è assai vario, ma pressochè tutte le forme morbose hanno in comune la bassa statura.
Avremo così due gruppi comprendenti:
- nanismi presenti alla nascita
- nanismi riscontrabili più tardivamente.
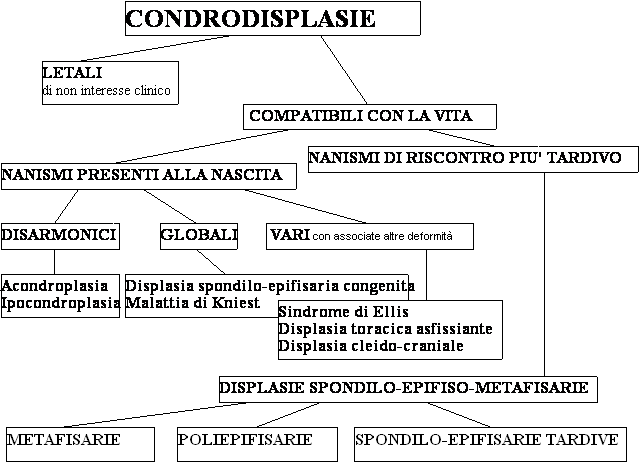
Ancora divisibili in:
1) nanismi disarmonici,
2) nanismi per insufficienza globale,
3) nanismi caratterizzati da altri motivi oltre al deficit staturale.
Al 1° gruppo appartiene la manifestazione più comune.
ACONDROPLASIA
Genotipica dominante.
Nel neonato si manifesta con l'associazione di un nanismo micromelico e di una deformità cranio-facciale.
La brevità degli arti è prevalente nei segmenti prossimali (omeri e femori); le mani sono tozze con uno scarto anormale fra il III e IV dito (mano a tridente).
Il cranio è voluminoso, con bozze frontali esagerate e radice del naso appiattita.
Nel neonato è presente ipotonia, responsabile di una cifosi dorsale accentuata.
Tale cifosi scompare nel corso dei primi 2-3 anni di vita, mentre è costante una iperlordosi lombare, secondaria a una flessione delle anche.
La crescita è molto lenta, con accentuazione della disarmonia fra tronco, pressochè normale, e arti.
L'aspetto del massiccio cranio-facciale è caratteristico, e via via più marcato negli anni.
L'esame radiografico dimostra una regione metafisaria delle ossa lunghe tozza, che contrasta con le epifisi che appaiono abbastanza conservate.
Le diafisi sono poco sviluppate.
Nell'insieme le ossa lunghe hanno un aspetto caricaturale.
Al rachide lombare si può evidenziare una brevità dei peduncoli, ristrettezza del canale rachideo, e concavità del limite vertebrale posteriore.
Al cranio si evidenziano dimensioni ridotte della base che contrastano con l'apparente eccessivo sviluppo della volta.
Il pronostico dell'acondroplasico è quello di un nanismo disarmonico con altezza che non supera i cm. 125 nei maschi (meno nelle femmine).
Sono pressochè costanti le deviazioni assiali degli arti.
TRATTAMENTO
Riassumibile:
1) correzione delle deviazioni assiali agli arti,
2) correzione delle deviazioni assiali e allungamento degli arti,
3) rieducazione funzionale per tonificare i muscoli del tronco e per la prevenzione delle rigidità articolari durante gli allungamenti.
IPOCONDROPLASIA
Simile alla precedente, ma con caratteristiche cliniche e radiografiche meno marcate, a riscontro più tardivo.
Al 2° gruppo appartengono la:
DISPLASIA SPONDILO-EPIFISARIA CONGENITA
L'iposomatismo di tipo globale è rilevabile alla nascita.
Durante l'età evolutiva si manifesta una grave cifosi o cifoscoliosi, a questa si accompagnano un torace carenato e una iperlordosi lombare.
Gli arti si presentano corti, con mani e piedi normali. Frequenti le limitazioni funzionali alle spalle e alle anche.
Si associa frequentemente una miopia.
MALATTIA DI KNIEST
Caratterizzata oltre che dal nanismo, da aumento di volume delle ginocchia e da diffuse limitazioni articolari.
Al 3° gruppo fanno riferimento quei nanismi molto rari a cui si associano malformazioni che interessano gli arti (polidattilia), il cuore, gli annessi cutanei, la gabbia toracica e le clavicole (sindrome di Ellis, displasia toracica asfissiante, displasia cleido-craniale).
NANISMI RISCONTRABILI PIÙ TARDIVAMENTE
E' un gruppo assai complesso, che può essere suddiviso in sottogruppi a secondo dell'interessamento predominante delle epifisi, delle metafisi o del rachide.
Alcune si presentano come forme ibride.
DISPLASIE METAFISARIE
Si manifestano intorno al 2° anno di vita per l'insufficienza staturale.
Colpiscono elettivamente gli arti, senza manifestazioni al viso.
L'insufficienza staturale è varia, ma di regola la taglia non supera i cm. 140.
RADIOLOGIA
Si apprezzano irregolarità del limite metafisario delle ossa lunghe e talvolta di quelle della mano.
Le epifisi sono ben sviluppate.
DISPLASIE POLIEPIFISARIE
Si manifestano fra i 2 e i 5 anni.
Il disturbo che attira l'attenzione dei genitori è la difficoltà nella deambulazione e lo scarso incremento staturale.
L'interessamento articolare è costante e in genere diffuso.
RADIOLOGIA
Si dimostrano gravi alterazioni epifisarie, con irregolarità morfologiche e strutturali.
Il prognostico è per una insufficienza staturale moderata, ma con un importante impegno articolare, causa di grave invalidità.
DISPLASIE SPONDILO-EPIFISARIE TARDIVE
Di riscontro abituale dopo il primo decennio di vita.
E' caratterizzata da un difetto di crescita del solo tronco, che si manifesta con la pubertà.
L'altezza, in età adulta, si aggira sui 145-150 cm.
RADIOLOGIA
L'esame radiografico mostra un appiattimento generalizzato dei corpi vertebrali.
TORCICOLLO MIOGENO CONGENITO
Il torcicollo miogeno congenito è determinato dalla retrazione unilaterale del muscolo sterno-cleido-mastoideo (S.C.M.) che impone una posizione asimmetrica della testa e del collo.
Il capo è così inclinato dal lato della retrazione muscolare e contemporaneamente ruotato dal lato opposto.
Si deve distinguere innanzi tutto:
Il torcicollo congenito posturale cha ha una frequenza del 2-3%. E' l'espressione di una mal posizione fetale, per contrasto con la parete uterina e ha una pressoché costante spontanea regressione dopo la nascita.
Il torcicollo miogeno congenito che si presenta in 3 forme cliniche differenti, ma espressione della medesima malattia.
1° forma: è talvolta presente alla nascita, ma più spesso si rivela nelle prime settimane di vita con una tumefazione, talvolta dolorosa, dello S.C.M. interessato, palpabile come una «oliva» nel contesto del muscolo. La posizione del capo del neonato è in rotazione opposta a detta tumefazione; può associarsi con una certa frequenza plagicefalia. Questa tumefazione tende alla regressione spontanea entro il 2°-6° mese di vita, senza lasciare, in più della metà dei casi, alcuna traccia successiva. Nei rimanenti si instaura un'autentica retrazione fibrosa del muscolo, con la comparsa, più o meno rapida, di un torcicollo nel corso dei primi mesi o anni di vita.
2° forma: si riscontra verso il 4° mese di vita, per un torcicollo con retrazione dello S.C.M., senza l'evidenza dell'«oliva». La plagicefalia è frequentemente associata. L'evoluzione è come per la precedente.
3° forma: si riscontra verso il 3°-4° anno di età e deriva evidentemente da una delle forme precedenti, passate più o meno inosservate. E' svelata dalla retrazione visibile e palpabile del muscolo dal lato della retrazione, con l'associazione di una asimmetria facciale che non è necessariamente proporzionale all'importanza o all'anzianità del torcicollo. Questa forma non ha mai la tendenza alla regressione spontanea. La deformità resta stabile o, più raramente, progressivamente si aggrava nel corso degli anni. In effetti, durante la crescita, lo scheletro facciale e rachideo, si deforma progressivamente, di modo ché, a fine crescita, l'eventuale correzione della retrazione, non riuscirà a correggere completamente la deformità.
Lo studio istologico dell'«oliva» non ha mai dimostrato la presenza di emosiderina, quale testimonianza di un pregresso ematoma, escludendo la possibile origine traumatica della lesione.
L'«oliva» risulta essere costituita unicamente da tessuto fibroso denso, organizzato, anche in prelievi bioptici eseguiti nei primi mesi di vita; la qualcosa rafforza l'idea che si tratti di un processo a inizio durante la vita fetale.
L'eziologia è di fatto sconosciuta; va ancora segnalato che esistono dei casi di familiarità.
Esame clinico
L'esame clinico è facile allorchè il bambino, passati i primi mesi, presenta inclinazione del capo dal lato della lesione e il mento guarda dal lato opposto, una asimmetria facciale più o meno evidente e una retrazione visibile e palpabile della retrazione dello S.C.M..
La motilità è ridotta.
Di fatto, l'esame clinico diventa difficile nei primi mesi di vita, quando il collo quasi non esiste, soprattutto qualora si palpi l'«oliva», che non sempre ha un prognostico ineluttabile verso la retrazione.
Diagnosi differenziale
E' abitualmente facile, tuttavia bisogna escludere:
una malformazione ossea del rachide cervicale; bisogna infatti sapere che queste si associano talvolta a una autentica retrazione muscolare;
una lesione infettiva o tumorale rachidea, midollare o cerebrale (che esordiscono frequentemente con un torcicollo); si tratta in questi casi, piuttosto di una contrattura generalizzata di difesa dei muscoli della regione che di retrazione localizzata, accompagnata costantemente da dolore importante persistente, cosa che non è presente, se non talvolta lieve e fugacemente nella forma miogena, e dai segni neurologici per le forme neurogene o dalla precedente infezione per le forme di interesse otorinolaringoiatrico;
una lesione traumatica conseguente a frattura o distorsione cervicale;
una eccezionale forma oculare, determinato dalla necessità di compensare con l'inclinazione del capo la mancata convergenza oculare e che solo l'esame oftalmologico specialistico sarà in grado di confermare
Trattamento
Nei primi mesi di vita si avvarrà delle manipolazioni correttive e dall'uso di un cuscino/collare a bandoliera di correzione. I risultati di tale trattamento sono a volte insufficienti.
Gli interventi di exeresi dell'«oliva» sono da proscrivere perchè non impediscono la secondaria retrazione muscolare oltre a essere causa di cicatrice inestetica.
Dopo i 2 anni di vita, allorché la deformità si è istaurata, si rende necessaria una chirurgia correttiva.
Essa consiste in una tenotomia a cielo aperto dei capi prossimali e distali dello S.C.M., seguita da un apparecchio gessato per 40 gg.
E' praticata, alternativamente, la plastica di allungamento a zeta del muscolo al III medio seguita o meno da immobilizzazione in apparecchio gessato, con risultati descritti buoni.
EZIOLOGIA
Lo sviluppo del piede dipende dall'insieme degli elementi osteoarticolari e neuromuscolari dell'arto inferiore fin dal periodo embrionario. Successivamente subisce l'effetto modellante della parete uterina e quindi del sistema nervoso, che, intorno all'anno di età, consente la deambulazione.
Non è affatto semplice trovare il confine fra la semplice deformazione fetale e una vera malformazione del piede.
ANATOMIA PATOLOGICA
Il calcagno ha un ruolo centrale nella funzione del piede; infatti questo, come blocco calcagno-piede, segue i movimenti del calcagno, che rulla, si impenna e gira sotto l'astragalo.
La caratteristica del vero P.T.C. è l'equino del retropiede che si accompagna a un tendine di Achille corto che accentua anche la componente di inversione, se il calcagno è in varo, o di eversione, se il calcagno è in valgo.
Le articolazioni mediotarsica e sottoastragalica vanno poi viste come una componente funzionale unica; sarà perciò illusorio pensare di correggere una deformità severa agendo su una sola componente.
ESAME CLINICO
L'esame clinico deve essere attento alla nascita, perché il rischio è di confondere una deformità lieve con un banale atteggiamento viziato.
Perciò il piede andrà più palpato che osservato, allo scopo di evidenziare quelle deformità che non si dimostrano riducibili alle manipolazioni.
Va ancora ricordato che il reperto di un P.T.C. è talvolta un segno di una malattia più generale, neurologica, distrofica, malformativa, o espressione di una sindrome posturale fetale, in cui, il reperto di una D.C.A. è l'evenienza più logica e comune.
ESAME RADIOLOGICO
Sarà complementare al clinico e si gioverà delle proiezioni ortogonali e dinamiche (massima flessione plantare e dorsale) per la valutazione del movimento del retropiede.
Caratterizzato dall'associazione di un equino-varo del retropiede e una lussazione interna irriducibile dello scafoide sulla testa dell'astragalo.
La frequenza è di 1-2 casi su 1000 abitanti, con una preferenza del sesso maschile (70%); i casi bil. sono circa la metà.
ANATOMIA PATOLOGICA
E' un piede deforme su 3 piani dello spazio: equino sul piano sagittale, supinato sul piano orizzontale, varo sul piano frontale.
L'astragalo è rigido in equino, il calcagno in equino-varo, lo scafoide in lussazione irriducibile sulla faccia interna del collo dell'astragalo.
Anche le parti molli partecipano alla deformità:
1) lo scafoide è ancorato al malleolo interno da un tenace tessuto fibroso e dall'inserzione del tendine, alquanto
ispessito e plantarizzato, del Tibiale Posteriore,
2) l'aponevrosi plantare è spesso ispessita e aderente al piano cutaneo,
3) il tendine di Achille è corto e ispessito, inserito sul solo versante interno del calcagno,
4) la capsula della Tibio-Tarsica è anch'essa ispessita e retratta posteriormente.
Volendo cercare una definizione di questo tipo di deformità, possiamo dire che il P.T.C. equino-varo-supinato è una deformità complessa e tridimensionale, organizzata intorno all'astragalo.
DIAGNOSI
E' facile fin dalla nascita, per la sua rilevanza clinica e l'esame radiografico abitualmente non aggiunge nessuna informazione.
TRATTAMENTO
Inizia nei primissimi giorni di vita e prevede trattamento riabilitativo modellante, con l'associazione di manipolazioni correttive e confezione di bendaggi funzionali correttivi (BFC).
Questi, di norma, vengono eseguiti dal medico o da fisioterapista esperto e rinnovati settimanalmente fino al 3°-4° mese di età.
Successivamente il trattamento riabilitativo sarà affidato all'uso di un tutore dinamico correttivo (TDC) e alle manipolazioni correttive.
Il TDC è portato costantemente durante la giornata e rimosso solo per la mobilizzazione (manipolazioni), fino all'inizio della marcia.
Dopo questa età, diventerà il presidio notturno.
BFC, a questa età, potranno essere ripetuti, al fine di migliorare la formazione degli schemi motori della marcia.
Ai 2 anni di età si introdurrà la calzatura correttiva.
Essa sarà rappresentata da una scarpa a pollacchetta, con forti posteriori bassi, flessibile, fornita di plantare con cuneo pronatore lungo tutto l'asse longitudinale.
Il trattamento chirurgico sarà indicato per quei piedi non completamente corretti, dopo il 4° mese di età o recidivati più tardivamente.
Esso comprende una serie di opportunità, che verranno utilizzate in associazione varia per quello che, alla fine, sarà un trattamento su misura:
Il trattamento chirurgico non è alternativo a quello riabilitativo, ma lo affianca per renderlo più efficace.
P. T. C. TALO-VALGO
Ne dobbiamo distinguere 2 forme:
1) P.T.C. talo-convesso
2) P.T.C. talo o talo-valgo.
1) P.T.C. TALO-CONVESSO
E' dato dall'associazione di un equino irriducibile del retropiede e di una lussazione dorsale dello scafoide, anch'essa irriducibile. E' una varietà veramente molto rara.
Frequentemente è bilaterale, ma comunque, il piede controlaterale, non è quasi mai di aspetto normale.
Le malformazioni associate sono frequenti e di preferenza neurologiche (50%) (artrogriposi, spina bifida, agenesia sacrale, diastematomelia).
In qualche caso l'E.M.G. dimostra una atrofia neurogena periferica diffusa.
ANATOMIA PATOLOGICA
Le caratteristiche della deformità sono date dall'equino-valgo del retropiede e dal talo dell'avampiede, entrambi irriducibili.
L'astragalo è equino irriducibile, con il collo orientato in dentro e in basso e determina la convessità del profilo anatomico.
Il calcagno è equino-valgo, dislocato all'indietro sotto l'astragalo.
Lo scafoide, di dimensioni ridotte, è lussato dorsalmente sulla testa dell'astragalo, in maniera irriducibile.
Il cuboide è alla sommità dell'arco esterno; è sublussato dorsalmente rispetto alla grande apofisi del calcagno e dopo l'anno di età, ipertrofizzandosi, fissa la deformità.
Il tendine di Achille, corto, si inserisce sul versante esterno dell'apofisi calcaneare.
La capsula della Tibio-Tarsica è posteriormente ispessita e retratta.
L'aponevrosi plantare, viceversa, è distesa.
Alla caviglia i tendini del Tibiale Posteriore e dei Peronei possono essere sublussati sulla faccia laterale dei malleoli.
L'esame radiografico sarà utile per dimostrare l'entità della fissità dell'equino del calcagno e dell'astragalo nelle proiezioni dinamiche.
DIAGNOSI
Alla nascita è facile solo quando il piede è veramente convesso, perché il talo è moderato, e soprattutto la salienza esagerata della testa dell'astragalo è facilmente palpabile sul bordo interno dell'arcata plantare.
Di fatto, però, l'aspetto è quello di un piede talo, e solo la palpazione del calcagno consente di apprezzare l'equino e il valgo del retropiede, che non esiste nel piede talo.
L'esame dinamico sorprende per la rigidità del piede; i movimenti si verificano sull'avampiede, senza correzione dell'equino del retropiede.
L'esame radiografico dimostrerà:
1) l'irriducibilità dell'equino dell'astragalo in flessione dorsale forzata,
2) l'irriducibilità della lussazione astragalo-scafoidea in flessione plantare forzata.
All'età della deambulazione la diagnosi diventa più facile per la scheletrizzazione del piede e l'inversione dell'arco plantare si fa lampante.
A questa età anche lo studio radiografico, per la maggiore maturazione scheletrica, è più dimostrativo.
TRATTAMENTO
-ORTOPEDICO- Alla nascita si cercherà con manipolazioni e BFC di correggere la mediotarsica, senza preoccuparsi dell'equino del retropiede. Solo successivamente si cercherà di ridurre l'equino del retropiede, portando il piede prima in supinazione, e poi, in lenta progressiva correzione dell'equino, preoccupandosi di sostenere la testa astragalica.
-CHIRURGICO- Sarà intrapreso fra i 4 mesi e l'anno di età. La liberazione posteriore sarà realizzata con un allungamento del tendine di Achille e una capsulotomia della Tibio-Tarsica, sopra e sottoastragalica. Si accompagnerà un tempo anteriore di liberazione e riposizionamento dello scafoide sulla testa astragalica (spesso questo atto necessita dell'allungamento del tendine del Tibiale Anteriore e trasposizione ventrale del Tibiale Posteriore).
I risultati di tale trattamento sono molto discussi.
2.1) PIEDE TALO-DIRETTO
E' una esagerazione della postura fetale, la cui evoluzione è spontaneamente favorevole.
Non si apprezzano rigidità, e la limitazione della flessione plantare, mai superiore ai 10°, è facilmente recuperabile con poche manipolazioni.
2.2) PIEDE TALO-VALGO
Ha il medesimo aspetto del precedente, con, in aggiunta, una pronazione dell'avampiede. Anche qui non vi sono rigidità e la prognosi è favorevole.
Il trattamento si limita, di norma, a manipolazioni correttive.
METATARSO VARO
E' assai frequente.
E' completamente diverso dal P.T.C. equino-varo-supinato; la deformità consiste in un varo o varo-supinazione dell'avampiede a livello della Lisfranc, con un retropiede assolutamente normale.
CLINICA
Alla nascita, da una osservazione plantare, si ha l'impressione di un piede caricaturale; il bordo esterno è convesso, con una salienza del profilo alla base del V metatarso e, nei quadri più eclatanti, una plicatura medio plantare interna.
La motilità della Tibio-Tarsica è completa.
La deformità resta correggibile per tutto il primo anno di vita.
TRATTAMENTO
Si avvale, nelle forme più lievi, delle sole manipolazioni correttive; di gessi o tutori ortopedici in quelle più gravi.
DEFINIZIONI
LUSSAZIONE: L'anca è lussata quando la testa femorale è completamente fuori della cavità acetabolare.
SUBLUSSAZIONE: L'anca è soltanto sublussata, quando la testa femorale non è normalmente posizionata nel fondo dell'acetabolo, ma è alquanto lateralizzata e risalita, senza essere tuttavia completamente uscita dalla cavità acetabolare.
DISPLASIA: Si tratta di un difetto morfologico dello sviluppo del cotile, rilevabile all'esame radiografico o ecografico.
EZIOLOGIA
Sono da considerarsi 2 ordini di fattori: genetici e meccanici.
I FATTORI GENETICI trovano giustificazione nella maggior frequenza nel sesso femminile, di una certa familiarità e di un certo contesto razziale e geografico.
I FATTORI MECCANICI sono preponderanti. Solo essi spiegano la frequenza della D.C.A. nelle primipare, nelle malposizioni fetali, nell'oligoidroamnios e nella sproporzione materno fetale, cause anche di deformità ai piedi, alle ginocchia, al cranio e al collo, e che spesso si accompagnano alla D.C.A.
Possiamo anche accettare un concetto più moderno di DEFORMAZIONE CONGENITA, contrapposto a MALFORMAZIONE CONGENITA.
Quest'ultima, assai rara, si formerebbe, per fattori genetici, molto precocemente, nel periodo embrionario dell'organogenesi: è sempre di difficile trattamento.
All'opposto, la deformazione congenita, di insorgenza più tardiva, in periodo fetale su un organo indenne, per fattori meccanici, è parzialmente o totalmente reversibile sotto l'effetto del trattamento di posizione, in abduzione.
PATOGENESI DELLA LUSSAZIONE DELL'ANCA
QUANDO LA LUSSAZIONE ?
IN UTERO, tranne le rarissime forme malformative dell'organogenesi, è impossibile nel periodo embrionario, mentre lo è durante tutto il periodo fetale e più ancora nell'ultimo trimestre di gestazione, in cui si instaura un conflitto meccanico materno-fetale, quale conseguenza del rapido aumento del volume fetale, della diminuzione della quantità del liquido amniotico, dell'aumento del tono della parete uterina, soprattutto nelle primipare, e della pressione del feto sul rachide lombare.
ALLA NASCITA è impossibile; infatti un traumatismo ostetrico determinerebbe un distacco epifisario prossimale del femore e non la lussazione.
DOPO LA NASCITA non c'è alcuna ragione valida per pensare che un'anca normale possa lussarsi (le lussazioni realmente acquisite sono di origine neurologica e si spiegano anch'esse con una postura lussante direttamente legata a un disequilibrio muscolare); al contrario è dimostrato l'inverso, cioè che le displasie del neonato non evolvono mai verso la lussazione, ma sovente guariscono spontaneamente.
COME SI INSTAURA LA LUSSAZIONE?
3 fattori conducono alla lussazione.
LA POSTURA LUSSANTE, data dalla combinazione di un'anca iperflessa e con una scarsa abduzione o una posizione addotta, con una rotazione esterna.
L'APPOGGIO DIRETTO DEL GRAN TROCANTERE su una postura lussante, determina facilmente una lussazione posteriore.
UNA LASSITA' CAPSULARE O DEL LIMBUS, eventualmente su base familiare e a maggior valenza nel sesso femminile, rappresenta un fattore di minor resistenza alle forze lussanti.
ANATOMIA PATOLOGICA
I quadri anatomopatologici che rientrano nella L.C.A. sono condizionati dal tipo, grado e tempo di durata della dislocazione.
La lussazione o sublussazione avviene quasi costantemente in senso postero-superiore o posteriore puro.
LA CAPSULA, distesa, forma una tasca erniaria (camera di lussazione), abitata dalla testa femorale, che, di norma, può essere riposizionata nel cotile e poi rilussata.
IL LEGAMENTO ROTONDO può apparire ipertrofico, atrofico e perfino assente.
LA CAVITA' ACETABOLARE è ovalare con asse maggiore dal polo postero-superiore a quello antero-inferiore, poco profonda, a volte appiattita.
Nei casi di lussazione di vecchia data (embrionaria o atipica), è reperibile, a fianco al cotile, un neocotile.
IL LIMBUS è deformato sia in fuori (estroflesso), sia in dentro (introflesso).
LA TESTA FEMORALE è in genere un po' appiattita.
IL COLLO FEMORALE dimostra, più frequentemente, un'antiversione accentuata.
STORIA NATURALE DELLA L.C.A
La lussazione si instaura durante la vita fetale per i motivi precedentemente esposti.
Alla nascita e successivamente, l'anca si libera dei fattori meccanici che hanno agito durante la vita uterina e tende spontaneamente alla guarigione.
Difficilmente, alla nascita, un'anca si presenta irriducibile, ma più facilmente come un'anca instabile (segno clinico dello scatto o quadri ecografici di anca in via di decentramento e decentrata).
Se l'instabilità persiste, la lussazione diventa progressivamente irriducibile.
Nella restante parte dei casi, l'anca si stabilizza, e l'evoluzione potrà essere verso la guarigione, o la displasia cotiloidea residua.
ESAME CLINICO
ALLA NASCITA
è difficile e dovrebbe essere affidato a mani esperte
Bisognerà valutare:
L'ABDUZIONE
I quadri clinici possibili sono 4:
1) abduzione completa e normale,
2) limitazione simmetrica, con ipertonia degli adduttori,
3) limitazione simmetrica, con retrazione e ipotonia degli adduttori,
4) bacino asimmetrico caratterizzato da limitazione unilaterale per ipertonia degli adduttori.
Gli ultimi tre gruppi sono bambini a rischio e circa la metà sono portatori di una D.C.A., bilaterale o monolaterale.
UNA POSTURA VIZIATA DEGLI ARTI INFERIORI, che deve essere rilevata nei primi giorni di vita e deve essere valutata quale testimonianza dell'insulto meccanico posturale.
L'INSTABILITA' dell'anca, che rappresenta il segno clinico più importante dell'anca lussata.
L'anca è detta instabile qualora la testa femorale
1) è fuoruscita
2) può uscire in parte o totalmente dalla cavità acetabolare.
Si distinguono perciò le anche:
1) lussate riducibili,
2) ridotte ma lussabili.
Le tecniche di ricerca dell'instabilità sono numerose, ricordiamo quelle più note, di Ortolani e di Barlow.
NEL LATTANTE
I segni clinici sono i medesimi e spesso più marcati. Talvolta l'anca diventa irriducibile.
DOPO L'INIZIO DELLA DEAMBULAZIONE
Il sintomo dominante diventa la zoppia, legata all'insufficienza del medio gluteo, con spostamento del tronco verso il lato lussato, in appoggio monopodalico (segno di Trandelemburg).
INDAGINI STRUMENTALI
L'indagine clinica, per quanto affinatasi negli anni e in mani esperte, non è in grado di dissipare tutti i dubbi. L'uso delle indagini strumentali mirano a risolvere queste incertezze.
INDAGINI ALLA NASCITA
Oggi è senz'altro l'ecografia l'esame più praticato, secondo la metodica messa a punto da Graf.
Laddove è stata istituita come screening di massa, ha dimostrato:
1) affidabilità,
2) i limiti dell'esame clinico (il 50% delle anche malate erano state negative all'esame clinico)
3) innoquità (esame ripetibile con frequenza laddove necessario).
INDAGINI NEL PRIMO ANNO DI VITA
L'esame ecografico mantiene un buon valore diagnostico fino all'anno di età, ma dopo il 5°-6° mese, l'esame radiografico diventa più significativo.
Alla nascita l'indagine radiografica, per la prevalente componente cartilaginea dell'anca, è poco utile.
Dopo il 4° mese di vita, invece, diventa l'esame preferibile per:
1) il confronto diretto dei due lati sullo stesso radiogramma,
2) una immagine più definita.
Il suo limite è l'uso di raggi ionizzanti e per questo motivo non è così disponibile a controlli ravvicinati nel bambino.
TRATTAMENTO
PRIMA DELL'ANNO DI ETA'
il trattamento è ortopedico e si avvale preferibilmente di apparecchi di abduzione delle anche (cuscini divaricatori per i più piccini, divaricatori di Milgramm per i bimbi sopra i 2 mesi).
DOPO L'ANNO DI ETA'
per la cura della lussazione, sono necessari ricoveri per trazione e riduzione atraumatica, vale a dire lenta e progressiva, con l'uso di letti appositamente studiati (lettini di Morell) o modificati, quindi, ottenuta la riduzione, immobilizzazione in apparecchi gessati per 6 mesi.
DOPO IL 2° ANNO DI ETA'
dopo la riduzione atraumatica o chirurgica, per la cura della displasia residua, il trattamento diventa chirurgico, con un'ampio ventaglio di interventi, così brevemente riassumibili:
DAI 2 AI 5 ANNI
le tettoplastiche e le osteotomie di centramento,
DAI 3 AGLI 8 ANNI
le osteotomie di bacino, tipo Salter,
DAI 6 AI 10-12 ANNI
le osteotomie di bacino tipo Still, Chiari, e le Buteè osteoplastic.
L'ARTROGRIPOSI
L'artrogriposi è una sindrome clinica congenita che colpisce preferibilmente gli arti, che associa a delle rigidità articolari di diverso grado, delle insufficienze o assenze dei muscoli e delle anomalie cutanee, rappresentate da una pelle dura e anelastica con assenza delle pieghe flessorie. La malattia non ha caratteristiche evolutive.
É molto rara, e la sua frequenza è assai diversa a seconda delle popolazioni considerate.
ANATOMIA PATOLOGICA
L'interessamento articolare
È rappresentato da una rigidità pressoché completa, con motilità residua di 3°-5°, non dolorosa, molto raramente in un settore funzionale.
La rigidità sarà in flessione o in estensione estrema.
Le superfici articolari sono, all'inizio conservate; la rigidità articolare dipende unicamente dalle strutture periferiche: fibrosi legamentosa e capsulo-sinoviale, retrazioni e fibrosi muscolare peri articolare.
Lentamente ma progressivamente, in conseguenza dell'impotenza funzionale, si produrrà un progressivo deterioramento delle superfici articolari, con progressiva distruzione e scomparsa delle rime articolare, fino all'anchilosi ossea, che si verifica abitualmente in epoca puberale.
L'interessamento muscolare e neuro muscolare
È rappresentato da :
una diminuzione di volume delle masse muscolari;
una immobilità talvolta completa, talaltra parziale, con una diminuzione della forza muscolare e soprattutto dell'elasticità, in conseguenza delle modificazioni profonde della fibra muscolare;
qualche piccolo movimento può esistere, allora l'attività dei muscoli sarà normale, senza turbe della conduzione e fibrillazione. Di fatto, durante gli interventi chirurgici si riscontrano talvolta muscoli apparentemente normali, talaltre e più spesso, non si ritrova il muscolo vero e proprio, ma le vestigia, rappresentate dall'aponeurosi fibrosa e da tessuto adiposo al posto di quello muscolare.
L'evoluzione: la capacità motoria rimane inalterata dopo la nascita
Per le fibre muscolari normali, si produrrà durante la crescita un progressivo aumento della forza, ma, siccome molti muscoli o fibre muscolari sono degenerate, nel complesso l'attività motoria sarà molto ridotta, da che il deterioramento funzionale potrà apparire progressivo senza una reale progressione della malattia.
Il danno muscolare o neuro-muscolare è esclusivamente motorio.
Non si riscontrano mai turbe della sensibilità superficiale.
Per contro possono essere presenti delle turbe trofiche quali l'ipersudorazione degli arti, del capo e del tronco.
L'interessamento cutaneo
È rappresentato da:
presenza di fossette con accollamento della cute al piano osseo in vicinanza della convessità delle grosse articolazioni;
la pelle appare dura e ispessita sui segmenti interessati;
il tessuto sottocutaneo è ispessito, fibroso, impedendo alla pelle di stirarsi e ripiegarsi come di norma;
il viso del neonato o del bimbo è assai caratteristico, arrotondato, senza rughe e inespressivo. Talvolta è presente un angioma della radice del naso.
Esami complementari ed eziopatologia
L'elettromiografia non dimostra caratteristiche specifiche. La sua importanza, nelle forme dubbie, servirà a escludere affezioni neurologiche con aspetto clinico simile.
Il dosaggio degli enzimi muscolari sono pressoché normali. Anche qui ha valore solo per la diagnosi differenziale con malattie neuro-muscolari vicine.
Lo studio anatomopatologico/istologico e istoenzimatologico ha permesso di riscontrare, in alcuni casi, un danno prevalentemente neurologico, interessante anche le corna anteriori del midollo spinale.
Di conseguenza un buon numero di Ricercatori hanno concluso per una distrofia muscolare congenita di tipo embrionario.
L'eziopatologia, in effetti, più correntemente ammessa, è quella di un danno neuro muscolare o muscolare fetale molto precoce o embrionario del 2° mese di gestazione. Non è stata evidenziata per la malattia alcuna familiarità.
Principi del trattamento.
Questo sarà diverso a secondo delle localizzazioni, e prevederà un trattamento con gessi o bendaggi adesivi correttivi nei primi giorni di vita, per migliorare le posizioni viziate.
All'arto superiore si cercherà di portare la mano, il gomito e la spalla in posizione funzionale per afferrare gli oggetti su un piano di lavoro.
All'arto inferiore si cercherà di mantenere l'estensione del ginocchio e un corretto atteggiamento di appoggio del piede.
I risultati di questo trattamento saranno condizionati dalla qualità della rigidità presente alla nascita.
Sarà possibile successivamente completare la correzione con interventi di rilassamento sulle parti molli e di allungamento di tendini.
La funzione residua potrà essere ulteriormente migliorata con esercizi di riabilitazione attivi e passivi e l'uso di tutori ortopedici.
A fine crescita, deformità residue, potranno giovarsi di interventi sullo scheletro, consistenti in osteotomie direzionali, artrodesi modellanti e resezioni articolari.
Le deformità del tronco, che potranno essere le più diverse (iperlordosi, cifosi, scoliosi e cifoscoliosi), si gioveranno da subito di manovre di elongazione vertebrale e manipolazioni, poi di correzioni in busti di gesso e corsetti ortopedici e quindi, in età più avanzata, di correzione e stabilizzazione chirurgica.
Un bambino è affetto da piede piatto-valgo statico quando non è in grado di mantenere sollevato l'arco plantare sotto carico.
La riducibilità lo distingue dalle altre forme di piede piatto.
I motivi che convincono i genitori a portare il figlio al controllo specialistico sono in genere:
1) una camminata poco elegante,
2) l'usura anomala e rapida delle calzature,
3) una certa stancabilità nella deambulazione, senza un vero sintomo doloroso.
QUADRO CLINICO
E' caratterizzato dalla triade:
1) calcagno valgo oltre i 10°,
2) abbassamento del profilo interno del piede,
3) allargamento e valgismo dell'avampiede, con metatarsi a ventaglio.
BILANCIO DINAMICO
E' caratterizzato anch'esso dalla triade:
1) riducibilità del piattismo in assenza di appoggio,
2) incapacità di sollevare, in carico, il I metatarso,
3) rotazione interna della tibia, in carico, con fron talizzazione dei malleoli.
BILANCIO QUANTITATIVO
E' praticato attraverso lo studio dell'impronta plantare. Lo strumento più usato è il podoscopio, perché più semplice e di immediata lettura. Il suo maggior difetto è l'impossibilità di conservare l'immagine. E' comunque facile sopperire a tale carenza praticando una documentazione fotografica.
Dall'impronta plantare è possibile giungere a una classificazione del piede piatto.
Si tiene conto del rapporto quantitativo fra l'istmo e i talloni, anteriore e posteriore.
I° GRADO: l'istmo resta concavo, anche se allargato.
II° GRADO: l'istmo diventa rettilineo.
III° GRADO: l'istmo diventa convesso.
RADIOLOGIA
Lo studio avviene in carico, con proiezioni:
1) dorso-plantari,
2) latero-mediali,
3) antero-posteriori delle Tibio-Astragalo-Calcaneari.
La 1) consente lo studio e la misurazione dell'angolo Astragalo-Calcaneare, che è aumentato.
La 2), la più significativa, permette di verificare il buon allineamento fra Astragalo-Scafoide-I°Cuneiforme-I°Metatarso (linea di Meary).
La 3) consente la misurazione dell'angolo di valgismo Tibio-Calcaneare.
PROGNOSI
E' di norma favorevole.
Sono segni di benignità la riducibilità della deformità in assenza di carico e la correzione, sotto carico, del difetto, con la correzione dell'asse calcaneare.
TRATTAMENTO ORTOPEDICO
Almeno fino agli 8-9 anni di età è possibile, con il trattamento attivo e le ortesi, un progressivo miglioramento; per questo motivo le opzioni chirurgiche non sono prese in considerazione nella prima infanzia.
I fattori da prendere in considerazione sono:
L'età del bambino
La gravità della deformità
L'anomalo consumo delle calzature
La sintomatologia riferita
L'associazione al ginocchio valgo
L'età del bambino
Fino al 3° anno di età, abbiamo detto, può essere difficile l'identificazione di un piede piatto essenziale: fino a questa età è giustificata una vigile attesa.
Dopo tale età saranno gli altri fattori quelli decisivi
La gravità della deformità
Nel I° si dovrà mirare al rinforzo del tono muscolare, consigliando attività ludico motoria, deambulazione scalza su superfici sconnesse (sabbia, scogli, ghiaia) e/o esercizi mirati (deambulazione tacco-punta, sul bordo esterno, esercizi di prensione), sempre sotto forma di attività ludica.
Sono da evitare le calzature con costruzione a mocassino.
Nel II° potrà essere consigliata anche una fornitura ortopedica adeguata, soprattutto nel periodo invernale, quando l'attività motoria è necessariamente ridotta dai fattori climatici.
Nel III° la calzatura correttiva è sempre consigliabile, così come l'attività ludico motoria.
L'anomalo consumo delle calzature
Va valutata, prima di tutto le caratteristiche costruttive delle calzature:
- se le calzature sono adeguate, cioè con contrafforti al calcagno, è la prova della pronazione forzata del piede, oltre il limite fisiologico. Giustificano il trattamento ortopedico;
- se le calzature sono inadeguate (a mocassino), l'uso di scarpe "fisiologiche", cioè fornite dei contrafforti calcaneari e a suola flessibile, risolverà il problema.
La sintomatologia riferita
Potrà essere di tipo soggettivo o oggettivo
Sintomatologia soggettiva
Potrà essere caratterizzata da:
facile affaticamento
presenza di dolore, ma più spesso sensazione di tensione ai piedi e/o alle gambe.
Sono sintomi di uno scompenso funzionale che, in genere, l'uso di una calzatura correttiva risolve.
Sintomatologia oggettiva
Sarà l'osservazione di:
un carico saltuario sul bordo esterno del piede
una deambulazione a piedi addotti o abdotti.
Anche in questi casi una calzatura correttiva migliorerà l'appoggio del piede e l'efficacia della marcia.
L'associazione al ginocchio valgo
È possibile l'associazione di un valgismo delle ginocchia al piede piatto-valgo.
Nel qual caso i due difetti si influenzano vicendevolmente negativamente.
L'uso della calzatura correttiva sarà perciò consigliata.
LE ORTESI
Abbiamo parlato ripetutamente delle calzature.
Esiste molta confusione sulle calzature nell'infanzia, perciò sarà bene definire quali devono essere le caratteristiche che queste devono avere.
Le calzature, per essere definite "fisiologiche" e cioè che rispettano la biomeccanica del piede, dovranno essere costruite, preferibilmente in materiali biologici (pelle), che permettono la traspirazione. La suola, flessibile, permetterà un migliore adattamento della pianta del piede al suolo. Posteriormente la presenza dei contrafforti, assicurerà una buona aderenza della calzatura al calcagno; questi dovranno essere a tenuta calcaneare, senza mai superare i malleoli, per non limitare la motilità della tibio-tarsica.
Per la scelta della misura, poi, bisogna sapere che il piede infantili necessita di spazi di movimento e di crescita, per cui la calzatura dovrà essere larga di forma e sufficientemente lunga (abitualmente la misura del polpastrello del pollice oltre la punta dell'alluce).
La calzatura correttiva dovrà rispettare le caratteristiche enunciate.
In essa verrà inserito un plantare provvisto di un cuneo posteriore mediale-varizzante (A) ed, eventualmente, un secondo cuneo metatarsale esterno-pronatore (B).
TRATTAMENTO CHIRURGICO
Dopo gli otto anni di età le deformità vanno rapidamente a strutturarsi, perdendo la possibilità di correggersi.; perciò se persiste una importante pronazione del calcagno (piede piatto-valgo o piede cavo valgo), dovrà essere presa in considerazione l'opzione chirurgica.
Le tecniche chirurgiche oggi più usate a questa età sono:
il "Calcaneo Stop"
la vite nel seno del tarso "Vite di Giannini", "Kalix" ecc.
Sono entrambi interventi poco aggressivi, che migliorano l'appoggio del piede, senza limitarne la funzionalità.
PIEDE PIATTO-VALGO STATICO DELL'ADOLESCENTE
La semeiologia è la medesima, ma possono verificarsi fatti nuovi, probabilmente come conseguenza di una maggiore richiesta funzionale.
DOLORE ALLA FATICA, spesso come conseguenza di attività sportiva.
Il dolore ha sedi caratteristiche:
1) dolori in sede sotto malleolare, interna o esterna, quale segno di tensione dei legamenti collaterali,
2) dolori sul decorso e spesso elettivo sull'inserzione allo scafoide del tendine del Tibiale Posteriore, ove è talvolta osservabile un distacco inserzionale di dubbia interpretazione.
3) in un piccolo numero di casi si può instaurare una sintomatologia dolorosa con contrattura (piede piatto
contratturato); l'eziologia è spesso riconducibile a una sinostosi congenita che può interessare calcagno e scafoide (più frequentemente) o astragalo e calcagno.
TRATTAMENTO
ORTOPEDICO
Il piede piatto doloroso dell'adolescente si gioverà di plantari modellati e di sostegno, oltre al riposo.
Il piede piatto contratturato dimostrerà vantaggio dal riposo, con immobilizzazione in gesso per 15-20 gg.
CHIRURGICO
Comprende diverse opzioni:
1) operazione di Grice (artrodesi astragalo-calcaneare extrarticolare),
2) operazione di Viladot, vite di Giannini, Kalix (anchilosi extrarticolare astragalo-calcaneare),
3) operazione di calcagno-stop + eventuale "plastica mediale",
4) osteotomia varizzante del calcagno.
Il termine non deve far pensare a una malformazione; esso è PIATTO E NORMALE.
CLINICA
La familiarità è indiscussa.
Sembra un piede troppo largo e lungo per l'età del bambino; la gamba pare piantarsi perpendicolarmente nella massa del piede come dentro una pantofola!
Non vi è alcun accenno della volta plantare.
La deambulazione è antiestetica, ma senza alcun disturbo funzionale.
Il piattismo plantare non è riducibile in scarico e, soprattutto, non è apprezzabile il valgismo del calcagno.
Per questo motivo potrebbe meritare anche il nome di piede piatto a calcagno orizzontale.
Questa è la caratteristica essenziale di questo tipo di piede, che è piatto e resterà piatto, dalla nascita alla morte.
L'impronta plantare è quella tipica di un piede piatto di III° grado.
RADIOLOGIA
Sul clichè latero-mediale, il calcagno avrà, nel bambino, un aspetto a sabot, per il risalimento della grande tuberosità.
Tale immagine, da sola, è sufficiente per la diagnosi.
PROGNOSI
La prognosi funzionale è buona.
TRATTAMENTO
E' consigliata l'astensione da qualsiasi iniziativa terapeutica.
Prende il nome dei primi tre ricercatori che lo descrissero simultaneamente a inizio di questo secolo, in America, in Germania e in Francia.
E' interpretato come una necrosi ischemica dell'epifisi femorale prossimale e rappresenta, nel bambino, l'equivalente dell'osteonecrosi idiopatica della testa del femore dell'adulto. La differenza con quest'ultima è che influisce sui meccanismi abbastanza complessi di crescita dell'estremo prossimale del femore.
La diretta conseguenza è una evoluzione assai variabile che comprende, nelle forme più benigne, un completo rimodellamento articolare, e, in quelle più maligne, una deformità irreversibile (coxa plana), foriera di lesioni degenerative in età adulta.
Dal punto di vista Rxgrafico, si distinguono 3 fasi (condensazione, frammentazione, riparazione), ma dal punto di vista clinico, altre 2 fasi sono determinanti per la prognosi: il periodo preradiologico e quello del rimodellamento.
Quest'ultimo sarà tanto migliore, quanto più giovane è l'età del bambino.
Il trattamento, fino a una decina di anni fa basato sullo scarico articolare, oggi si avvale di diverse opzioni, sia ortopediche che chirurgiche .
E' indispensabile per comprendere l'evoluzione dell'osteocondrosi dell'estremità superiore del femore.
Il gran trocantere e poi il piccolo trocantere sono sede di cartilagini di crescita sferiche proprie, che daranno luogo, rispettivamente, a un nucleo di ossificazione apofisario.
Sono questi 3 settori di crescita, che sviluppandosi armoniosamente, determinano la morfologia dell'estremità superiore del femore
La testa femorale è costituita da un nucleo epifisario circondato da una cartilagine di crescita sferica a sua volta avvolta da quella articolare.
Il collo femorale si allunga per l'attività peculiare della cartilagine di coniugazione epifisio-metafisaria a "L", con 3 settori di crescita.
A loro volta essi sono condizionati da fattori vascolari e meccanici.
La vascolarizzazione è garantita dalle arterie circonflesse. Quella posteriore è la principale poiché assicura la vitalità del nucleo epifisario e della zona germinale della cartilagine di coniugazione, responsabile dello sviluppo della metafisi.
La cartilagine articolare e la calotta superficiale della cartilagine di crescita, traggono nutrimento dal liquido sinoviale articolare.
Queste strutture sono poi sollecitate dalle forze meccaniche (pressione, peso, muscoli) che agiscono sull'anca.
Qui la cavità cotiloidea gioca un ruolo importante come mola emisferica per la ripartizione regolare delle pressioni sulla testa femorale. Ne consegue la necessità di una assoluta sfericità della testa femorale.
ANATOMIA PATOLOGICA
-STADIO INIZIALE
Si caratterizza per una necrosi avascolare più o meno estesa. Molto rapidamente si osservano tentativi di rivacolarizzazione e, soprattutto, fenomeni di necrosi iterativi.
-STADIO INTERMEDIO
Si caratterizza per una spiccata riparazione con proliferazione di tessuto connettivo riccamente vascolarizzato, organizzazione di focolai di riassorbimento osseo, ben presto rimpiazzato da osso nuovo e immaturo e, in fine, una ripresa dell'ossificazione encondrale.
Parallelamente a questi segni positivi di riparazione,si possono osservare ancora dei segni inquietanti, quali: alterazioni metafisarie caratterizzate dall'allargamento della stessa, frattura laterale dell'epifisi, ispessimento e irregolarità della cartilagine di coniugazione.
Durante tutta questa fase, la plasticità della testa la espone a un appiattimento più o meno importante.
-STADIO TARDIVO
E' caratterizzato dalla riapparizione del tessuto osseo spongioso normale, che progressivamente si riappropia dell'epifisi. Tuttavia, anche in questo stadio possono ancora trovarsi aree necrotiche e di tessuto connettivo o cartilagineo.
EZIOPATOGENESI
Non è ancora ben chiarita.
TRE FATTORI sono in qualche modo i colpevoli della lesione.
s VASCOLARE
E' il più noto, ma nè il meccanismo nè la causa scatenante sono certe. Le ipotesi principali sono:
- una embolia arteriosa,
- una trombosi in situ,
- una compressione dei vasi nutritivi causata dal tendine dell'Ileo-Psoas o dell'Otturatore esterno o da microtraumatismi ripetuti o, per finire, da un meccanismo di "stantuffo" articolare.
s MECCANICO
Sovente invocato, per l'associazione di microtraumi vascolari e cartilaginei. In appoggio a questa ipotesi si deve considerare la particolare vivacità di questi bambini. Anche il sesso, in prevalenza maschile, come per la traumatologia, è ulteriore elemento probatorio.
s CONDROPATICO
Proposto da Duriez, come una patologia generalizzata e latente di tutte le strutture cartilaginee, coinvolgente anche la componente vascolare. Questa teoria troverebbe sostegno nel riscontro frequente di un ritardo della maturazione scheletrica e di anomalie minori osservabili sull'anca sana controlaterale.
In conclusione, il substrato della malattia sarebbe un terreno predisposto (condropatia) su cui agirebbero fattori scatenanti accidentali (vascolari, traumatici o altri).
QUADRO CLINICO
E' assai poco significativo; due dati possono avere un certo significato:
- una zoppia, influenzata dalla fatica e dal riposo, sovente discreta,
- dei dolori riferiti all'inguine, alla coscia o al ginocchio, incostante nel bambino più piccolo.
L'insorgenza di questa sintomatologia può essere progressiva o acuta indifferentemente. Sarà significativo il riscontro di un episodio simile, risoltosi spontaneamente, nelle settimane o mesi precedenti; ma il quadro clinico potrà essere del tutto muto e la diagnosi porsi per una indagine Rxgrafica del bacino praticata per altri motivi.
L'esame obiettivo dimostrerà sovente una limitazione moderata dei movimenti dell'anca, in particolare dell'abduzione e dell'intrarotazione. L'ipotonotrofismo dei muscoli della coscia sarà presente solo nelle forme inveterate. Le condizioni generali saranno sempre ottime.
QUADRO RADIOGRAFICO
E' differente nei vari stadi della malattia.
I PRIMI SEGNI radiografici sono vaghi ma non sfuggiranno a un occhio esperto:
- un arresto della crescita del nucleo epifisario,
- un minimo appiattimento supero-esterno del nucleo,
- una immagine a colpo d'unghia sotto corticale, spesso distinguibile solo nella proiezione assiale (denominata frattura subcondrale),
- una mancanza di omogeneità del nucleo epifisario,
- una banda chiara metafisaria,
- un allargamento dell'interlinea articolare, talvolta solo nella parte mediale.
LA FASE DELLA CONDENSAZIONE si caratterizza per l'addensamento del nucleo epifisario, quasi sempre associato a un'appiattimento globale. Il termine di "necrosi" associato a questo stadio è impropio, infatti la condensazione è possibile solo per l'avvento della rivascolarizzazione con la formazione di osso nuovo che si viene a sovrapporre a quello necrotico.
LA FASE DELLA FRAMMENTAZIONE si caratterizza per uno spezzettamento apparente del nucleo e per un rimaneggiamento della metafisi femorale. Si osservano delle immagini di disorganizzazione della trama ossea che creano l'impressione di un peggioramento della malattia. L'estensione della frammentazione è vario, potendo estendersi a tutta l'epifisi.
LA FASE DELLA RICOSTRUZIONE O DELLA RIPARAZIONE ha inizio virtualmente quando tutte le zone dense sono scomparse e contemporaneamente si manifesta la neo-ossificazione periferica del nucleo epifisario. Ha una durata molto lunga e termina solo con la completa ricostruzione dell'epifisi.
LA FASE DEL RIMODELLAMENTO dura fino alla fine della crescita e permette di migliorare ulteriormente la congruenza articolare con un reciproco rimodellamento del cotile con la neoepifisi femorale.
LA FASE DELLE SEQUELE, alla fine della crescita, determinata dalla morfologia articolare. La valutazione della sfericità della testa femorale coi i cerchi concentrici distanziati di 2 mm. di Mose permette di definire:
- una testa sferica perfetta, perfettamente adattata a un cerchio,
- una testa regolare che si inscrive entro lo spazio di 2 cerchi,
- una testa irregolare, negli altri casi.
Questo pare essere il metodo di valutazione delle sequele più utile, fra tutti quelli proposti.
CLASSIFICAZIOINE DI CATTERALL
Si basa sulla topografia ed estensione Rxgrafica della lesione epifisaria. Individua 4 gruppi e 5 segni di testa a rischio.
I GRADO: la lesione è localizzata alla parte anteriore dell'epifisi senza immagini di sequestri; è molto rara.
II GRADO: la lesione interessa un po' di più della metà anteriore dell'epifisi. Sull'immagine in A.P. si manifesta con un sequestro ovalare circondato da 2 zone sane, interna e esterna, mentre sull'assiale, il sequestro è separato dalla parte sana posteriore da un'immagine chiara, tipicamente a V.
III grado
III
GRADO: la lesione interessa l'epifisi quasi
totalmente, essendo preservata solo una piccola parte posteriore. La
cartilagine di coniugazione è frequentemente colpita, la metafisi
costantemente; si apprezza spesso un allargamento del collo.
IV GRADO: la lesione si manifesta su tutta l'epifisi, sia sulla proiezione di faccia che di profilo. L'interessamento del collo e della cartilagine è costante, e, soprattutto quest'ultima, condiziona la prognosi, che non è abitualmente buona.
I segni di TESTA A RISCHIO sono:
- SEGNO DI GAGE o immagine chiara epifisaria esterna, il suo significato è discusso,
- CALCIFICAZIONE ESTERNA o piccola opacità situata sulla parte esterna dell'epifisi, vicino alla cartilagine di coniugazione,
- SUBLUSSAZIONE DELLA TESTA, o lateralizzazione, è un segno molto peggiorativo, significativo di un appiattimento della testafemorale che guadagna in larghezza quello che perde in altezza,
- ORIZZONTALIZZAZIONE DELLA CARTILAGINE METAFISARIA,assai rara,
- REAZIONE METAFISARIA importante, conseguenza di un interessamento della cartilagine metafisaria.
L'interesse della classificazione di Catterall è di permettere una valutazione prognostica, il suo inconveniente è di dover aspettare 4 - 6 mesi di evoluzione della malattia prima di poter definire il gruppo di appartenenza. Essa permette soprattutto un'analisi retrospettiva e quindi uno studio più rigoroso dei risultati.
Più recentemente, Salter e Thompson, hanno proposto una classificazione più semplice, secondo l'estensione della frattura subcondrale sul clichè di profilo.
GRUPPO A, quando la frattura interessa meno della metà della testa.
GRUPPO B, quando la frattura interessa una porzione più estesa.
Il vantaggio di questa classificazione è di essere valida fin dall'esordio della malattia.
ALTRE METODICHE DI INDAGINE
L'ARTROGRAFIA ha indicazioni ristrette. Consente di riconoscere la morfologia reale della testa femorale e in particolare si dimostra utile prima di un atto chirurgico. Con un clichè in abduzione consente di verificare il ricentramento dell'epifisi e il grado di copertura dell'acetabolo.
La SCINTIGRAFIA permette di evidenziare l'ischemia epifisaria precocemente, in fase preradiologica; in realtà non è sempre così, e la positività di tale esame dovrà essere nei mesi successivi convalidata dalla documentazione Rxgrafica.
La TAC è utilizzata da certuni per valutare esattamente l'estensione della necrosi e guidare il trattamento.
La RMN è l'esame più attendibile, fin nello stadio precoce. Definisce immagini estremamente dettagliate, definendo con precisione i limiti della zona necrotica.
Anche i fenomeni riparativi sono apprezzabili fin dall'inizio.
Purtroppo l'esame richiede un'assoluta immobilità per alcuni minuti e questa necessità obbliga, nei bimbi più piccoli, alla narcosi. Questo è l'unico vero limite all'indagine.
L'ECOGRAFIA dell'anca è in grado di dimostrare il versamento sinoviale endoarticolare e, assai più precocemente della radiologia, le alterazioni della superficie articolare. Per l'assenza di radiazioni ionizzanti e per i bassi costi, è facilmente ripetibile.
MANIFESTAZIONI CLINICHE
Sono state individuati diversi quadri clinici.
LE FORME DEI BAMBINI SOTTO I 4 - 5 ANNI. La prognosi è abitualmente favorevole, qualsiasi sia l'atteggiamento terapeutico. La diagnosi differenziale va posta con la Sindrome di Meyer, ove, però, l'evoluzione è verso un progressivo miglioramento, senza l'andamento tipicamente ciclico del morbo di L.C.P.
LE FORME ABORTIVE E LE IRREGOLARITA' COSIDDETTE FISIOLOGICHE. Si tratta di forme che colpiscono assai parzialmente il nucleo epifisario e che sono scoperte casualmente durante una indagine Rxgrafica.
LE FORME BILATERALI, relativamente frequenti (12%). Pongono soprattutto un problema diagnostico differenziale con le condrodistrofie, soprattutto quando l'esordio è simultaneo e simmetrico.
L'OSTEOCONDRITE DISSECANTE, che può manifestarsi durante il decorso del morbo di LCP e che abitualmente non è riconosciuto se non dopo diversi anni. Talvolta è asintomatico, talaltro causa di blocchi o limitazioni articolari da corpo estraneo. Di rado e solo per questa ultima evenienza, può necessitare di trattamento chirurgico.
EVOLUZIONE NELL'ADULTO
Se alla fine della crescita residua un testa non più sferica, l'evoluzione sarà verso l'artrosi.
Comunque questa sopraggiungerà tardivamente (sopra i 50 anni) nonostante l'evidenza del danno morfologico.
DIAGNOSI DIFFERENZIALE
LE OSTEONECROSI SECONDARIE (esiti di trattamento della LCA o di frattura del collo del femore o di trapianto renale o in corso di una emopatia) hanno degli aspetti radiologici diversi.
LE CONDRODISTROFIE dovranno essere considerate di fronte a un quadro bilaterale e simmetrico, soprattutto se con interessamento dei cotili. Si provvederà, allora, a una ricerca sui familiari e a indagini Rxgrafiche complementari (cranio, rachide,mano).
LA SINOVITE TRANSITORIA DELL'ANCA è un'entità clinica comportante rapidamente zoppia o dolore con rifiuto della marcia, limitazione dei movimenti più o meno vistosi, senza segni clinici generali. L'esame Rxgrafico sarà assolutamente negativo. L'evoluzione è risolutiva sia spontaneamente, sia dopo qualche giorno di riposo a letto con trazione. Sarà quindi solamente questa caratteristica rapidamente risolutiva a distinguerla da un morbo di LCP in fase iniziale. Per le forme più persistenti o recidivanti, sarà l'esame scintigrafico, generalmente caratterizzato da una ipercaptazione, a escludere una osteocondrosi.
TRATTAMENTO
Il trattamento, pena la sua inutilità, deve mirare a diminuire le sequele e/o a ridurre i tempi di evoluzione della malattia.
Di fronte a una evoluzione spontanea verso la riparazione della testa femorale, il trattamento, oltre a minimizzare o eliminare le sequele, si proporrà altri obiettivi:
- preservare la motilità dell'anca, evitando l'immobilizzazione che non favorisce la nutrizione della cartilagine articolare,
- scaricare l'anca durante il periodo del rammollimento cefalico, causa dello schiacciamento e di perdita della sfericità,
- ricentrare al meglio la testa del femore nell'acetabolo, che si comporterà da modellatore.
METODICHE
Il TRATTAMENTO ORTOPEDICO ha un ruolo importante, e propone metodiche che consentono la deambulazione o che costringono il bimbo a letto.
I METODI CHE CONSENTONO LA DEAMBULAZIONE sono i meglio accetti. Attualmente l'ortesi che pare ottenere i migliori risultati e, contemporaneamente ben sopportato dai bambini, è il tutore in abduzione detto di ATLANTA. E' di facile uso e consente una marcia relativamente disinvolta.
I METODI CHE COSTRINGONO AL LETTO, si basano su una trazione continua in moderata abduzione delle anche. L'impatto psicologico sul bambino è facilmente immaginabile e questo, ne limita molto l'uso.
IL TRATTAMENTO CHIRURGICO si prefigge anch'esso una migliore centrazione dell'anca, consentendo inoltre una più rapida evoluzione della malattia e una più prolungata azione dei fattori meccanici del rimodellamento.
Si avvale di osteotomie femorali e di bacino.
L'OSTEOTOMIA FEMORALE DI VARIZZAZIONE ottiene una buona copertura della testa femorale, al prezzo di un modesto accorciamento e di una varizzazione dell'angolo cervico-diafisario. Sarà perciò da evitare ove sono manifesti segni di sofferenza della cartilagine metafisaria.
L'OSTEOTOMIA DI BACINO SECONDO SALTER (o tripla osteotomia se necessario), consente, al prezzo si un intervento più indaginoso, di ottenere una buona copertura senza alterare il fisiologico angolo cervico-diafisario e con un modesto allungamento.
LA DURATA DEL TRATTAMENTO è di diversi mesi (fino a 2 anni), e per questo vanno presi tutti quegli accorgimenti che consentano al bambino una vita relazionale il più normale possibile per tutto il periodo.
INDICAZIONI TERAPEUTICHE
L'atteggiamento deve essere il più eclettico possibile, tenendo conto dell'età del bambino, della situazione familiare, della vivacità del bambino e della gravità della malattia: per questo non esiste il trattamento standard del Morbo di L.C.P.
- L'età inferiore ai 5 anni comporta una prognosi generalmente buona anche in assenza di trattamento e, quindi, anche la semplice osservazione nel tempo può rivelarsi sufficiente.
Viceversa, un'età superiore ai 9 anni è foriera di cattivi risultati, qualsiasi cosa si faccia.
- La situazione familiare rappresenta un fattore da tener conto nel trattamento ortopedico, ove la osservanza delle cure è affidata ai familiari. Una indicazione chirurgica, in alcuni casi, può rappresentare una scelta tattica.
- La eccessiva vivacità del bambino comporta le stesse scelte.
- La gravità della malattia, testimoniata dal quadro Rx grafico secondo Catterall, in stadio e grado, consentirà programmi terapeutici diversi; agli stadi iniziali generalmente è consentito un comportamento di attesa, mentre in quelli più tardivi, l'impostazione terapeutica è definitiva.
L'osteomielite ematogena ha una spiccata predilezione dell'età pediatrica (85%).
Colpisce prevalentemente le regioni metafisarie.
Questa localizzazione è giustificata dalla topografia della vascolarizzazione dell'osso, più ricca a tale livello.
L'assenza di comunicazione vascolare fra metafisi ed epifisi nell'età pediatrica per l'interposizione della cartilagine di accrescimento, rappresenta un fattore di protezione per le articolazioni, a eccezione di quelle ove le metafisi sono intracapsulari, come l'anca e la spalla. L'infiammazione, localmente, può diffondersi e raggiungere il periostio, scollarlo e creare sacche sottoperiostee (ascessi sottoperiostei), superarlo e diffondersi nei tessuti molli, per affiorare alla cute (fistolizzazione). L'ipertensione flogistica dell'osso è la causa dei fenomeni di ostruzione vascolare, sia venosa che arteriosa, che conducono alla necrosi ossea, con la formazione di sequestri osteonecrotici, che non sempre sono riassorbiti.
L'età più colpita è quella dei 6 anni, con predilezione del sesso maschile.
Spesso un trauma, provocando un'occlusione vascolare, con conseguente anossia e stasi venosa, rappresenta il fattore favorente l'insorgere di una osteite acuta.
Il focolaio di infezione primario, quello da cui arrivano all'osso i germi responsabili dell'osteomielite, è spesso dell'apparato respiratorio (¼ dei casi).
Non sono tuttavia assolutamente rari quei casi ove tale focolaio non è rilevabile, e l'osteite appare essere un'infezione primitiva dell'osso.
CLINICA
I segni clinici saranno dominati dalla febbre, talvolta elevata, dal dolore locale e dall'impotenza funzionale più o meno marcata dell'arto colpito.
Le condizioni generali saranno più o meno compromesse, con turbe caratteriali che andranno dall'irritabilità a uno stato letargico per i bambini più piccoli.
Le articolazioni vicine sono abitualmente indenni, con una motilità conservata, tranne che nei bimbi sotto l'anno, in cui il quadro clinico è dominato da una psudoparesi dell'arto colpito.
Le manifestazioni cutanee, quali l'arrossamento, la tumefazione, il calore e la fistolizzazione, sono più tardive.
Le localizzazioni più frequenti sono alle regioni metafisarie del femore e della tibia, ma tutte le ossa possono essere colpite.
L'estensione del processo infiammatorio alle articolazioni contigue è possibile per l'anca e la spalla, per i motivi anatomici precedentemente riferiti.
RADIOLOGIA
All'esordio l'esame radiografico è muto, ma nel giro di alcuni giorni è possibile rilevare dei fenomeni osteolitici associati a reazione periostale.
Con il procedere dei fenomeni osteolitici possono verificarsi fratture patologiche.
La scintigrafia si è dimostrata in grado di colmare il periodo di latenza radiografica, ed è senz'altro da praticare all'esordio della sintomatologia.
LABORATORIO
Tutti i test infiammatori sono elevati, in particolare la V.E.S. e la Proteina C.
Il germe più frequentemente in causa è lo staffilococco aureo, che determinerà anche un aumento del titolo antistaffilolisinico.
La ricerca del germe in causa sarà fatta direttamente su pus prelevato da fistola, se presente, o su materiale agoaspirato o su sangue (emocoltura).
EVOLUZIONE
L'evoluzione è condizionata dalla precocità delle cure che possono prevenire la diffusione del processo infiammatorio alle articolazioni contigue (spalla e anca), la fistolizzazione e la frattura patologica.
Sarà quindi solo grazie alla diagnosi precoce (la ½ dei casi) che si potranno evitare queste complicazioni, destinate inevitabilmente a esiti più o meno invalidanti.
I postumi potranno essere:
1) segni radiografici asintomatici,
2) alterazione del ritmo di crescita dell'arto,
3) limitazione dell'escursione dell'articolazione eventualmente aggredita,
4) deformità evolutiva per danneggiamento della regione fisaria,
5) cronicizzazione del processo infiammatorio.
Di più frequente riscontro con l'avvento degli antibiotici.
E' caratterizzata da un quadro clinico sfumato; il bambino non dimostra scadimento delle condizioni generali e la febbre è poco elevata e può essere anche assente.
L'unico segno clinico costante è il dolore, non violento, risvegliabile alla palpazione.
L'esame radiografico e i test di laboratorio saranno positivi, così come la scintigrafia.
La diagnosi differenziale sarà da porsi essenzialmente con l'istiocitosi X (granuloma eosinofilo) e il sarcoma di Ewing.
Il trattamento sarà chirurgico e/o medico(antibiotici).
Come già detto, può essere l'evoluzione di una osteite acuta, dopo una fase di apparente guarigione, che può durare anche degli anni.
I segni dell'infiammazione si riaccendono localmente, con la formazione di un ascesso che frequentemente produce una fistola. Le indagini radiologiche sono poco utili, non aggiungendo nulla alle alterazioni già note; talvolta è possibile evidenziare un sequestro osseo.
La fistolografia sarà un esame utile anche in prospettiva di un'aggressione chirurgica.
Il trattamento sarà più spesso chirurgico.
L'osteomielite del neonato è un'affezione relativamente frequente, in genere diagnosticata tardivamente per oggettive difficoltà.
Sono particolarmente colpiti i prematuri, con apparato immunitario immaturo.
La via di accesso ai germi può essere cutanea, delle vie aeree, intestinale, ma può essere anche iatrogena, quale un catetere per perfusione endovenosa.
Le infezioni viscerali dovranno perciò essere curate con estrema attenzione.
La sede prediletta è la metafisi prossimale del femore, con interessamento pressochè costante dell'anca.
Il segno clinico che deve attirare l'attenzione è la psudoparesi dell'arto colpito e il pianto al cambio del pannolone, se è interessato l'arto inferiore.
Gli esami di laboratorio sono positivi per una infiammazione acuta, mentre la radiografia, negativa all'esordio, alla spalla e all'anca, dimostrerà in seguito i segni di sublussazione (piartro) e successivamente la reazione periostale metadiafisaria.
Per il ritardo con cui spesso si giunge a una diagnosi corretta, i processi distruttivi sono in genere avanzati e , quando è coinvolta un'articolazione, gli esiti funzionali non mancano.
Il germe coinvolto quasi costantemente è lo staffilococco aureo, prelevabile dal focolaio per agoaspirazione o all'aggressione chirurgica.
Il trattamento sarà medico nei casi diagnosticati precocemente, chirurgico nei restanti.
Le fratture nell'età evolutiva, per la frequenza, le varietà anatomiche, le localizzazioni, la rapidità di consolidazione e la possibilità di rimodellamento del callo osseo, hanno aspetti peculiari.
E' bene sapere anche, che alla benignità della gran parte delle lesioni, si contrappongono altre, quali quelle che interessano le cartilagini di crescita, che hanno tutt'altra evoluzione, e che, se non riconosciute, sono in grado di provocare vizi gravemente evolutivi nel corso degli anni.
La "volontà" di guarigione dell'osso giovane è una costante, così come la capacità di correggere eventuali difetti assiali.
Anche le rigidità articolari sono evenienze pressochè eccezionali.
L'insieme di tutto questo fa sì che il trattamento classico, con apparecchi gessati è ancora il migliore nell'età evolutiva, per gran parte delle lesioni.
Per quello che riguarda le lesioni legamentose, queste praticamente non esistono; infatti, per la maggior resistenza alle forze torsionali dei legamenti, il trauma si scarica sulle cartilagini metafisarie (distacchi epifisari).
Un distacco epifisario deve perciò sempre essere sospettato di fronte a un importante traumatismo di tipo distorsivo dell'infanzia, anche con radiogrammi negativi.
L'osso infantile è relativamente poco mineralizzato e quindi, in assoluto, meno resistente dell'osso adulto; all'inverso è maggiore l'elasticità e la plasticità. Il periostio molto spesso, determina una peculiare risposta ai traumatismi, con scarsa tendenza alla dislocazione dei monconi (frattura a legno verde). Questa parziale continuità è la causa della relativa difficoltà della diagnosi clinica.
FRATTURE DIAFISARIE
GENERALITA'
FRATTURE METADIAFISARIE
dovute ad affondamento della corticale diafisaria nella spongiosa metafisaria.
INCURVAMENTI SENZA FRATTURA
la forza traumatizzante viene assorbita dall'elasticità della struttura ossea, che si deforma plasticamente, senza segni di frattura (sono in realtà presenti delle microfratture).
Interessano principalmente il perone e l'ulna.
Guariscono con un ispessimento della diafisi dalla parte della concavità.
FRATTURE A LEGNO VERDE
sono caratterizzate dall'integrità del periostio e dall'interruzione di una sola corticale, con deformazione plastica della seconda.
FRATTURE COMPLETE
possono essere spiroidi, oblique e tronche.
Le fratture con minuta, per l'elasticità dell'osso infantile, sono molto più rare che nell'adulto.
CONSOLIDAZIONE
La velocità di consolidazione è massimale alla nascita, poi decresce rapidamente, di anno in anno, durante tutta l'età evolutiva.
ESITI
LE PSEUDOARTROSI praticamente non esistono nell'infanzia.
LE DISMETRIE hanno una doppia causa:
1) ipermetrie per stimolo della crescita dell'osso fratturato,
2) accorciamento per guarigione con accavallamento dei monconi di frattura.
Nel primo caso lo stimolo è naturale e biologico.
Nel secondo è conseguente a un difetto di riduzione.
Entrambi i difetti tendono, negli anni, a una egualizzazione.
Deve considerarsi perciò corretta anche una metodica di trattamento che prevede una non perfetta riduzione della frattura con modesto accavallamento dei monconi.
E' invece da evitare una riduzione con diastasi dei monconi.
IL CALLO VIZIOSO ANGOLARE si corregge, tanto più quanto è più giovane il bambino e il difetto è vicino alla cartilagine di crescita.
IL CALLO VIZIOSO ROTATORIO non dimostra la medesima tendenza alla correzione.
FRATTURE DELL'OMERO
sono molto più rare che nell'adulto e vengono trattate con trazione e gesso toracobrachiale.
Rare anche le lesioni associate del nervo radiale, che non cambiano le indicazioni.
Le fratture ostetriche e neonatali guariscono in 2 settimane e accettano angolazioni anche importanti, che si correggono in brevissimo tempo.
FRATTURE DELL'AVAMBRACCIO
rappresentano un'eccezione alle regole generali. Consolidano molto più lentamente (2 mesi in media), sono di difficile o di instabile riduzione (va preservato lo spazio fra le 2 ossa per mantenere una buona prono-supinazione), per cui, non di rado, il trattamento è chirurgico, con riduzione a cielo aperto e osteosintesi con fili di Kirschner endomidollari.
Il gesso, omero-metacarpale per 2 mesi, è necessario per tutti .
FRATTURE DEL FEMORE
si trattano con apparecchio gessato pelvi-pedidio per 2 mesi. Sono fra quelle che più frequentemente causano un'ipermetria. Per questo un lieve accavallamento è permesso, se non auspicabile.
Dopo i 10 anni di età, quando i fenomeni di rimodellamento osseo diventano meno affidabili e i tempi di guarigione si allungano, si possono prendere in considerazione altre ipotesi di trattamento:
FRATTURE DELLA GAMBA
si trattano con gesso femoro-pedidio per 45-60 giorni.
La complicanza più frequente è la sindrome compartimentale. Si rende perciò indispensabile un'attenta osservazione durante i primi giorni in gesso, evitando di ingessare fratture ancora tumefatte (aspettare tenendo l'arto in trazione su Zuppinger).
Anche per queste, nei bimbi più grandi, è possibile un trattamento chirurgico, come per il femore, per le stesse motivazioni.
FRATTURE METAFISARIE
GENERALITA'
Le metafisi subiscono soprattutto traumi in compressione.
L'osso spongioso di cui sono costituite, è infinitamente meno rigido di quello corticale; questa caratteristica fa assumere loro una funzione di ammortizzatore fra le diafisi e le articolazioni.
CONSOLIDAZIONE
Avviene in 4-6 settimane per un fenomeno di neosteogenesi rampante.
Il rimodellamento dei difetti assiali è assai veloce in vicinanza delle epifisi a rapida crescita (spalla, polso e ginocchio)
FRATTURE DISTALI DELL'AVAMBRACCIO
sono molto frequenti.
La riduzione si pratica immediatamente e l'immobilizzazione in gesso di polso dura circa 4 settimane.
FRATTURE SOVRACONDILOIDEA DELL'OMERO
sono fra le più pericolose per le complicanze.
L'esame clinico è eclatante per la tumefazione e la deformità del gomito.
Sono relativamente frequenti i deficit nervosi e vascolari. Possono essere determinati da lacerazioni da parte del moncone tagliente della frattura o, più spesso, dallo stiramento e dall'inginocchiamento della frattura.
Le fratture senza o con modesto spostamento sono trattate con gesso omero-metacarpale per 25 gg.
Le fratture scomposte si preferisce trattarle in urgenza con riduzione incruenta e osteosintesi percutanea con 2 fili di Kirschner transcondiloidei e apparecchio gessato omero-metacarpale. Anche per loro il periodo di immobilizzazione è di 25 gg.
Il trattamento in urgenza è risultato più valido nella risoluzione e prevenzione delle complicanze neuro-vascolari.
FRATTURE DEL COLLO DEL FEMORE
rare ma a cattiva prognosi per il rischio di necrosi epifisaria, ritardo di consolidazione e pseudoartrosi.
FRATTURE PROSSIMALI DI TIBIA
tipicamente a legno verde, con rottura della corticale interna e integrità del perone così che la deformità è in lieve valgo.
Il trattamento con gesso femoro-pedidio per 45-60 gg. consente la consolidazione.
La complicanza tipica di questa lesione è la comparsa, a distanza di 6 mesi - 1 anno, di un valgismo progressivo del ginocchio, che successivamente tenderà a regredire.
FRATTURE DEL CAPITELLO RADIALE
relativamente rare.
Quelle composte o con modico spostamento guariscono con un gesso omero-metacarpale in 20 gg. e hanno una prognosi favorevole.
Le fratture scomposte necessitano di una riduzione.
Qualora questa fosse chirurgica, ci si espone al rischio di esiti funzionali, soprattutto nel recupero della pronosupinazione. E' sempre controindicata la resezione del capitello radiale.
Le fratture interessanti le epifisi e le cartilagini di crescita hanno due picchi di frequenza: alla nascita (traumi ostetrici) e nell'adolescenza. Entrambi periodi di aumento dell'attività delle cartilagini metafisarie.
Il danno sulla cartilagine di accrescimento è, il più spesso, generato da traumatismi in torsione e flessione (traumi di tipo distorsivo) o in compressione.
I traumatismi in tale sede sono potenzialmente causa di complicazioni per la crescita dell'osso.
E' bene ribadire che nell'infanzia le distorsioni sono evenienze rare. Questa diagnosi è sovente errata e conseguenza di un referto radiografico negativo. Sarà il quadro clinico che, evidenziando un dolore palpatorio in corrispondenza delle cartilagini metafisarie, permetterà la diagnosi corretta.
La più diffusa è quella proposta da Harris e Salter in 5 tipi principali.
TIPO I
è il distacco puro dell'epifisi dalla metafisi lungo la regione fisaria; ha un buon prognostico.
TIPO II
la rima di frattura inizia e interessa per un tratto la fisi, per poi dirigersi verso la metafisi; è facilmente riducibile e gode di una prognosi favorevole.
TIPO III
la rima di frattura inizia e interessa per un tratto la fisi, per poi attraversare l'epifisi, fino a raggiungere la cavità articolare. La prognosi potrà essere buona solo con un perfetto riallineamento della regione fisaria e della superficie articolare. Il trattamento dovrà essere spesso chirurgico per
raggiungere questo obiettivo.
TIPO IV
la rima di frattura inizia dall'articolazione, per attraversare l'epifisi, la fisi e dirigersi nella metafisi, isolando un grosso frammento epifiso-metafisario.
La prognosi è grave, con il rischio di una parziale epifisiodesi, nonostante un buon riallineamento della frattura, per il quale è spesso necessario un atto chirurgico.
TIPO V
corrisponde a uno schiacciamento della regione germinale della cartilagine di crescita, e non è praticamente dimostrabile con l'esame radiografico.
Sia come lesione unica, sia come lesione associata agli altri tipi di distacco epifisario, dimostra la sua reale gravità nel tempo, con carattere gravemente evolutivo.
La consolidazione richiede 5-6 settimane.
Qualora il danno biologico interessi una zona contenuta dello strato germinativo della fisi, è possibile una guarigione per proliferazione delle cellule germinative viciniori.
Nel caso in cui la lesione fosse più estesa, il tessuto necrotico verrà dapprima rimosso per invasione di gettate vascolari di provenienza sia epifisaria che metafisaria e successivamente colmato da tessuto osseo, che costituirà un ponte fra l'epifisi e la metafisi, con conseguenze variabili in funzione della sede, estensione ed età del bambino.
L'evolutività di queste epifisiodesi sono tanto più gravi quanto più la cartilagine interessata è fertile, vale a dire: fisi prossimale dell'omero e distale dell'avambraccio per l'arto superiore, distale del femore e prossimale della tibia per l'arto inferiore.
DISTALI DEL RADIO
prevalentemente rappresentati il I e II tipo di Salter.
Il trattamento è ortopedico con gesso per 25 gg. e prognosi buona.
PROSSIMALI DELL'OMERO
spesso del II tipo di Salter.
Si giovano del trattamento ortopedico con apparecchio gessato toracobrachiale per 5 settimane.
La prognosi è buona.
FRATTURE DEL RACHIDE
Le fratture vertebrali nell'età evolutiva sono condizionate dalla presenza, da una parte e dall'altra dei corpi vertebrali, di una cartilagine di crescita, nel cui seno apparirà un nucleo di ossificazione.
La lesione interessa spesso questa zona più debole, con il rischio di turbe della crescita; si aggiungerà così, alla deformità da trauma, quella evolutiva da crescita viziata, con insorgenza di cifosi o scoliosi evolutive.
Il trattamento è ortopedico e si avvarrà di busti gessati o corsetti ortopedici.
Le indicazioni chirurgiche sono ristrette, trovando ulteriori difficoltà operative dalla mancanza di strumentario adeguato alle dimensioni del rachide infantile.
DISTALI DELLA TIBIA
Il più tipico è il distacco triplanare che si verifica in epoca puberale, per un meccanismo ove predominano le forze torsionali esterne.
Sono distacchi del IV tipo di Salter, con svolgimento su tre piani dello spazio.
Sono caratterizzate, sui radiogrammi ortogonali, da un'immagine di distacco di III tipo, su una proiezione, e di II tipo, sull'altra.
La riduzione deve essere anatomica, e per questo il trattamento è spesso chirurgico.
Le turbe della crescita sono in genere poco avvertite perché interessano soggetti a fine sviluppo.
DEL CONDILO ESTERNO DELL'OMERO
è di frequente riscontro e di difficile diagnosi per l'incompleta ossificazione del gomito, per cui è facile sottostimare il volume del frammento distaccato.
Sono classificabili fra i distacchi del IV tipo di Salter e il trattamento è prevalentemente chirurgico.
I tempi di consolidazione possono essere anche particolarmente lunghi (45 gg.), mentre le complicazioni più frequenti sono: il ritardo di consolidazione, la pseudoartrosi (spesso asintomatica), la necrosi del distacco, le deviazioni assiali (ben tollerate perché abitualmente non antiestetiche e prive di esiti funzionali significativi).
Sono lesioni che interessano nuclei di ossificazione extrarticolari.
DELL'EPITROCLEA OMERALE
più frequente nei bambini fra i 10 e i 15 anni.
E' sovente la conseguenza di una lussazione del gomito ridottasi spontaneamente.
Il trattamento potrà essere ortopedico o chirurgico, condizionato dall'entità dello spostamento; è comunque bene sapere che sono tollerati spostamenti anche di una certa entità.
DELLA TUBEROSITA' TIBIALE ANTERIORE
assume particolare importanza in conseguenza della sua continuità con la cartilagine fisaria prossimale.
Il suo distacco espone al rischio di una epifisiodesi prossimale anteriore con conseguente evolutività in ginocchio recurvato. Il trattamento è chirurgico.
Sono secondarie a distocie del parto, la più comune delle quali la presentazione podalica, soprattutto nelle primipare.
In ordine di frequenza, interessano la clavicola, la diafisi omerale, la diafisi femorale, la epifisi omerali e femorali.
DELLA CLAVICOLA
non richiede alcun trattamento e consolida in 15 gg.
Sarà importante, nella diagnosi differenziale, escludere una paresi ostetrica del plesso brachiale.
DELLA DIAFISI OMERALE
si manifesta con un braccio ciondolante. Anche in questo caso l'esame radiografico permetterà la diagnosi differenziale con la paresi ostetrica.
Il trattamento con gesso toraco-brachiale, consentirà la consolidazione in 15 gg.
Angolazioni anche di 50°-60° si rimodelleranno rapidamente con la crescita.
DELLA DIAFISI FEMORALE
Il trattamento prevede o una trazione allo zenit dell'arto inferiore o un apparecchio gessato pelvi-pedidio con anca e ginocchio flessi per 15 gg.
Si possono verificare all'omero e al femore, prossimali o distali.
La diagnosi è difficile in conseguenza della non presenza dei nuclei di ossificazione alla nascita (fa eccezione quello distale del femore).
Perciò, di fronte a una articolazione tumefatta e dolorosa, con immagine radiografica di lussazione, la diagnosi differenziale dovrà essere fatta con l'artrite settica (ricordo ancora che la lussazione traumatica alla nascita è evenienza impossibile).
Sono quelle fratture che intervengono su un processo patologico dell'osso che ne ha indebolito la struttura e dove il trauma è spesso di entità trascurabile.
Ci limiteremo a una elencazione dei fenomeni patologici responsabili di tale complicazione:
OSTEOMIELITE
CISTI OSSEA GIOVANILE
CISTI ANEURISMATICA
FIBROMA NON OSSIFICANTE
TUMORI MALIGNI PRIMITIVI
METASTASI OSSEE
OSTEOPOROSI LOCALIZZATA O GENERALIZZATA
FRAGILITA' OSSEE COSTITUZIONALI LOCALIZZATE (morbo di Recklinghausen e la pseudoartrosi congenita di tibia)
OSTEOGENESI IMPERFETTA
DISPLASIA FIBROSA.
Durante l'esposizione abbiamo ripetutamente affermato che il trattamento sarà prevalentemente incruento e si gioverà dei tradizionali apparecchi gessati.
E' bene però ricordare che le sindromi ischemiche compartimentali sono più frequenti nei bambini rispetto agli adulti, perciò il trattamento dovrà prevedere un periodo di attesa per consentire che si risolvano i processi infiammatori postraumatici (contenzione in valva gessata o di cartone oppure trazione a letto).
Il trattamento chirurgico, ridotto ai casi selezionati precedentemente esposti, si avvarrà, come mezzi di sintesi, quasi esclusivamente dei fili di Kirschner, che verranno lasciati, quando possibile, sporgenti sulla cute, per una facile rimozione senza ulteriori atti chirurgici.
Il trattamento delle epifisiodesi postraumatiche è assai complesso e potrà avvalersi, a secondo delle deformità residuate, di:
1) osteotomie per la correzione dei difetti assiali,
2) approcci chirurgici selettivi alla cartilagine di crescita per la liberazione di zone di epifisiodesi,
3) allungamenti e correzioni assiali, qualora necessari.
L'EPIFISIOLISI
Nel periodo di più rapida crescita dell'adolescenza, l'indebolimento della fisi prossimale del femore e le forze di taglio del peso corporeo possono provocare l'inizio di uno scivolamento dell'epifisi dal collo femorale.
La deformità derivante è data, generalmente, da uno risalimento e anteriorizzazione del collo femorale rispetto all'epifisi, così che questa si presenta come scivolata in basso e indietro, pur mantenendo i suoi normali rapporti nell'acetabolo.
Occasionalmente, tuttavia, lo scivolamento della testa femorale può essere apprezzato infuori e indietro rispetto al collo.
Molto più raramente, in seguito a un evento traumatico, l'epifisi femorale può dislocarsi anteriormente al collo.
La malattia preferisce i maschi (2,5 a 1) e la razza negra (2,5 a 1).
L'età prediletta è quella dell'adolescenza, nel periodo del massimo accrescimento scheletrico (13 - 15 anni per i maschi, 11 - 13 anni per le femmine).
L'interessamento di entrambe le anche si verifica nel 25% dei malati.
Anche se in letteratura sono riferite alte incidenza della malattia nello stesso nucleo familiare, essa, di norma, si presenta come caso sporadico.
Classificazione
Possiamo classificare l'epifisiolisi in acute e croniche. Le prime possono ancora essere suddivise in traumatiche e non.
Secondo la gravità è possibile individuare quattro categorie:
I°grado: allargamento e rarefazione dell'epifisi, senza scivolamento,
II°grado: scivolamento minore di 1/3 della larghezza del collo,
III°grado: scivolamento maggiore di 1/3 ma minore di ½ della larghezza del collo,
IV°grado: scivolamento maggiore del 50% della larghezza del collo.
Eziologia
Quattro fattori possono operare nella patogenesi:
l'aumento dell'altezza della fisi della collo femorale,
verticalizzazione della fisi del collo femorale,
l'abnorme carico sulla cartilagine di crescita,
l'insufficienza delle componenti di tensione (collagene) e idrostatiche (proteoglicani) della cartilagine di crescita.
Non è essenziale la concomitante presenza di tutti i fattori elencati.
Il momento scatenante l'evento patologico è meccanico: le forze di taglio che agiscono sull'epifisi sono più grandi di quelle che danno stabilità alla fisi, così che la testa femorale si disloca.
Lo scivolamento è un processo graduale, poiché l'indebolimento della cartilagine di crescita è protetto parzialmente dall'integrità del pericondrio.
Come già detto, l'epifisiolisi si manifesta nel periodo di più rapida crescita scheletrica della pubertà, quando sono in atto significativi mutamenti endocrinologici; è stato spesso fatto rilevare la possibilità che disfunzioni endocrine predispongano alla malattia.
Clinicamente questo dato è supportato dal fatto che gli adolescenti affetti da epifisiolisi spesso hanno una sindrome adipogenitale o, meno comunemente, sono alti ed esili, segno di uno spunto di crescita assai rapido.
Gli ormoni presi in considerazione sono principalmente due: l'ormone della crescita e gli ormoni sessuali.
Il primo agisce stimolando lo strato delle cellule germinative della cartilagine di crescita; l'aumento di spessore di questo strato determina una minor resistenza alle forze di taglio della fisi.
Viceversa il secondo deprime la proliferazione delle cellule cartilaginee, riducendo lo spessore della fisi.
Nelle sindromi adipogenitali si avrà: un aumento delle forze di carico secondarie all'obesità e un aumento di spessore delle fisi (indebolimento), stimolate dall'ormone della crescita non contrastato degli ormoni sessuali.
Negli adolescenti alti ed esili, la causa dell'aumento dello spessore delle fisi sarà da ricercare in un aumento della produzione o ipersensibilità all'ormone della crescita.
In questi casi può essere anche sospettato un adenoma pituitario.
Oltre all'ipogonadismo a all'iperattività dell'ormone della crescita, altri fattori che possono causare un indebolimento delle cartilagini di crescita sono:
la somministrazione di ormone della crescita in bambini in trattamento per bassa statura,
l'ipotiroidismo: la carenza dell'ormone tiroideo agirebbe indebolendo la matrice della cartilagine di crescita,
le osteodistrofie renali, con il secondario ipoparatiroidismo, determinano un aumento dello spessore e conseguente indebolimento delle cartilagini di crescita.
Anatomia patologica
A livello della membrana sinoviale sono presenti fenomeni di infiammazione, perduranti per diversi mesi.
L'emartro si verifica solo in caso di epifisiolisi traumatica acuta.
Il piano di scivolamento dell'epifisi interessa lo strato delle cellule cartilaginee adiacenti alla zona di calcificazione provvisoria, tuttavia spesso questo può essere molto più irregolare, attraversando tutte le differenti zone della fisi.
Lo scivolamento è abitualmente graduale, il pericondrio si mantiene integro, adeguandosi alla migrazione epifisaria; al contrario, nell'epifisiolisi acuta, può lacerarsi.
Lo scivolamento posteriore può essere anche importante. Come l'epifisi inizia a scivolare posteriormente, così comincia a dislocarsi anche inferiormente; la conseguenza, sui radiogrammi di fronte e di profilo, e il disegnarsi di una gobba sul profilo del collo femorale.
Dal punto di vista istologico il danno è tutto a carico della zona ipertrofica della cartilagine fisaria: alle colonne longitudinali separate da sottili setti longitudinali e trasversali di fibre collagene, si sostituiscono disorganizzati gruppi o irregolari colonne di condrociti. Anche i sottili e ordinati setti di fibre collagene si disorganizzano dando luogo a fini fibrille disordinate nella matrice condrale.
Con la guarigione, l'angolo inferiore e la porzione anteriore del collo, adiacente alla fisi, si colma con callo osseo e con il sopraggiungere del rimodellamento, il callo viene inglobato con il collo e le "gobbe" si arrotondano e si appiattiscono.
Nel caso di scivolamento importane, le "gobbe" ossee possono entrare in conflitto con il margine anteriore e superiore dell'acetabolo. è questa la causa delle limitazioni dell'abduzione, intrarotazione e flessione.
Nel giro di 1 - 2 anni la fisi scompare con la formazione di tessuto osseo che unisce il collo alla epifisi femorale.
Il destino nei restanti stadi evolutivi, dipende:
dall'integrità della circolazione dell'epifisi femorale,
dalla integrità della cartilagine ialina,
dalla residua deformità e conseguente difettoso meccanismo articolare.
La coxartrosi potrà svilupparsi in epoca successiva, specialmente se vi sono stati fenomeni di necrosi epifisaria o se residua incongruità articolare.
Quadro clinico
I sintomi variano in accordo con il tipo di scivolamento: cronico, acuto o acuto - traumatico.
Abitualmente la coxalgia è modesta, a volte continua, altre intermittente, esacerbata dallo sforzo.
Il dolore può durare da diverse settimane o mesi e attribuito a banale o importante traumatismo.
Il ragazzo deambula con zoppia da fuga ed extrarotazione dell'arto colpito.
Le limitazioni della motilità sono proporzionali all'entità dello scivolamento.
Il segno tipico è che quando si porta l'arto in flessione si provoca un'automatica extrarotazione dell'anca e la coscia non arriva a toccare l'addome.
Normalmente non si apprezza limitazione nella estensione, al contrario, l'anca è estesa ed è limitata la flessione. La presenza di un atteggiamento in flessione deve far pensare a una condrolisi.
L'accorciamento è intorno a 1 - 2 cm., l'importanza dell'ipotrofia della coscia è proporzionale alla durata della sintomatologia.
caratterizzata da un esordio improvviso, con violenta coxalgia e impossibilità all'appoggio dell'arto. Ne esistono due tipi: traumatica, che si verifica in conseguenza di un trauma di rilievo (caduta dall'alto, incidente stradale ecc.) senza storia di pregressa sintomatologia e non, con precedenti di algie riferiti all'inguine, alla coscia o al ginocchio: uno scivolamento moderato si aggrava improvvisamente sotto il carico del peso corporeo dopo un trauma minimo o insignificante.
L'esame clinico sul malato deve essere effettuato con estrema delicatezza.
L'anca apparirà in marcata extrarotazione, la motilità sarà limitatissima per la difesa del paziente.
Le manovre forzate sono da evitare perché potrebbero provocare ulteriore scivolamento dell'epifisi.
Anche l'indagine radiografica deve essere praticata con cautela e il ragazzo deve essere immediatamente ospedalizzato, al letto e in trazione: è un'emergenza!
Nello stadio del pre o minimo scivolamento, l'indagine radiografica dimostra un allargamento e irregolarità della fisi con rarefazione nella porzione iustaepifisaria.
Lo scivolamento epifisario potrà non essere apprezzabile sui radiogrammi in anteroposteriore; è essenziale la proiezione assiale, essendo spesso lo scivolamento solo posteriore, nelle fasi iniziali.
Misurazioni radiografiche
In anteroposteriore, il prolungamento della linea tracciata sul profilo superiore del collo (linea di Kline) deve comprendere un pezzo di epifisi, pari a quella del lato sano.
Lo scivolamento sarà considerato modesto finché un pezzo di testa è attraversato dalla linea (I°grado), medio se il collo femorale rimane scoperto fino a 1/3 della sua larghezza (II°grado), grave fino a ½ (III°grado), gravissimo oltre (IV°grado).
In assiale, la testa e il collo del femore si pongono, di norma, tra di loro con un angolo di 87°- 90°.
Una diminuzione di questi valori indicano una epifisiolisi, anche in assenza di uno scivolamento in anteroposteriore.
L'epifisiolisi è una emergenza chirurgica. è di fondamentale importanza, quindi, la diagnosi precoce, onde prevenire lo scivolamento dell'epifisi.
Il trattamento nelle forme di I°grado consisterà nell'infibulazione, attraverso il collo femorale, dell'epifisi con fili di Kirschner o chiodi di Staiman, al più presto possibile.
Negli altri casi il trattamento esordirà con trazione al letto, più fasce di intrarotazione alla coscia per qualche giorno, per ottenere una riduzione atraumatica dello scivolamento.
Seguirà la sintesi con la metodica già descritta.
Successivamente all'atto chirurgico seguirà un periodo di almeno 6 mesi durante il quale sarà concessa la deambulazione con 2 bastoni canadesi, senza carico sull'arto malato.
La rimozione dei mezzi di sintesi avverrà soltanto a fisi completamente ossificata, in media dopo 1 - 2 anni dall'intervento.
Un discorso a parte merita l'epifisiolisi acuta traumatica, che si verifica in conseguenza di un grave trauma (caduta dall'alto o incidente della strada), che può interessare bambini di qualsiasi età e va interpretata come un distacco epifisario di I° tipo secondo Salter.
La prognosi è quasi sempre sfavorevole per l'alta incidenza della necrosi asettica dell'epifisi.
La condrolisi o necrosi acuta della cartilagine ialina, è complicanza distinta dalla necrosi asettica della testa del femore. Consiste in un processo di autolisi della cartilagine articolare sostenuta dagli stessi prodotti della degradazione che man mano vengono liberati nella cavità articolare; gli enzimi lisosomiali sono i maggiori imputati.
L'eziologia è sconosciuta.
I fattori che statisticamente favoriscono il fenomeno sono:
la razza (più colpiti i negri e gli Hawaiani),
il sesso (le femmine con prevalenza da 2 a 5 a 1),
la penetrazione di chiodi metallici in articolazione (iatrogena),
l'immobilizzazione prolungata, influenzando al formazione del liquido sinoviale,
le osteotomie valgizzanti, per iperpressione articolare,
l'incongruenza articolare, quale fattore meccanico traumatizzante l'articolazione.
Dal punto di vista clinico si assiste a un irrigidimento dell'articolazione con vivo dolore.
La fase acuta dura circa sei settimane, seguita da una subacuta, da 1 mese a 6 mesi e da una cronica, successivamente.
L'evoluzione successiva è in una forma o benigna o persistente.
Nel primo caso si assisterà a un completo recupero articolare nell'arco di 6 mesi, nel secondo caso l'anca andrà incontro a progressiva anchilosi fibrosa.
Il trattamento è basato sullo scarico articolare, la mobilizzazione sia attiva e assistita, sia passiva, anche su macchine per mobilizzazione continua, per diversi mesi (il movimento è vita!).
In caso di insuccesso del trattamento riabilitativo, il tentativo chirurgico è mirato alla liberazione dalla contrattura dell'anca (allungamento degli adduttori, ileopsoas e apertura della capsula fibrotica) seguito della terapia riabilitativa intensiva.
La necrosi asettica può verificarsi in conseguenza alla riduzione dello scivolamento acuto o subacuto.
una complicazione seria e, nel trattamento dell'epifisiolisi devono essere posti in atto tutte le precauzioni per prevenirla.
La miglior prevenzione possibile è l'itervenire tempestivamente, prima che lo scivolamento dell'epifisi femorale diventi eccessivo, cosa possibile solo con la diagnosi corretta all'inizio della sintomatologia.
Il decorso postoperatorio va seguito con attenzione, in quanto la comparsa della necrosi determina un collassamento dell'epifisi femorale con secondaria penetrazione dei fili in articolazione, cosa che può scatenare una condrolisi. Va da se che la rimozione dei mezzi di sintesi va effettuata senza indugi.
La necrosi potrà essere completa o parziale.
Nel primo caso una osteotomia intertrocanterica permetterà di ruotare la testa del femore, allontanando la parte necrotica dalla zona di carico (osteotomia di Sugioka).
Nel secondo caso le possibilità terapeutiche sono affidate alla riabilitazione e alllo scarico articolare per lungo periodo e, in caso di persistenza dei sintomi dolorosi e della rigidità articolare, all'artrodesi.
LA SCOLIOSI
Definizione
La scoliosi è una deviazione di un tratto più o meno esteso del rachide che si sviluppa su un piano obliquo, quale risultato di un movimento elicoidale, che le vertebre compiono per una inflessione sui piani sagittale e laterale, contemporanea a una rotazione e una torsione assiale.
Una deviazione vertebrale può essere identificata come vera scoliosi soltanto alla presenza di specifiche alterazioni anatomopatologiche e cliniche, delle quali la rotazione delle vertebre e il conseguente gibbo costale sono l'espressione più apparente, che inducono una rigidità del tratto di colonna interessato dalla deviazione e ne determinano la caratteristica clinica della malattia, rappresentata dall'evoluzione peggiorativa.
Atteggiamento Scoliotico è invece una deviazione del rachide morfologicamente simile alla scoliosi ma privo della caratteristica rigidità per questo la semplice sottrazione al carico determina la risoluzione della curva, che di conseguenza non è mai evolutiva.
Nel trattare questa complessa malattia è indispensabile adottare una terminologia che ne identifichi i multiformi aspetti clinici ed anatomo-patologici, evitando ogni confusione che non sarebbe soltanto semantica ma anche concettuale.
Pertanto è bene richiamarsi alla terminologia codificata dalla Scoliosis Research Society ormai universalmente adottata nella letteratura scientifica:
Per quanto riguarda la sede della scoliosi, una curva maggiore può essere:
a) Cervicale con apice compreso tra Cl e C6.
b) Cervico-toracica con apice in C7 o DI
c) Toracica con apice compreso tra D2 e DIO.
d) Toraco-lombare con apice compreso tra D11 e L1
e) Lombare con apice compreso tra L2 e L4
f) Lombosacrale con apice compreso tra L4 e L5.
Relativamente al periodo di insorgenza si possono distinguere:
Vertebre
Vertebre limiti: la vertebra superiore ed inferiore della curva i cui rispettivi piatti vertebrali sono i più inclinati verso la concavità dalla curva.
Vertebre neutre: vertebre di una curva scoliotica nelle quali la rotazione è nulla.
Vertebra apice: vertebra di una curva ove la rotazione è massimale, ed è anche quella più distante dall'asse verticale del paziente.
Vertebra di transizione: vertebra cerniera di una scoliosi a due curve maggiori rappresentando la vertebra limite inferiore della curva superiore e la vertebra limite superiore della curva inferiore.
Rotazione vertebrale
Nella scoliosi, fin dall'instaurarsi della deviazione vertebrale, parallelamente al costituirsi della curva sul piano frontale, si verifica una rotazione della vertebra apicale e di quelle para-apicali sull'asse verticale.
Il corpo tende a ruotare verso la convessità, mentre la porzione arcale ruota verso la concavità della curva.
A livello dorsale in questo movimento rotatorio le vertebre coinvolgono la cassa toracica, inducendo una rotazione ed il deformarsi delle costole, che assumono un decorso più obliquo e protrudono dorsalmente dal lato convesso (gibbo) mentre divengono più orizzontali e s'inflettono ventralmente dal lato concavo. Questo movimento rotatorio è massimo nella vertebra apicale.
Torsione vertebrale
È invece una deformazione della vertebra sul suo asse anteriore-posteriore, dovuto agli stress trasmessi dal movimento rotatorio e ai quali si oppongono la resistenza delle formazioni anatomiche rappresentate da: muscoli, legamenti, capsule e coste connesse alla vertebra stessa.
Pertanto il complesso arcale (peduncolo-lamine-apofisi spinosa) della vertebra scoliotica è allungato ed assottigliato dal lato convesso; accorciato, ispessito e tozzo dal lato concavo.
A livello lombare pur non esistendo un gibbo d'origine costale, esiste una gibbosità sempre sul lato convesso della curva, originata dalla superficializzazione delle masse muscolari, come conseguenza della rotazione e della torsione vertebrale.
Cuneizzazione vertebrale
L'altra caratteristica anatomo-patologica tipica della scoliosi strutturata è la deformazione a cuneo dei corpi vertebrali, che occorre essenzialmente per il diminuito potere d'accrescimento della cartilagine del piatto superiore nella porzione concava e posteriore.
Classificazione ed ipotesi patogenetiche
Dal punto di vista eziologico le scoliosi si distinguono in forme da causa ben individuata e forme idiopatiche.
La scoliosi idiopatica rappresenta oltre il 70% di tutte le scoliosi e incide prevalentemente sul sesso femminile.
Mentre l'incidenza di scoliosi, in periodo prepuberale è pressoché pari nei maschi e nelle femmine, nel periodo postpuberale si raggiunge quel rapporto di 4 a l che caratterizza la maggiore espressività della scoliosi nel sesso femminile.
Il perché di quest'andamento della malattia non è stato ancora evidenziato.
La scoliosi è una malattia ereditaria: infatti, è molto frequente che la malattia colpisca consanguinei tanto da arrivare ad una percentuale d'interessamento familiare del 43%, dato che, integrato da studi genetici e statistici più specifici, ci può permettere di affermare che la scoliosi idiopatica si trasmette come carattere autosomico dominante multifattoriale a penetranza variabile.
In conclusione, nella genesi della scoliosi idiopatica, non vi è un fattore primitivo unico ma bensì un insieme di fattori genetici, chimici, di crescita e neuromuscolari che indurrebbero o un disturbo di maturazione del sistema nervoso centrale, alterando il circolo d'informazioni afferenti necessario all'equilibrio, ovvero un'alterazione del sistema endocrino responsabile dell'accrescimento staturale.
Esame clinico
Esame statico
Viene eseguito con il paziente in posizione eretta con le gambe tese e nella posizione abituale del tronco.
Si rileva lo stato di pubertà secondo le tabelle di Tanner.
L'equilibrio del bacino è valutato tramite la localizzazione delle SIAS e posteriormente delle SIPS.
Se esiste una disuguaglianza degli arti inferiori, viene calcolato il rialzo necessario al riequilibrio del bacino.
Al livello del cingolo scapolare va misurata la differenza d'altezza esistente tra i due punti acromiali.
Essa è più frequentemente modificata in presenza di curve cervicali o cervico-toraciche ma anche in curve basse senza curve di compenso.
Il disassamento del tronco è valutato tramite la rilevazione dell'asse occipito-sacrale, che nella pratica clinica è sostituito dal rilievo dell'asse che unisce la spinosa di C7 (prominente) e il solco intergluteo.
Le gibbosità vanno rilevate con il paziente flesso (80 gradi) a gambe estese, mani unite e braccia estese in situazione di rilasciamento, con l'esaminatore posto sia di fronte che dietro al paziente.
In tal modo è possibile valutare numericamente l'entità del gibbo, che viene calcolata a livello della massima differenza tra parte prominente (convessa) e la controparte (concava).
Sul piano sagittale le curve di massima cifosi e lordosi sono misurate sempre con l'ausilio del filo a piombo tangente l'apice della cifosi e del sacro e definite numericamente dal valore di questi segmenti: frecce cifotiche.
L'esame statico in posizione eretta può essere integrato da un esame con il paziente in posizione seduta, che permette di valutare l'abituale attitudine durante le ore di studio o di lavoro, e da un esame di posizione «distesa» utile particolarmente per rilevare, con la palpazione, zone dolorose e d'anormale contrattura muscolare.
Esame dinamico
Individua la motilità articolare rachidea nel suo complesso cervicale dorsale e lombare esplorandola nei tre piani; estensione, flessione, inclinazione laterale sinistra e destra e rotazione della cintura scapolare verso dx. e sx. in rapporto alla pelvi.
Permette di valutare il grado di riducibilità delle curve, d'evidenziare i punti di maggiore rigidità che potrebbero essere spia di patologie associate a scoliosi o causa di scoliosi.
Esame radiografico
Ha come finalità:
Lo studio radiografico standard deve prevedere radiografie della colonna in toto, in posizione ortostatica, in anteroposteriore e laterolaterale, da eseguire su un solo film; se esistono dismetrie esse andranno corrette con un rialzo adeguato.
Tali proiezioni rappresentano gli esami fondamentali nello studio della scoliosi.
Potranno essere integrati:
Nella pratica comune lo studio della scoliosi è quindi riportato su due soli piani dello spazio il che, pur offrendone un'immagine diversa dalla realtà, consente di valutarne l'entità, la riducibilità e l'evoluzione mediante la misurazione del valore angolare della curva secondo il metodo di Cobb.
Tale metodica è messa in atto misurando l'angolo formato dalle tangenti, il piatto superiore della vertebra limite superiore ed il piatto inferiore della vertebra limite inferiore. L'entità della rotazione vertebrale può essere valutata nelle radiografie in AP valutando la proiezione della spinosa sui corpi vertebrali.
Il grado di rotazione è calcolato con una scala di valori variabile da 0 a 4:
L'angolo di caduta costale di Mehta misura l'angolo formato dalla retta passante per la metà del collo e la metà della testa delle costole, e la retta passante verticalmente al livello della metà del corpo vertebrale della vertebra apice della curva.
La differenza, tra i valori angolari dei due lati concavo e convesso, maggiore di 20°, è indice di un potenziale di evolutività delle curve.
Altro elemento di notevole importanza ai fini della prognosi e dell'eventuale trattamento della scoliosi è l'individuazione dell'età scheletrica in riferimento all'età cronologica.
Il metodo di Risser valuta in 5 stadi il grado d'ossificazione delle cartilagini delle apofisi iliache durante l'adolescenza.
Trattamento
Il trattamento della scoliosi è funzione di numerosi parametri; tra questi, quelli che svolgono un ruolo preminente sono essenzialmente l'eziologia, l'età d'insorgenza, la sede della curva.
Questi fattori concorrono a determinare l'evolutività e quindi la gravità della curva.
Per quanto riguarda l'eziologia sappiamo che le forme congenite, ad esempio sostenute da emispondili liberi o da difetti di segmentazione, sono molto evolutive e così anche quelle dovute alla neurofibromatosi, mentre per le idiopatiche l'evolutività e di conseguenza la gravità è proporzionale all'età di comparsa: pertanto le infantili sono le più gravi.
Nella ricerca di fattori di valutazione prognostica più approfonditi ne sono stati evidenziati alcuni che si sono dimostrati importanti nelle forme infantili.
Le forme in cui vi è un andamento molto obliquo delle coste (indice di Metha >20°) con gran differenza di valore angolare tra i due lati, risultano essere le scoliosi più evolutive.
Anche la sede della curva può essere dirimente nella scelta del trattamento.
Le scoliosi toraciche sono le più evolutive; a seguire le toracolombari e quelle costituite da due o più curve primitive o doppie primarie, e infine le lombari.
L'esistenza di un disassamento del capo rispetto al bacino depone per una scoliosi evolutiva perché si tratta di una forma in precario equilibrio meccanico.
Quando sul piano sagittale prevale la componente lordotica a livello toracico, s'identificano scoliosi con più marcato potenziale evolutivo: lordoscoliosi.
Tre i tipi di trattamento:
-chinesiterapia,
-correzione con supporti esterni: trattamento ortopedico,
-correzione chirurgica.
La cinesiterapia
I vari sistemi di rieducazione si sono dimostrati insufficienti nel controllare l'evolutività di una scoliosi strutturale.
Pertanto il ruolo riservato alla chinesiterapia, nei programmi terapeutici moderni della scoliosi, è quello di importante sostegno al trattamento ortopedico o chirurgico nelle varie fasi in cui essi si sviluppano.
Il trattamento ortopedico
Si avvale di gessi correttivi e dell'uso di busti (o corsetti).
Tutti erano finalizzati, tramite le vie più disparate, ad ottenere tre scopi essenziali:
Il Risser localizer cast e l'EDF di Cotrel eseguiti fuori carico su appositi telai con il paziente in trazione cefalica e pelvica, realizzano la correzione mediante l'applicazione contemporanea di forze di trazione longitudinale, derotazione e flessione variamente applicate nelle due metodiche.
Entrambi i tipi di gesso possono essere usati sia nel trattamento ortopedico, seguiti dall'uso di busti, che nel trattamento chirurgico e sia nella fase preoperatoria di preparazione all'intervento, come nella fase post-operatoria di contenzione.
Per quanto riguarda i corsetti ortopedici, ne esistono numerose varietà, alti, bassi, con caratteristiche dinamiche (Milwaukee) o prevalentemente statiche (Lyonese), nel senso di mantenimento delle correzioni ottenute tramite gessi o interventi.
Il corsetto di Milwaukee, in uso dai primi anni 50, è costituito da un canestro pelvico, eseguito su moulage gessato in lordosi corretta, da cui si dipartono due aste posteriori e un'anteriore, raccordate tra loro da un collarino sottomentoniero e occipitale posteriore.
La correzione è attivamente ottenuta per un continuo stimolo all'autoelongazione e pertanto tale busto trova indicazione nelle forme meno rigide.
L'azione di pelotte agenti al livello delle gibbosità dorsali contribuisce alla correzione.
Trova indicazione in tutti i tipi di scoliosi (infantili, adolescenziali) non solo idiopatiche, ma anche nelle neuromuscolari, congenite e cerebropatiche.
Tra le complicanze del corsetto di Milwaukee, oltre a quelle di natura psicologica legate all'eccessiva visualizzazione dell'apparecchio, ricorderemo il prognatismo o malocclusione dovuta alla spinta sottomentioniera e ovviabile con un attento controllo del rapporto tra la mandibola ed il collarino.
Per ovviare ai sopraccitati inconvenienti psicologici sono stati messi a punto corsetti di dimensioni più ridotte e quindi più facilmente occultabili da giovani pazienti, adottabili specie nelle curve più basse.
Tra questi ricorderemo il sistema di Boston, messo in atto negli anni 80, rappresentano da un corsetto costruito su moduli prefabbricati, al cui interno sono applicate spinte agenti al livello delle curve e controspinte anteriori derotanti.
Trova indicazione nelle curve lombari, toracolombari e in quelle toraciche in cui la vertebra apice non superi T8.
Le controindicazioni principali sono rappresentate dall'obesità e dalla rigidità delle curve.
In ultimo citeremo il corsetto Lionese, il quale fa parte di un vero e proprio sistema di cura che si compone di vari momenti consequenziali e che può essere usato sia in un ambito strettamente ortopedico sia in un ambito chirurgico di trattamento della scoliosi.
La prima fase di questo sistema è quella fisiochinesiterapica, in cui si mira ad ottenere la distensione della curva tramite esercizi attivi d'autocorrezione, di mobilizzazione associati o meno, a seconda della rigidità della curva, alla trazione vertebrale continua o notturna.
Ottenuta una soddisfacente mobilizzazione delle curve si esegue il gesso correttivo EDF.
Dopo un periodo di tempo oscillante tra i 4/6 mesi, con l'esecuzione di 2 o 3 gessi, a seconda della rigidità della curva, si passa al corsetto vero e proprio, costruito con materiale plastico rigido.
Il metodo lionese è molto valido nel trattamento delle curve evolutive e fortemente strutturate, l'azione modellante sui gibbi è particolarmente efficace e tale correzione tende a mantenersi anche dopo la sospensione del trattamento. Tutti questi metodi di trattamento ortopedico hanno dimostrato di ottenere risultati simili nel controllo del valore angolare della curva.
La revisione a distanza dei risultati ottenuti ha dimostrato che i valori angolari tendono, nel tempo, dopo la sospensione della tutela, a riavvicinarsi ai valori iniziali di partenza. Per cui la finalità del trattamento ortopedico è quella di stabilizzare una scoliosi evolutiva migliorandone l'aspetto estetico.
In linea di massima possiamo definire le indicazioni al trattamento ortopedico quelle scoliosi con curve comprese fra i 20° e i 40°, oltre il quale si deve ricorrere ad un trattamento chirurgico.
Il trattamento chirurgico
Prendendo i 40° come linea di demarcazione, la via chirurgica risulta essere quella d'elezione quando ai test di riducibilità clinica e radiografica (bendings, sospensione) si ha una riduzione dell'entità angolare di partenza di oltre il 50% (per curve comprese tra i 40° e i 65°) e non vi è necessità assoluta di eseguire correzioni preoperatorie delle curve.
Altresì nei casi con valori angolari superiori o che presentano maggiore strutturazione vertebrale, quindi meno distensibili e perciò più rigide, riteniamo di dover ricorrere ad una correzione preoperatoria, che secondo la gravità dei casi può essere ottenuta da:
a) trazione vertebrale secondo Cotrel;
b) gesso tipo EDF o tipo Risser;
c) gesso di elongation (Stagnarà);
d) Halo system nelle sue varianti.
La preparazione preoperatoria permette di ridurre la percentuale di complicazioni vascolo-nervose e viscerali, che possono verificarsi nel corso di interventi correttivi di chirurgia vertebrale, scatenando problemi a volte già esistenti in forma latente (siringomielia, diastomatomielia, etc.).
Il trattamento chirurgico è sostanzialmente basato sull'artrodesi vertebrale, di cui negli anni sono state proposte differenti varianti, ma è senz'altro la metodica di Risser, modificata da Moe, quella che dà i risultati più efficaci per garanzia di solidità.
Essa prevede un'artrodesi delle articolari, decorticazione delle lamine e applicazione di autotrapianti corticospongiosi preferibilmente prelevati dalla cresta iliaca.
L'area di artrodesi si sviluppa sulla zona di rachide interessata dalla curva o dalle curve scoliotiche, i cui limiti corrispondono ai limiti geometrici.
La correzione delle deformità quando non è previsto l'uso di mezzi di sintesi, è affidata essenzialmente a gessi correttivi pre o postoperatori.
L'impulso più importante alla chirurgia vertebrale è in ogni modo stato dato da P. Harrington che con il suo chiodo distratto re in combinazione all'artrodesi ha permesso di ottenere maggiori correzioni delle deformità.
Dalla semplice barra di Harrington, si è passati nel tempo a sistemi più complessi tendenti a migliorare la correzione ed ottenere un migliore assetto biomeccanico, aumentando la stabilità del montaggio.
È in quest'ottica di miglioramento che va inquadrata l'evoluzione ultima della chirurgia vertebrale, rappresentata dal sistema Cotrel-Dubousset e da cui hanno preso spunto numerose altre metodiche similari.
Il sistema CD, si basa su una concezione tridimensionale della scoliosi, da cui deriva che la correzione debba essere portata sui tre piani dello spazio; in pratica correggendo la deformità esistente sul piano frontale e ricostituendo contemporaneamente le normali curvature sagittali.
Tutto ciò è possibile grazie all'azione correttiva in distrazione-compressione segmentaria e alle manovre di derotazione-attrazione.
Il sistema CD grazie alla sua versatilità, alle possibilità di usufruire di numerose combinazioni di assemblaggio (diversi tipi di uncini e viti) permette correzioni e stabilità di montaggio molto validi.
CIFOSI, CIFOLORDOSI
Premessa
Alla nascita il rachide è totalmente retto e può presentare una curvatura ad ampio raggio, a concavità anteriore, estesa dall'occipite al sacro.
Con la crescita s'incominciano a sviluppare le normali curvature, iniziando con la lordosi cervica1e, che si manifesta con la capacità di mantenere la testa in posizione eretta, passando allo svilupparsi della lordosi lombare, con l'assunzione della stazione eretta e con la deambulazione, e quindi al successivo sviluppo della cifosi toracica. L'esistenza delle curve sul piano sagittale ha una notevole valenza biomeccanica, perché aumenta la forza di resistenza del rachide alla forza di gravità.
D'altra parte le fisiologiche curvature rachidee, a differenza di quello che avviene sul piano frontale, in cui il rachide è fisiologicamente diritto, hanno portato sempre a sottovalutare l'importanza di deformità cifotiche e cifolordotiche.
Classificazione
La classificazione della cifosi, comprende vari tipi, ma è certo che tra tutte le forme quella più importante e più frequente, che assume i caratteri più peculiari, e per questo genericamente denominata cifosi giovanile, è il m. di Scheuermann, che insieme alla forma idiopatica e astenica è quella di più frequente riscontro e di cui ci occuperemo più strettamente in questo capitolo.
Nel 1921 H. Scheuermann descrisse una malattia caratterizzata da specifiche alterazioni vertebrali, con cifosi, che si distingueva dalla cifosi astenica per la sua peculiare rigidità.
Il m. di Scheuermann è caratterizzato dalla cuneizzazione vertebrale, dovuta ad un disordine dei piatti vertebrali, che sembra colpire in una percentuale compresa tra lo 0,5% e 1'8% della popolazione, con una certa preferenza per il sesso maschile.
Eziopatogenesi e anatomia patologica
La causa di questo disturbo è ancora sconosciuta da quando lo stesso Scheuermann lo definì come una forma di necrosi asettica delle «ring apophisis».
Studi condotti indagando aspetti ormonali hanno dimostrato, nei soggetti con morbo di Scheuermann, iperincrezione del G.H. nel periodo prepuberale, altezza maggiore e un anticipo dell'età ossea rispetto ai coetanei non affetti.
Tali studi, inoltre, sono stati correlati ad indagini istologiche, istochimiche e ultrastrutturali, eseguite sul complesso disco-cartilagineo dei pazienti affetti da m. di Scheuermann, prelevati nel corso di interventi correttivi.
Hanno mostrato:
1. il primitivo processo patologico è localizzato in alterate aree della cartilagine d'accrescimento e sul piatto vertebrale;
2. l'alterazione interessa la matrice e probabilmente le cellule;
3. la matrice presenta un basso numero di fibre collagene, che sono anche più sottili, ed un più alto contenuto di proteoglicani;
4. l'ossificazione encondrale è alterata;
5. l'accrescimento longitudinale delle vertebre varia in rapporto alle differenti regioni anormali;
6. l'aspetto radiografico deve essere interpretato, quindi, come un'assenza di crescita piuttosto che una distruzione delle aree ossee.
In conformità a queste premesse si può asserire che il morbo di Scheuermann è patogenicamente causato da un disturbo dell'ossificazione encondrale che determina un 'alterazione della crescita longitudinale del piatto vertebrale.
Ciò che alle indagini radiografiche appare come erosione è dovuto ad un difetto assoluto dell'ossificazione, mentre le aree che appaiono radiologicamente normali, presentano un'accelerazione della crescita, dimostrata dall'iperplasia della cartilagine di coniugazione.
L'influenza dei fattori meccanici ha un effetto sfavorevole poiché tendono ad aumentare la cuneizzazione, favorendo la cifosi.
Studio radiologico
Lo studio radiografico comprende l'esame del rachide in toto in ortostasi in proiezione latero-laterale, con le braccia tenute parallele al terreno. Ciò permette di visualizzare completamente la silhouette, valutando l'entità della cifosi toracica, la lordosi cervicale e lombare.
Il normale valore di cifosi toracica è compreso tra i 20° e i 40° secondo Cobb.
La misurazione è eseguita tracciando le linee tangenti al piatto superiore della vertebra craniale più inclinata verso la curvatura cifotica e la linea tangente al piatto inferiore della vertebra caudale più inclinata verso la curvatura.
L'angolo formato da queste due linee è l'angolo di cifosi.
Il piatto sacrale è considerato la vertebra limite inferiore per la misurazione della lordosi.
Lo studio deve essere integrato da proiezioni in antero-posteriore in ortostasi, che mette in evidenza la presenza di scoliosi associata e da proiezioni in latero-laterale in clinostasi e nella stessa posizione con aggiunta di un cuneo posto all'apice della curva.
Queste due proiezioni, specie la seconda, permettono di valutare la riducibilità e la conseguente rigidità della curva.
In queste proiezioni è inoltre maggiormente valutabile l'entità della cuneizzazione vertebrale, peraltro visualizzabile anche alle Rx standard sottocarico, e l'irregolarità dei piatti vertebrali, caratteristiche del m. di Scheuermann.
Tali alterazioni sono maggiormente definibili con tagli stratigrafici eseguiti in proiezione laterale. Essi mostrano i segni patognomonici dello Scheuermann: la cuneizzazione vertebrale, i noduli di Schmorl, le irregolarità dei piatti vertebrali. Bradford a tale proposito indica come criteri di diagnosi del m. di Scheuermann i seguenti:
l. irregolarità dei profili dei piatti vertebrali superiori ed inferiori;
2. apparente restrizione dello spazio discale;
3. una cuneizzazione vertebrale maggiore a 5° in una o più vertebre;
4. una cifosi superiore ai 40°.
È importante rilevare che la diagnosi di m. di Scheuermann non richiede la presenza contemporanea di tutti e quattro questi segni. In ultimo deve essere associata una radiografia della mano e polso sx. che valuterà l'età ossea del paziente, che in associazione al test di Risser valutabile nella Rx in AP sotto carico in toto, definirà il livello di maturità raggiunta.
Esame clinico
Come in precedenza detto la cifosi, fin dall'atteggiamento a «C» totale dei neonati, è un'elemento essenziale dell'assetto rachideo.
Escludendo le forme ad eziologia congenita, neuromuscolare, infiammatoria, traumatica, che sono come frequenza percentualmente minori, per il m. di Scheuermann e per le idiopatiche, l'inizio della deformità avviene in età prepuberale, generalmente intorno ai 10 anni.
Particolarmente per quanto riguarda la cifosi da m. di Scheuermann non è mai stata individuata prima di questa età, alcuna cuneizzazione vertebrale.
È per questo che molte forme di m. di Scheuermann non sono inizialmente riconosciute al loro esordio, e sono altresì definite come cifosi asteniche.
È necessario rilevare la differenza esistente tra cifosi da morbo di Scheuermann e quella idiopatica (forme strutturate) con la cifosi astenica (forma non strutturata).
Carattere distintivo è rappresentato dalla rigidità, sia clinica che radiografica della curva, che nello Scheuermann è associata alla cuneizzazione vertebrale, che ne sottolinea il carattere di strutturazione.
Le cifosi asteniche non presentano questa caratteristica di rigidità e in esse la flessione anteriore del tronco porta ad una normalizzazione del profilo laterale del dorso, mentre nelle forme strutturate tale manovra determina un incremento della deformità.
I soggetti con cifosi da m. di Scheuermann sono generalmente più atletici e muscolati di quelli con cifosi di tipo astenico e possono presentare una tensione o contrattura dei muscoli pettorali e degli ischiocrurali.
È possibile individuare due tipi differenti di cifosi nel morbo di Scheuermann: la forma toracica con apice compreso tra T7 e T9, e la forma toracolombare con apice compreso tra TIO e T12.
La prima si caratterizza clinicamente da un aumento della cifosi dorsale, della lordosi lombare e cervicale, per meccanismo di compenso, cifosi che aumenta con la flessione anteriore del tronco.
Spesso in corrispondenza della spinosa posta all'apice della curvatura esistono macchie d'iperpigmentazione cutanea, espressione di un aumentato contatto tra dorso e schienali delle sedie.
Non è infrequente inoltre l'associazione di questa cifosi a scoliosi che seppur strutturate hanno un andamento benigno e di cui se né possono distinguere due tipi: il primo in cui apice di cifosi e di scoliosi coincidono, hanno una scarsa rotazione e tale rotazione può avvenire verso la convessità delle curve; il secondo presenta curvature scoliotiche sopra o, più spesso, sottostanti all'apice di cifosi e hanno caratteristiche simili a quelle idiopatiche compresa la rotazione verso la concavità della curva.
Le forme toraco-lombari sono caratterizzate da notevole rigidità, paradossalmente l'esistenza dell'apice di cifosi più in basso determina una riduzione della cifosi dorsale alta.
Spesso tale tipo si associa a dolore e questo può essere la causa della diagnosi, mentre non presenta le deformazioni somatiche caratteristiche delle forme con apice più alto.
Oltre all'aspetto estetico, una delle caratteristiche delle cifosi strutturali è il dolore che inizialmente poco frequente, con un'incidenza intorno al 20%, raggiunge la massima incidenza (60%) con il progredire dell'accrescimento, riducendosi al raggiungimento della maturità ossea.
A questo punto diventa circoscritto alle zone periapicali con un'irradiazione verso l'alto e più spesso verso il basso.
Una palpazione accurata dei soggetti con cifosi da m. di Scheuermann, ma che non riferiscono spontaneamente dolore, può mettere in evidenza una mappa di tensione intorno all'apice della cifosi e nella porzione sovrastante ad esso.
Il dolore comunque tende ad essere più frequente a livello del limite cervicotoracico e nella regione interscapolare.
L'esame clinico vero e proprio può essere eseguito con la misurazione delle frecce sagittali, cioè la distanza intercorrente tra il filo a piombo tangente all'apice di cifosi e la spinosa di C7, a livello superiore, e tra il filo a piombo e il punto di massima lordosi, a livello inferiore.
Normalmente la somma delle due distanze varia da 60 a 80 mm ed è più bassa nei soggetti in accrescimento.
L'esame deve continuare con il paziente flesso in avanti e con il torace appoggiato su un tavolo da esame, a ginocchia flesse.
Tale posizione permette di apprezzare le deformità strutturali e la sede del dolore.
Anche la manovra di deflessione della curva, eseguita o con il tronco del paziente flesso in avanti a ginocchia estese a mani incrociate dietro la nuca e gomiti in retropulsione o con la stessa manovra eseguita a paziente seduto, è una prova atta a valutare la riducibilità attiva della deformità e quindi la sua rigidità.
Diagnosi differenziale
Si pone con le cifosi posturali, nelle quali l'esame Rx non evidenzia cuneizzazione vertebrale, né irregolarità del piatto, ma che mostrano una completa riducibilità dell'ipercifosi al test d'iperestensione passiva eseguita con il cuneo apicale.
È stata identificata una forma d'ipercifosi completamente differente da quella da m. di Scheuermann che Stagnara ha definito idiopatica.
In questa forma non esistono alterazioni del profilo vertebrale ma è presente una marcata rigidità della curva cifotica.
L'evoluzione di queste curve è similare a quella delle scoliosi idiopatiche.
Le spondiliti specifiche o aspecifiche possono essere confuse con il m. di Scheuermann ma in esse le irregolarità vertebrali sono adiacenti al disco interessato e non presentano un bordo sclerotico avvolgente le aree d'erosione.
Le forme osteocondrodisplasiche presentano degli interessamenti epifisometafisari in altri distretti.
In ultimo bisogna ricordare che in alcune forme di cifosi congenite, si può verificare una fusione intersomatica nello stesso periodo nel quale compare il m. di Scheuermann, il quale non presenta mai la tendenza a formare fusioni intersomatiche anteriori.
Laddove esistessero, queste fusioni avvengono attraverso osteofiti anteriori al disco intervertebrale.
Trattamento
In linea di massima potremo definire 4 situazioni che necessitano di trattamento, cruento o incruento:
l. un rapido aumento della cifosi;
2. un aumento delle lesioni vertebrali con incremento della cuneizzazione;
3. dolore correlato alla cifosi dorsale e che non risponde a trattamento antalgico;
4. alterazioni respiratorie in rapporto alla deformità rachidea.
In ogni modo si può affermare che in genere gli adolescenti con un incremento medio della cifosi toracica tra i 40° e i 50° senza un'evidente progressione, necessitano solo di controlli periodici e di una sana attività fisica, specie sport in estensione tipo basket e volley.
Come per la scoliosi anche la cifosi si avvale, quando c'è bisogno, di una terapia più mirata: della Kinesiterapia, dell'uso di corsetti e gessi e, infine, del trattamento chirurgico.
La Kinesiterapia ha come finalità di mantenere la flessibilità delle curve, correggere la lordosi lombare e rinforzare i muscoli estensori.
Questo tipo di terapia è sempre applicabile, ma è da tenere presente che essa è particolarmente utile nei primi stadi della deformità o come complemento di terapie più drastiche, quali busti o corsetti e della terapia chirurgica.
I corsetti: le cifosi strutturali rispondono bene al trattamento con ortesi ortopediche, specie nei primi stadi della deformità e in ogni modo prima che si raggiunga la maturità scheletrica.
Le indicazioni sono le cifosi flessibili cioè quelle che presentano al test di correzione passiva (sia clinicamente, che alla Rx con cuneo) una riducibilità non inferiore al 40% e con un valore angolare compreso tra i 50° e i 75°. Il corsetto più usato è certamente il Milwaukee, con spinte simmetriche a livello dell'apice della cifosi, e il cui canestro pelvico è confezionato riducendo la lordosi.
È particolarmente indicato nelle cifosi con apice compreso tra T6 e T9.
La sua controindicazione principale è di tipo psicologico per la presenza dell'appoggio occipito-mentoniero, che lo rende di difficile accettazione da parte dei pazienti.
Per cui molti autori preferiscono usare quando è possibile, particolarmente nelle forme con apice a livello più basso di T9, corsetti bassi come quello ideato da Zielke, costituito da 4 valve ad azione correggente a livello toracico e lombare.
È da ritenere d'altra parte che tali tipi di corsetti, non avendo l'azione d'elongazione attiva fornita proprio tramite l'anello occipito-mentoniero, siano validi nelle curve particolarmente flessibili e con apice posto sotto T9.
Le forme toracolombari di Scheuermann rispondono bene all'uso di corsetti bassi che riducono la lordosi.
Trattamento con gessi
Quando vi è una notevole rigidità è consigliabile l'uso di gessi, preceduti da una fisioterapia preparatoria, quindi l'esecuzione di 2 o 3 gessi antigravitari e quindi il mantenimento con un corsetto fino alla maturità ossea.
Oltre questo tipo di gesso n'esistono altri tipi come quelli eseguiti sul letto di Risser o di Cotrel, la cui utilizzazione è in rapporto alla preferenza delle diverse scuole.
Come per la scoliosi anche nella cifosi il ritorno dei valori angolari prossimi a quelli di partenza è da considerare un successo del trattamento, portando i valori terminali, a fine accrescimento, intorno a quei 40-50° da considerarsi fisiologici, inoltre bloccando il peggioramento.
In conclusione possiamo asserire che nelle forme di cifosi strutturali allo stato iniziale, con valori angolari compresi tra i 45° e i 65 °, con una distensibilità non inferiore al 40%, i corsetti, specie il Milwaukee, hanno una valida efficacia.
Le cifosi più rigide dovrebbero essere trattate preventivamente con gessi, seguiti da corsetti; questo tipo di trattamento non è consigliabile da condurre nel periodo post-puberale, in cui vi è un'alta percentuale di perdita di correzione.
Infatti, se vi è una cuneizzazione vertebrale in un soggetto pre-pubere, per cui si suppone un periodo abbastanza lungo di ripresa e rimodellamento del piatto vertebrale, trova indicazione un trattamento ortopedico, specie se la curva non è rigida.
Se invece ci si trova nel periodo post-pubere con ampia cuneizzazione vertebrale, intorno ai 10°, il trattamento ortopedico non è efficace poiché al termine si tornano ad avere situazioni simili alla partenza, dato lo scarso tempo a disposizione per un'eventuale rimodellamento del piatto vertebrale.
Trattamento chirurgico
Oltre i 75° Cobb e con una riducibilità della cifosi sotto i 50° ai test in iperestensione con cuneo, si può ricorrere ad una correzione chirurgica anche solo attraverso un tempo posteriore.
Allorquando invece non si raggiunge una riduzione della curva inferiore ai 50%, si deve tenere in considerazione la necessità di due tempi di correzione chirurgica, uno per via anteriore, seguito da uno per via posteriore.
Tanto più sono gravi le curve e tanto è maggiore la necessità di una correzione preoperatoria, utilizzando le varie metodiche già descritte nella parte riservata alla scoliosi.
Le forme più gravi ed importanti, specie degli adulti, possono richiedere addirittura tre tempi, secondo lo schema proposto da Stagnara, che prevede un primo accesso anteriore di osteotomia e parziale correzione, il secondo di correzione artrodesi con strumentari metallici per via posteriore e in ultimo il terzo tempo anteriore di artrodesi con blocchi costali.
Le tecniche d'aggressione chirurgica e di osteosintesi sono le medesime usate per il trattamento della scoliosi.
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025