|
|
| |
Francesco Bacone (1561 - 1626)
Vita e opere
Si ha l'impressione che il metodo fino allora seguito sia sbagliato
Le conclusioni della fisica aristotelica sono contraddette dall'esperienza.
Superare questa concezione: novum organon.
Ideale del sapere per potere.
Si ripropone di ricostruire l'edificio del sapere nell'instauratio magna: è un ideale ancora medievale di scienza, ma è consapevole della difficoltà. Non è da scartare per l'influenza sui posteri.
Divisione delle scienze
Natura Uomo Dio
La suddivisione del sapere riprende quella delle
facoltà dell'anima:
![]() Scienza di memoria: è la storia.
Scienza di memoria: è la storia.
Scienza di fantasia: è la poesia.
![]()
![]() Scienza di ragione: è la filosofia, il cui oggetto è:
Scienza di ragione: è la filosofia, il cui oggetto è:
A fondamento di queste tre parti di filosofia sta la filosofia fondamentale, che tratta aspetti comuni a tutti gli oggetti del sapere: condizioni trascendenti. Non manifesta una gran fiducia in tale scienza.
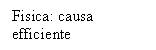
![]()
![]()
![]()
![]()
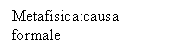
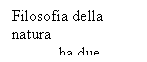
![]()
![]()
Afferma poi che l'ammettere la finalità è ben diverso dal poter capire il fine degli eventi naturali: lo studio si concentrerà sulle cause formali dalle quali procedono i fenomeni naturali.
Il metodo. Pars destruens
Il novum organon si divide in due libri: il primo critico, l'altro costruttivo (incompiuto). La novità del metodo consiste essenzialmente in:
Fondamentale nell'acquisizione del sapere è l'induzione, non la deduzione sillogistica.
Il passaggio particolare universale deve avvenire gradatamente, attraverso assiomi medi.
Gli assiomi medi non si trovano a caso, ma seguendo regole.
![]()
![]()
![]()
![]()
Idola sono nostre immaginazioni nei confronti di idee divine: queste ultime istituiscono la realtà, che ne porta le tracce nella sua struttura. La conoscenza vera si ha solo se seguiamo queste tracce; se vogliamo proiettare le nostre idee sulle cose, non raggiungiamo il sapere:
Idola tribus: dipendono dalla natura umana. Tendenza ad assumere ciò che appare come la realtà stessa delle cose.
Idola specus: radicati nel comportamento individuale.
Idola fori: preconcetti che nascono con l'uso del linguaggio. Si usano parole senza rendersi conto del loro significato.
Idola theatri: preconcetti inculcati dalle scuole fi 353b16d losofiche.
Le due vie del sapere
La prima parte dal particolare e vola subito agli assiomi generalissimi, e giudica secondo questi principi. La seconda dal particolare trae gli assiomi per gradi fino ad arrivare ai più generali. Questa è la vera via: il rimprovero alla fisica tradizionale è dunque quello di aver avuto fretta, e aver proceduto senza metodo.
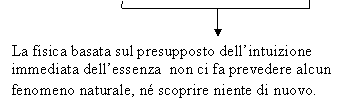
I caratteri del vero sapere
Corpi individui, che sono le sole cose
esistenti Nature semplici, o qualità dei corpi Forme, dalle quali derivano le nature
semplici. È qualcosa di individuo e dinamico. Scoprirla vuol dire conoscere
la legge secondo cui operano i corpi.
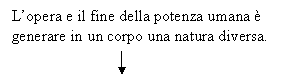
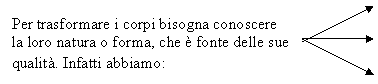
La fisica deve risalire dalle qualità sensibili dei corpi al processo nascosto che le genera e allo schematismo nascosto, che è la loro struttura profonda. Questi due momenti sono espressioni della forma, che è oggetto di metafisica, e insieme alla quale si scopre anche la legge di comportamento del fenomeno esprimibile con un assioma.
L'assioma si scopre con l'induzione vera, che deve partire dall'osservazione dei fatti per poi ordinarli:
Tabula praesentiae: enumerazione dei fatti in cui si presenta un dato fenomeno.
Tabula absentiae: casi simili ai precedenti in cui il fenomeno manca.
Tabula graduum: casi nei quali la natura studiata è presente in vari gradi.
Dopodichè si può procedere ad una esclusione e ad una prima ipotesi, che va verificata dall'esperienza.
Etica
Critica dell'etica antica: ci ha dato esempi di virtù senza dire come arrivarci. L'etica di divide in due parti:
Dottrina dell'ideale (felicità): inutile in quanto il cristianesimo ci dice che la felicità è altrove.
Dottrina della cultura d'animo (virtù).
È insita nella natura una tendenza sia al bene collettivo (da preferire) sia al bene individuale. Si deve affermare il primato della vita attiva: la contemplazione riguarda solo il bene privato. La filosofia ha lo scopo non di arrivare alla salute o alla tranquillità , bensì di risolvere le difficoltà della vita sociale.
Il primato della vita attiva si attua anche nel bene individuale: ogni cosa mostra tendenza a conservarsi (bene passivo) e a moltiplicarsi (bene attivo); esso non si identifica col bene comune.
Bene comune solo in rapporto alla società si può parlare di dovere.
![]()
La dottrina del dovere non riguarda solo
la scienza civile, ma anche il dominio di sé, e di divide in: Dovere dell'uomo in generale Dovere dell'uomo come
professionista
Per sapere come coltivarci, dobbiamo sapere cosa siamo in grado di fare. Bisogna descrivere prima di prescrivere. Importanza dello studio dell'uomo (psicologia).
Galileo Galilei (1564 - 1642)
A Pisa
Dagli studi di medicina passa a quelli di matematica e di filosofia naturale, o physica. Le sue convinzioni metodologiche sono chiare fin da subito: la matematica è il modello dei discorsi, l'esperienza il loro contenuto.
A Padova
![]()
![]() Molta più libertà di pensiero. Insegnava anche astronomia secondo il
sistema tolemaico, ma da tempo seguiva quello copernicano. Altra attività:
perfezionamento degli strumenti.
Molta più libertà di pensiero. Insegnava anche astronomia secondo il
sistema tolemaico, ma da tempo seguiva quello copernicano. Altra attività:
perfezionamento degli strumenti.
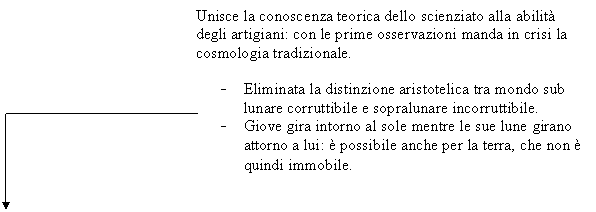
Non solo le osservazione astronomiche, ma anche le ricerche meccaniche gli facevano guadagnare argomenti a favore del sistema copernicano (scoperta della relatività classica). Le scoperte fatte grazie al telescopio furono però accolte con diffidenza e disprezzo: i contemporanei erano disorientati e impauriti.
![]()
Una grave minaccia arrivava dai teologi
"aristotelici": per contraddire Galileo invocavano anche la sacra
scrittura.
I processi
Nel 1611 veniva accolto trionfalmente a Roma, ma i suoi nemici lavoravano contro di lui, che da parte sua offriva pretesti di scontro a causa della pungente ironia delle sue discussioni.
Cosimo Boscaglia accusa la teoria copernicana di essere contraria alla Bibbia (Giusuè ferma il sole).
Galileo si difende: bisogna distinguere il testo sacro (sempre vero) dalle interpretazione che ne vengono date. L'interpretazione letterale è spesso fallace.
L'intenzione dello Spirito è di insegnare come si vada in cielo, e non come vada il cielo.
Ma commise un'imprudenza: un laico che dava lezioni di esegesi biblica non poteva che allarmare i teologi: nel 1616 la teoria copernicana fu condannata, e Galileo fu ammonito ad abbandonarla. Galileo si fece più ottimista alla notizia dell'avvento del nuovo papa Barberini.
Quando egli diventò papa Urbano VIII, Galileo compose il suo Dialogo dei massimi sistemi e lo sottopose al pontefice, che ne avrebbe permesso la pubblicazione solo se la teoria copernicana fosse stata presentata come ipotesi matematica.
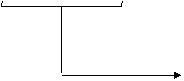
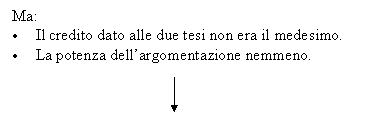
Il 22 giugno 1633 dovette abiurare la
teoria copernicana. Il fatto deplorevole è che, in luogo della discussione
sulla dottrina, si preferì condannare un uomo. Ciò sarebbe valso anche nel
caso in cui la teoria di Galileo fosse stata sbagliata.
Galileo filosofo
![]()
![]() Galileo intendeva la
filosofia come fisica: essere filosofo era sinonimo di studioso della natura,
non solo limitarsi a formulare ipotesi matematiche.
Galileo intendeva la
filosofia come fisica: essere filosofo era sinonimo di studioso della natura,
non solo limitarsi a formulare ipotesi matematiche.
Egli non solo poi proclama la superiorità della ragione sull'autorità, ma mette in pratica con costanza questo principio. Galileo è filosofo perché ha una nuova concezione della verità, opposta a quella della tradizione scolastica medievale: è la verità scientifica.
Nuovo concetto di scienza
L'idea di sapere dimostrativo è modellata sulla geometria:
A fondamento della dimostrazione stanno gli assiomi.
Assieme a ipotesi e postulati, sono considerati per sé evidenti.
La dimostrazione presuppone anche definizioni.
Le proposizioni universali per Aristotele
si conoscono per induzione, ma non ha mai prodotto una teoria
dell'induzione.
![]() La dimostrazione
aristotelica è sillogistica: rapporto fra due nozioni in virtù di un termine
medio. L'obiezione di Galileo riguarda non il sillogismo, ma il come dello
scoprire i postulati e le definizioni che stanno a fondamento della fisica.
La dimostrazione
aristotelica è sillogistica: rapporto fra due nozioni in virtù di un termine
medio. L'obiezione di Galileo riguarda non il sillogismo, ma il come dello
scoprire i postulati e le definizioni che stanno a fondamento della fisica.
Galileo individua il motivo nel fatto che
la scienza precede la metodologia.
Una scienza rigorosa deve procedere come la geometria: cominciare da definizioni ed assiomi per arrivare alla dimostrazione dei teoremi.
Bisogna però assicurarsi del valore delle definizioni:
Devono essere fondate sull'esperienza.
Ciò è più complicato di quanto credessero gli antichi
Non avevano strumenti
Non esercitavano controllo
A queste considerazioni, se vogliamo ancora un po' baconiane, ne aggiunge almeno un'altra originale: è impossibile cercare l'essenza dei corpi. Infatti essa viene descritta da qualità sensibili, che non sono notizie intrinseche.
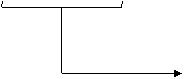
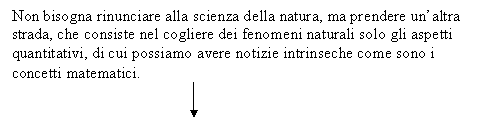
Anziché speculare su essenze che non
conosciamo, si definisce l'essenza di un fenomeno in base alla legge del
suo comportamento, espressa in termini matematici. Questo è il nuovo tipo
di sapere che noi chiamiamo scienza.
Questo nuovo sapere sostituisce l'antico?
La scienza sostituisce cioè la filosofia?
![]()
![]() Due problemi:
Due problemi:
Definire i fenomeni secondo leggi
matematiche esaurisce la loro realtà? Le essenze dei corpi si riducono agli
aspetti considerati dalla scienza?
Ma Galileo non cercava di costruire una metafisica sulla base della nuova scienza, e nemmeno una nuova filosofica della natura (determinazione delle cause prime della natura). È ciò che gli rimprovera Cartesio.
Pierre Gassendi (1592 - 1655)
Autore delle V obiezioni alle meditazioni metafisiche di Caartesio. Molto forte la polemica tra i due.
Aristotelismo ed epicureismo
Sono due gli elementi fondamentali del suo pensiero:
Critica all'aristotelismo: "esercitazioni in forma di paradosso contro gli aristotelici". Espone una critica serrata al principio di autorità, rivendicando la libertà del filosofare e di conoscere direttamente, con una spinte all'eclettismo.
![]() Critica della dialettica: lo scopo non è l'arte delle dispute, ma
giungere alla verità e goderne.
Critica della dialettica: lo scopo non è l'arte delle dispute, ma
giungere alla verità e goderne.
Rivalutazione dell'esperienza e del sapere
"umile". Ideale di scienza come sapere storico, progressivo e perfettibile. Equivalenza tra conoscere e fare. Gli
oggetti di dividono in: Naturali Artificiali L'uomo non può cogliere la verità della
natura nella sua essenza, perché non ne è l'artefice.
![]()
"De vita et moribus epicuri".
Traduzione e commento a Diogene Laterzio.
"Sintagma filosofico (1651)".
![]()
![]() L'opera omnia è Abrège de la philosophie de Gassendì, con cui verrà a
contatto Locke. Perché la scelta per l'epicureismo? Perché esso è congeniale
L'opera omnia è Abrège de la philosophie de Gassendì, con cui verrà a
contatto Locke. Perché la scelta per l'epicureismo? Perché esso è congeniale
Nessuna pretesa di metafisica come scienza.
Conciliazione con verità di fede.
Nessuna pretesa di autorità incontrovertibile.
Teoria della conoscenza
Criterio di certezza immediata: sensibilità, da cui si forma l'idea che è rappresentazione dell'oggetto esperito. Non si danno idee innate.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ogni idea deriva dai sensi: il passaggio dall'idea singola alla generale o composta si ha eliminando le caratteristiche singolarizzanti. L'idea generale non è comunque una essenza, e non può prescindere dall'idea concreta. Dall'idea generale si forma il giudizio, attraverso la copula "è".
![]() Concezione della natura
Concezione della natura
Modifiche per adattare al cristianesimo: Atomi non eterni, ma creati e
annientabili da Dio. Finalismo che sostiene il
meccanicismo. Anima composta da una parte
materiale che muore, e da una immateriale e immortale creata da Dio. Si presta bene al nuovo ideale di scienza
meccanicista. È una fisica molto diversa da quella cartesiana, e lo si vede
da: La materia non è divisibile
all'infinito, ma si danno atomi. L'universo non è pieno:
condizione di movimento è il vuoto. La materia non è inerte e
passiva (necessità di Dio), ma è attiva. Moto Vuoto Atomi
![]()
![]()

![]() Atomismo:
Atomismo:
Etica
Coniugazione dell'etica epicurea (piano della felicità umana) con l'etica cristiana (piano della felicità perfetta). I due cardini dell'etica cono piacere e dolore.
La voluptas è fine ultimo degli altri
piaceri. La virtù non è fine a sé stessa, ma è mezzo per il conseguimento
della felicità I beni dello spirito hanno comunque
primato sui beni del corpo, e la tranquillità dell'animo sulla salute del
corpo.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() La voluptas non è piacere corporeo, ma gioia e serenità: piacere
catastematico, quiete.
La voluptas non è piacere corporeo, ma gioia e serenità: piacere
catastematico, quiete.
Virtù fondamentale è la prudenza, che prescrive ciò che è da fuggire e ciò che è da seguire. È calcolo dei piaceri e delle conseguenze delle azioni. Polemica contro etica stoica:
Etica inumana.
Non è vero che c'è distanza tra virtù e piacere.
Le passioni non si possono estirpare, se non a patto di estirpare anche l'umanità. All'apatia stoica va sostituita una moderazione delle passioni (Metropatia). Seguendo le passioni naturali e necessarie si vive secondo natura.
Altra virtù centrale è la temperanza, il sapersi limitare a ciò che è naturale e necessario.
Modo migliore per raggiungere la salite del corpo.
Autarchia
Ottimismo antropologico: uomo è naturalmente limitato, ma non per il peccato.
Libertini e Giansenisti
Il clima di pensiero libertino ha costituito una delle componenti fondamentali della cultura francese del XVII secolo; lo stesso vale per le tesi fondamentali del pensiero giansenista.
Critica al tipo del cristiano
Presa di coscienza in seguito a scoperte geografiche: pluralità delle condizioni dell'esistenza umana.
Umanità non è incarnazione di un archetipo universale.
Messa in crisi del tipo d'uomo presentato come il più completo: il cristiano.
Il piano sul quale si attua il ripensamento più radicale è quello morale :
Indipendenza della morale dalla religione:
la morale si fonda solo su quel senso di bontà innato che ogni uomo ha nel
cuore; la vita morale è solo sviluppo di ciò Quando la religione diventa faziosità e
bigottismo non sviluppa più la moralità, ma la corrompe.
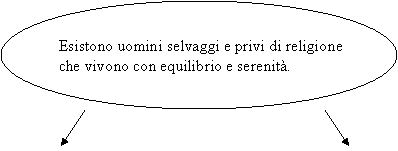
Posizione di
In una società fondata sulla forza e sull'astuzia, come si può essere umili?
I precetti evangelici non possono essere presi come punto di riferimento per la vita sociale.
Il cristiano non è più garante di un tipo d'universalità sulla quale si era fondato sino ad allora tutto un modo di pensare e vivere: servono nuove basi per ricomporre un nuova concezione dell'uomo.
Filosofia come vera religione
La verità non è frutto del numero, ma di
una mente che sa rettamente giudicare. La ragione unisce, l'opinione
divide. Necessità di staccarsi dalla moltitudine
per formare una èlite. Esiste una doppia universalità: puramente esteriore e
fondata sul numero, e qualitativa, vera universalità.
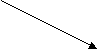
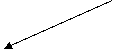
![]() I libertino è un uomo alla ricerca di una nuova universalità da
sostituire a quella che la religione fondava.
I libertino è un uomo alla ricerca di una nuova universalità da
sostituire a quella che la religione fondava.
La coscienza di ciò si trasforma in una vera e propria coscienza ecclesiale che surroga quella dell'appartenenza ad una confessione religiosa: in questa nuova chiesa, la religione che viene praticata è la filosofia.
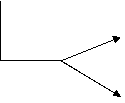
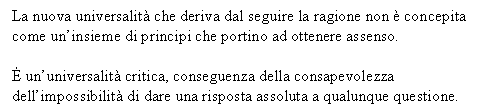
Il libertinismo segue due correnti:
Fino al 1660 circa presenta posizioni scettiche.
Demolizione di tutto ciò che è definitivo.
La religione è l'obbiettivo principale.
Scetticismo come propedeutico al cristianesimo.
Dopo il 1660 circa le posizioni si fanno meno radicali.
Deismo fondato sull'affermazione di un primo principio.
Un punto importante della critica della critica libertina alla religione è il suo rapporto con la politica: le religioni sono sorte come strumento in mano ai potenti equiparate ad ogni altro mezzo di mantenimento dell'ordine pubblico.
![]()
![]() Affermazione della
natura come suprema realtà, al pari delle filosofie naturalistiche: il culto
della natura diventava proposito di conformarlesi in ogni comportamento, allo
scopo di riconciliare virtù e natura, un tempo unite
Affermazione della
natura come suprema realtà, al pari delle filosofie naturalistiche: il culto
della natura diventava proposito di conformarlesi in ogni comportamento, allo
scopo di riconciliare virtù e natura, un tempo unite
Cristianesimo come comprensione esauriente
Caratteristica fondamentale del gruppo giansenista: la verità può essere incontrata solo superando i luoghi comuni al pari del libertinismo, il giansenismo sarà un movimento elitario. La pluralità di credenze religiose e morali solo superficialmente relativizza il cristianesimo, in realtà sottolinea la sua unicità.
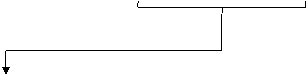
Argomento di Pascal, che
riprende un pensiero comune. L'uomo è insieme di grandezza
e miseria. L'errore delle filosofie è
considerare uno solo di questi aspetti.
Solo il cristianesimo riesce a superare la contraddizione: perché una religione sia vera, infatti, deve aver conosciuto la nostra natura nella sua grandezza e piccolezza. Quale religione lo ha fatto, se non quella cristiana? La tesi libertina non regge più , e va capovolta.
La loro filosofia non può essere vera religione, perché ignora una componente fondamentale dell'essere umano, di cui il cristianesimo tiene conto e dà una spiegazione. Non avendo una giusta comprensione dell'uomo, il pensiero libertino non può nemmeno fornire una morale adeguata.
Serve ai giansenisti a fare propria
l'istanza di riforma della religione dei Libertini.
Ritorno alla semplicità e all'interiorità
tipiche della religione naturale.
![]() Ruolo del dogma del
peccato originale:
Ruolo del dogma del
peccato originale:
Da un lato parallelismo tra risposta Libertina e Giansenista, ma anche divergenza: per questi ultimi richiamo alle origini significa ritorno al Cristianesimo dei Padri, che aveva proprio nei dogmi del peccato originale e della grazia i suoi cardini. I giansenisti dunque combattono su due fronti:
![]()
Si oppongono
alla corrente dell' umanesimo devoto: Si oppongono ai
Molinisti, che ritengono che l'efficacia della grazia dipenda dal volere
dell'uomo.
Dare così grande peso al dogma del peccato significava sollevare il problema del ruolo delle risorse umane nell'economia della salvezza. Proprio su questo punto il fronte giansenista perde la sua unità.
Il giansenismo delle origini (Pascal), definito estremista, ha una visione nettamente svalutativa delle realtà terrene. A fare le spese di questa svalutazione fu la ragione.
Attorno alla metà del secolo si fa largo la corrente centrista (Arnaud e Nicole). Rimane il principio di decadimento come conseguenza del peccato, ma non ritengono assolutamente senza valore le realtà terrene ed umane. Essi intuiscono la pericolosità di costruire un'apologia del cristianesimo su base scettica. Era necessario aprire un varco tra i due estremi della credulità (attaccato dei libertini) e dello scetticismo (contestato dai giansenisti).
Una virtù che porta all'estraniarsi da
ogni impegno porta al disinteresse (è la posizione libertina). La
perfezione cristiana deve mostrare la sua validità convenendo per ad ogni
occupazione e condizione.
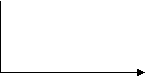
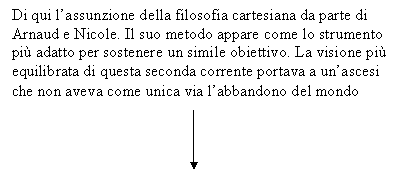
Blaise Pascal (1623 - 1662)
Vita e opere
A Parigi, Pascal potè venire in contatto coi più illustri scienziati. Rivelò spontaneamente e precocemente un genio matematico fuori dal comune. Stesso atteggiamento verso la scienza di Galileo, Bacone.:
Quando si tratta di fisica, e vano rivolgersi agli antichi.
A differenza di Cartesio, però, nessuna volontà di rinnovare la metafisica.
1646: Prima Conversione di Pascal Decisione di dedicare la vita a Dio. Incontra Cartesio a Parigi.
1651: Morì il padre di Pascal: comincia un periodo mondano e salottiero.
1654: seconda e definitiva conversione di Pascal. Dopo un'illuminazione, decide di dedicarsialla
preghiera, alla mortificazione e alla Bibbia.
Stoicismo e scetticismo
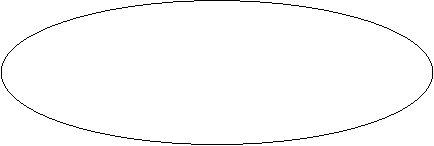
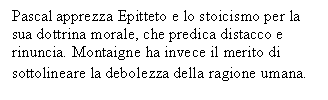


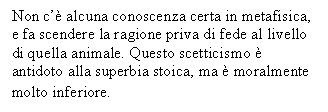
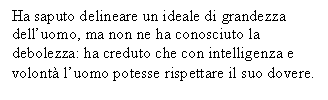
Il potere della ragione
La ragione si identifica per Pascal nell'esprit géométrique: la geometria è l'unica vera applicazione della logica. Esiste un ideale metodologico ancora superiore a quello geometrico, ovvero definire ogni termine e dimostrare ogni preposizione, ma è inattuabile.
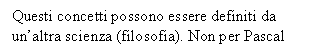
![]()
![]() La geometria suppone
concetti non definiti:
La geometria suppone
concetti non definiti:
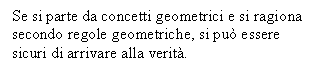 abbiamo due alternative
percorribili.
abbiamo due alternative
percorribili.
I limiti della ragione
Se la ragione si identifica con l'esprit géométrique, l'intelligenza è più della ragione: è esprit de finesse.
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()

![]()
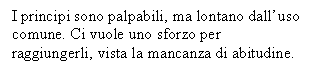
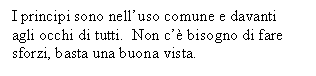
Nel concreto i principi astratti sono appena visibili; ragionare astrattamente su realtà concrete è vano.
![]()
Le cose che ci premono, che contano, non riusciamo a conoscerle con la ragione, e quelle che riusciamo a cogliere con la ragione sono inutili. Quando invece si tratta di conoscere il principio e la fine delle cose, la nostra ragione è impotente. Questa impotenza non dipende dalla natura umana, ma dalla sua situazione esistenziale:
L'uomo si lascia guidare dall'immaginazione.
Altro elemento che influisce sui nostri giudizi è la consuetudine.
Influente sui nosrti giudizi è anche il gusto, ciò che ci fa piacere.
A Dio non si arriva con la ragione
Dio non si può raggiungere con la ragione,
nemmeno allargandola fino a comprendere anche il senso di intellectus. Dio
è una Persona con cui ci si incontra.
![]()
![]() Il Dio dei cristiani non è il creatore delle verità geometriche o
dell'ordine degli elementi: pagano. E questo vale anche per le dimostrazioni
metafisiche dell'esistenza di Dio.
Il Dio dei cristiani non è il creatore delle verità geometriche o
dell'ordine degli elementi: pagano. E questo vale anche per le dimostrazioni
metafisiche dell'esistenza di Dio.
Il cuore
La ragione senza il cuore non serve, il cuore senza la ragione invece basta. La ragione è soggetta alla sensibilità dell'uomo (impressioni, consuetudini...), dal meccanismo del suo corpo, che è machine.
![]()
![]()
![]() Se "pieghiamo la machine" ci tireremodietro anche aal ragione
Se "pieghiamo la machine" ci tireremodietro anche aal ragione
Piegare la macchina significa compiere gli
atti esteriori della religione. Essi non costituiscono la religione, ma
sono mossi dalla volontà di credere, devono esprimere la nostra umiltà
Il "pari"
Quale motivo diamo all'ascesi (plier la machine) se non vi è certezza razionale? Agli argomenti razionali di dimostrazione di Dio, Pascal sostituisce il pari, la scommessa. Vale la pena di scommettere che ci sia, perché è in gioco il nostro destino.
Da una parte c'è il finito, dall'altra l'infinito: bisogna puntare sull'infinito.
L'adesione alle verità fondamentali richiede volontà, rischio, scommessa.
Pascal ha sempre considerato la ragione nelle sue condizioni esistenziali, soggetta a fantasia e capricci, e macchiata dal peccato. È di questa ragione che non ha una gran considerazione.
L'analisi dell'uomo
La nostra dignità consiste dunque nel
pensiero, che è coscienza del limite. Le antinomie di cui si compone la
vita dell'uomo (angelo \ bestia) sono segno della corruzione della natura
umana, sanabile solo dalla grazia. Ma non siamo solo questo: il fatto di
sentire il desiderio di una pienezza d'essere che non abbiamo, attesta al
nostra grandezza. L'uomo è debole come un fuscello, ma quand'anche
l'universo lo schiacciasse, resterebbe più nobile di ciò che lo uccide.
![]()
![]()
![]()
![]() Orientata intorno ai poli della grandezza e miseria. Pascal descrive la
condizione umana come dipendenza e desiderio di'indipendenza, coscienza di
contingenza, inquietudine. La nullità del nostro essere ci è rivelata nel
sentimento della noia.
Orientata intorno ai poli della grandezza e miseria. Pascal descrive la
condizione umana come dipendenza e desiderio di'indipendenza, coscienza di
contingenza, inquietudine. La nullità del nostro essere ci è rivelata nel
sentimento della noia.
Per risolvere le antinomie bisogna riconoscere tre ordini di realtà: la carne, lo spirito, la carità , che è grazia. Solo il cristianesimo risolve questo problema col mistero della redenzione, rivelato all'uomo dalla misericordia di Dio: senza fede l'uomo non risolve il problema della vita.
L'uomo deve conoscere entrambe le verità della rivelazione, cioè che esiste un Dio di cui l'uomo e capace, e che la sua corruzione lo rende indegno di Dio. Conoscere solo una delle due porta alla superbia dei filosofi o all'avvilimento delle bestie.
L'ultimo passo della ragione è riconoscere che esiste un'infinità di cose che la sorpassano.
Nicole Malebranche (1638 - 1715)
Problema dei rapporti tra estensione e pensiero
Dualismo cartesiano rendeva difficile la spiegazione del rapporto anima - corpo. Geulincx dà una sistemazione dell'occasionalismo: Dio ha fatto corpo e anima in modo che i loro moti si corrispondano, come due orologi sincronizzati. Siccome i corpi esterni non possono influire sull'anima, noi possiamo conoscere le nostre idee, ma le conosciamo come realtà che non dipendono da noi. Devono allora venirci da Dio.
Malebranche è stato uno spirito profondamente religioso, e ciò traspare nella sua visione della realtà. Legge il trattato sull'uomo di Cartesio e ne rimane folgorato. La divisione di spirito e corpo e la riduzione del mondo sensibile a pura estensione sono la base delle sue due teorie fondamentali: occasionalismo e visione delle cose in Dio.
Anima e corpo. La conoscenza
Lo spirito umana si trova tra il creatore e le creature corporee. L'unione con Dio eleva lo spirito, l'unione col corpo abbassa l'uomo infinitamente, ed è la causa degli errori. Bisogna dimostrare che l'anima umana immediatamente unita a Dio e conosce ogni cosa in lui.
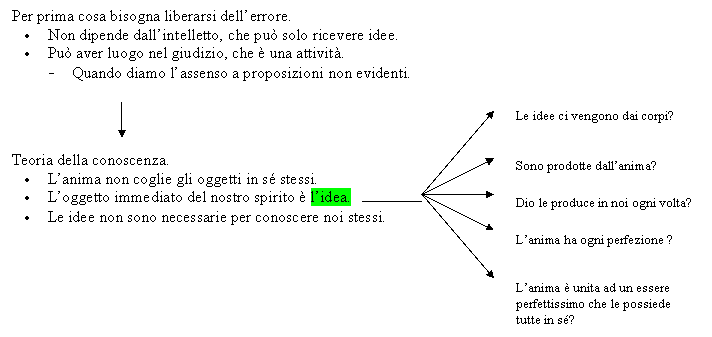
Ma le prime quattro mostrano in qualche modo una falla. Rimane la quinta soluzione, ovvero che vediamo le cose in Dio, che è strettamente unito alla nostra anima con la sua presenza. Malebranche parte dalla considerazione delle verità necessarie (come le geometriche), che non possono essere ricavate dall'esperienza, che è sempre conoscenza del singolare: derivano dalla luce divina. Concludendo il discorso, vengono enumerati quattro possibili tipi di conoscenza:
Viene sottolineata la differenza fra la conoscenza mediante idee e quella mediante sentimento: la prima chiara e distinta, la seconda oscura e confusa.
L'occasionalismo
Dio è l'unica causa efficiente: le creature sono occasioni per l'azione causale di Dio. Critica alla fisica di Aristotele: l'opinione che le qualità siano nei corpi è erronea e causa dell'errore più grave: attribuire alle creature efficacia causale.
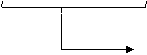
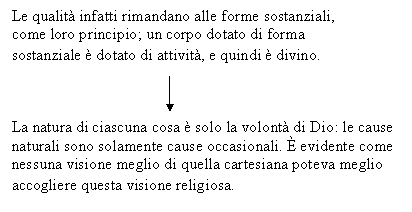
La morale
![]() Malebranche si allontana invece da Cartesio per la concezione delle
proposizioni universali, che per lui sono effettivamente realtà eterne
dipendenti dalle idee divine, e non da un semplice decreto divino.
Malebranche si allontana invece da Cartesio per la concezione delle
proposizioni universali, che per lui sono effettivamente realtà eterne
dipendenti dalle idee divine, e non da un semplice decreto divino.
Le inclinazioni sono i moti
che Dio imprime allo spirito. Sono rivolte prima a Dio e poi
all'autoconservazione. Inclinazione alla grandezza. Inclinazione al piacere. Siamo dunque inclinati al bene
in generale. Il bene verso gli altri è
amicizia, fondamento della società
civile.
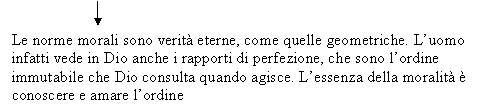
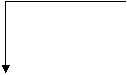
La teoria generale delle passioni è diversa da quella cartesiana, come conseguenza della diversa teoria dell'unione di anima e corpo. Critica anche la pretesa stoica che la ragione basti a mitigare le passioni. Le passioni sono volute da Dio, e il cristianesimo ci insegna ad accettarle e ad aspettare la liberazione da Dio.
B. Spinoza (1632 - 1677)
Vita e opere
Data di grande importanza: 1656: scomunica da parte della sua comunità ebraica. Ogni ebreo era tenuto a troncare ogni rapporto con Spinoza. Le sue opere maggiori: Trattato teologico - politico, De intellectus emendatione, Ethica, ordine geometrico demonstrata, oltre a quelle che citeremo nello schema.
Il "Breve Trattato"
Contiene le medesime dottrine che si ritroveranno nell'etica. In particolare, in un dialogo vengono posti questi problemi.
![]()
Remota, per le cose particolari.
![]() La risposta è comune ai
tre punti: Dio è causa
La risposta è comune ai
tre punti: Dio è causa
"Principi della filosofia di Cartesio" e "Cogitata Mataphysica"
![]()
![]()
![]() Spinoza fu pregato di dare lezioni a un giovane. Non volendo
manifestare le opinioni personali, gli spiegò la seconda parte dei principi di
Cartesio. Quando espose anche la prima parte, gli amici fecero pubblicare lo
scritto, ovvero tutte le lezioni fatte al giovane.
Spinoza fu pregato di dare lezioni a un giovane. Non volendo
manifestare le opinioni personali, gli spiegò la seconda parte dei principi di
Cartesio. Quando espose anche la prima parte, gli amici fecero pubblicare lo
scritto, ovvero tutte le lezioni fatte al giovane.
La metafisica di questi scritti è quella
dei Cogitata Metephysica, molto più vicina alla scolastica contemporanea
che a Cartesio:
Trattando invece la cosmologia, Spinoza
scelse Cartesio e non i neoscolastici. Spinoza riteneva dunque la
scolastica inutilizzabile solo in filosofia della natura, mentre la
metafisica andava bene.
![]()
![]()
Metafisica in generale; l'ente e le sue proprietà. Riduzione
dell'ens rationis a puro nome. Negazione
del possibile e contingente Tutto
ciò che è, è necessario.![]()
![]() I Cogitata Metaphysica
si dividono in due parti
I Cogitata Metaphysica
si dividono in due parti
Tutto ciò che è, lo è in quanto causato da Dio. Considerare una cosa senza rapporto con la sua causa è considerarla come non è, non come è.
Questione dei trascendentali: uno, vero e buono non sono affezioni dell'ente. È una tesi che si comprende bene, se si tiene conto che non si danno enti distinti né determinazioni: omnis determinatio est negatio.
"De intellectus emendatione"
È il discorso sul metodo di Spinoza. Somiglianze esteriori con l'opera di Cartesio:
Modo autobiografico.
Regole di una morale provvisoria.
Metodo per arrivare alla verità.
Quale senso allora alla ricerca del sommo
bene, se ognuno persegue solo il suo bene? Fino a quando non si sia
arrivati a vedere ogni cosa come necessaria, ci si figura un ideale di
umanità superiore, alla quale si cerca di partecipare con gli altri.
![]()
![]()
![]() Ma la verità cercata da Spinoza è una verità che dia senso alla vita:
questa ricerca non è conciliabile con quella dei beni terreni, perché essi
portano a tristezza e pentimento. Il bene assoluto non è però bene oggettivo: bene
e male sono relativi.
Ma la verità cercata da Spinoza è una verità che dia senso alla vita:
questa ricerca non è conciliabile con quella dei beni terreni, perché essi
portano a tristezza e pentimento. Il bene assoluto non è però bene oggettivo: bene
e male sono relativi.
Per quanto riguarda i comportamenti, vengono elencate tre regole:
Nella essenza
della cosa. (bisogna procedere
soprattutto con questo tipo di conoscenza) Indiretta Mediata Per esperienza
vaga
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Si tratta poi di emendare l'intelletto, ovvero renderlo capace di
conoscere la realtà in modo da farci arrivare al sommo bene. A questo punto
spinoza distingue quattro tipi di conoscenza.
Si tratta poi di emendare l'intelletto, ovvero renderlo capace di
conoscere la realtà in modo da farci arrivare al sommo bene. A questo punto
spinoza distingue quattro tipi di conoscenza.
Interessante nella gnoseologia spinoziana è il rifiuto del dualismo tipico di tutta la filosofia di quel periodo. La conoscenza è originariamente apprensione di realtà , non di idee. Spinoza distingue dunque l'idea nei suoi aspetti:
Psichico: l'idea è una modificazione della mens in virtù della quale lo spirito ha presente l'oggetto.
Intenzionale: è la stessa presenza della cosa (essenza oggettiva).
La metodologia non deve precedere la conoscenza della realtà: come potrei conoscere il valore della metodologia stessa? Bisogna allora usare gli strumenti naturali di conoscenza: sono le vere idee. Prima si fa una scienza, poi una metodologia.
Emendare l'intelletto tramite il metodo è necessario per combattere i pregiudizi e dare ordine alla ricerca. I pregiudizi si superano iniziando la riflessione dalla prima idea vera: l'Ente Perfettissimo.
Dio Forza delle
passioni (schiavitù umana) Spirito umano
(mens) Passioni


![]()
![]()
![]()
L' "Etica": l'ordine geometrico
Forza
dell'intelletto (libertà umana)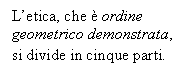
Cartesio aveva distinto ordine geometrico da modo geometrico di dimostrare, ovvero il non dare per dimostrato ciò che non è tale dal metodo sintetico, che deduce la verità da dimostrare dalle definizioni. Cartesio preferì il metodo analitico, Spinoza quello sintetico, perché quello analitico può risultare incomprensibile a molti.
Le definizioni
L'etica si apre con la definizione di causa sui, seguita da altre. Che carattere hanno le definizioni dell'Etica? Spinoza distingue due tipi di definizioni:
Quella che spiega la cosa quale essa è fuori dell'intelletto, e allora deve essere vera.
Quella che spiega la cosa quale è o può essere da noi concepita.
Non dice però a quale categoria appartengano le sue.
Il concetto di attributo
Sono reali o sono soltanto nostri modi di vedere le sostanze? Il concetto Spinoziano di attributo come costitutivo dell'essenza della sostanza dipende da quello cartesiano. Ma come mai per Cartesio ogni sostanza ha un solo attributo, mentre per Spinoza ne ha infiniti? Per spinoza esiste una sola sostanza, e la sua concezione degli universali è nominalistica.
Ma manifestazione verso chi? L'intelletto
umano? Dire che sono manifestazioni all'intelletto non significa dire che
siano soggettivi; inoltre la sostanza è per sua natura manifesta. La sostanza, in sintesi, inesauribile
ricchezza di perfezione, si attua in infiniti attributi (infinite forme),
ognuno dei quali la esprime totalmente. La somma realtà è somma perfezione e
infinita ricchezza: gli attributi sono manifestazioni di questa infinita
ricchezza.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Bisogna partire dal concetto di realtà come perfezione.
Bisogna partire dal concetto di realtà come perfezione.
Unicità della sostanza
L'inizio dell'etica contiene le seguenti proposizioni:
La sostanza è per natura anteriore alle sue affezioni.
Se c'è essere, c'è sostanza.
Due sostanze con attributi diversi non hanno nulla in comune.
Sostanze radicalmente diverse non possono essere causa una dell'altra.
Alternativa dell'unicità della sostanza![]()
 Ma come potrebbero
distinguersi due sostanze se non per la differenza di attributi? La differenza
di modi non basta, perchè, pur con modi diversi, una sostanza rimane uguale a
sé stessa. Due sostanze che hanno il medesimo attributo sono identiche:
Ma come potrebbero
distinguersi due sostanze se non per la differenza di attributi? La differenza
di modi non basta, perchè, pur con modi diversi, una sostanza rimane uguale a
sé stessa. Due sostanze che hanno il medesimo attributo sono identiche:
Alternativa dell'etereogenità
radicale degli esistenti.
![]() Ma se esistessero tante
sostanze eterogenee tra loro, ognuna dovrebbe essere incausata, e quindi
sarebbe necessaria. Ciò che è necessario è infinito: come concepire una
pluralità di infiniti?
Ma se esistessero tante
sostanze eterogenee tra loro, ognuna dovrebbe essere incausata, e quindi
sarebbe necessaria. Ciò che è necessario è infinito: come concepire una
pluralità di infiniti?
Esiste una sola sostanza, e questa è Dio. Cartesio, per timore di giungere a questa conclusione, aveva definito sostanza anche ciò ce aveva bisogno solo del concorso divino per esistere, ma fu una scappatoia.
Dio
Tutta la realtà è dio le dimostrazioni diventano quasi superflue. In ogni caso ne dà tre:
Poiché Dio è l'unica sostanza, tutto ciò che esiste dovrà essere modo o attributo di Dio. In particolare l'estensione è attributo divino. La preoccupazione di Spinoza è di mostrare come ciò non conduca ad ammettere in Dio imperfezione. Infatti l'estensione implica imperfezione solo in quanto implica divisibilità, ma la sostanza è indivisibile.
Negazione della finalità
Dio è causa immanente, e ogni cosa deriva da lui necessariamente. Da questa concezione derivano due conclusioni:
Riguardo al primo punto, Spinoza afferma che non esistono cose contingenti, ma ogni cosa è determinata ad esistere ed operare in un certo modo dalla necessità della natura divina.
La negazione della finalità è svolta nell'appendice all'Etica. Tutto ciò che accade è predeterminato da Dio, non per la sua volontà ma per la sua assoluta natura. A questa visione, dice Spinoza, si contrappongono i "pregiudizi finalistici" (natura creata per l'uomo e l'uomo per adorare Dio), nati dal fatto che gli uomini:
Ignorano le cause dei fenomeni che li circondano si credono liberi.
Tendono a cercare ciò che è loro utile credono che Dio li abbia forniti di ciò che serve loro.
Pensiero ed estensione
Nel De intellectus emendatione si diceva che la conoscenza dell'effetto dovrebbe essere dedotta dalla conoscenza della causa; spesso però Spinoza fa ricorso all'esperienza.
Ad esempio un uomo, considerato astrattamente, non implica l'esistenza; ne vedo la necessità solo se lo considero come complesso di modi dell'infinita sostanza. Oppure si dice che fra le attività spirituali, l'idea è il modo fondamentale, perché condiziona tutti gli altri e può stare senza gli altri.
Spinoza vuole però discostarsi dalla
scolastica: l'idea divina non è il modello della volontà creatrice: la
potenza divina non è altro che l'attuosa essenza divina, e l'idea divina è
l'aspetto pensante di questa essenza.
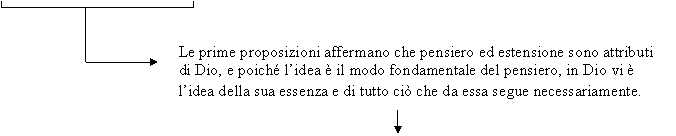
Non la mente di Dio dunque è causa delle cose, ma l'estensione di dio è causa dei corpi e il pensiero divino è causa dei pensieri. Come sostanza pensante e sostanza estesa sono una sola e identica sostanza, appresa sotto due attributi, così un modo dell'estensione e l'idea di esso sono la stessa cosa, espressa in due modi diversi.
L'uomo. Anima e corpo
![]() L'uomo pensa, ma non è sostanza pensante (non è sostanza).
L'uomo pensa, ma non è sostanza pensante (non è sostanza).
![]()
![]() Lo spirito umano è dunque un modo dell' attributo "pensiero."
Lo spirito umano è dunque un modo dell' attributo "pensiero."
L'idea è il modo fondamentale del pensiero.
Dunque lo spirito umano è fondamentalmente idea del corpo.
![]()
Può sembrare la traduzione della forma corporis aristotelica, ma bisogna tenere presente che tra la scolastica e Spinoza c'è stato Cartesio: questa mens non ha più alcuna funzione biologica, perché il corporeo si spiega meccanicamente.
Lo spirito resta comunque, anticartesianamente, riferito al corpo.
La conoscenza
![]()
![]()
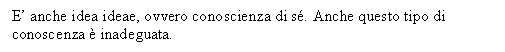
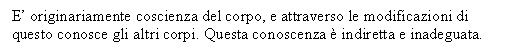

![]()
La conoscenza adeguata si ha quando si concepiscono le cose negli aspetti comuni a tutte. Una tale conoscenza sembra essere la matematica, alla quale si contrappone la conoscenza per universali in senso scolastico. Spinoza distingue poi tre genere di conoscenza:
![]()
![]() Polemica contro dualismo gnoseologico cartesiano:
Polemica contro dualismo gnoseologico cartesiano:
Solo la conoscenza di secondo e terzo genere ci aiuta a distinguere il vero dal falso. Non solo questo tipo di conoscenza è apprensione della realtà, ma è conoscenza adeguata della realtà, e poiché tutto è necessario, è proprio della ragione considerare le cose come necessarie, non come contingenti.
Ogni idea infatti implica l'essenza eterna di Dio, e questa conoscenza di Dio implicita nell'idea di ogni cosa è adeguata e perfetta. Lo spirito umano può avere conoscenza adeguata dell'essenza di Dio. In quest ottica, gli errori altro non sono se non scambi di termini.
![]()
![]()
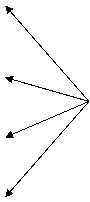
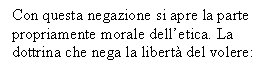
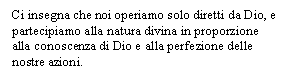
![]()
![]()
![]()
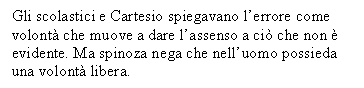

Le passioni
Poi aggiunge che ogni cosa tende a
perseverare nel suo essere, e questa tendenza è l'essenza stessa della
cosa. Una passione è una modificazione del corpo
che ne aumenta o diminuisce la potenza di agire, unita alla coscienza di
tale modificazione. Anche lo spirito umano ha questa tendenza
fondamentale, che si chiama Volontà se riferita allo
spirito Appetitus se riferita a
spirito + corpo. Il desiderio (cupiditas) è l'appetitus
unito alla coscienza di esso.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() All'esercizio della vita secondo ragione si oppongono le passioni. I
filosofi, convinti dal pregiudizio che l'uomo fosse libero, si sono preoccupati
di dare solo giudizi di valore sulle passioni. Siccome sono realtà necessarie
come le altre, non vanno disprezzate, ma studiate.
All'esercizio della vita secondo ragione si oppongono le passioni. I
filosofi, convinti dal pregiudizio che l'uomo fosse libero, si sono preoccupati
di dare solo giudizi di valore sulle passioni. Siccome sono realtà necessarie
come le altre, non vanno disprezzate, ma studiate.
L'impulso è conseguenza dunque della natura del soggetto, non della bontà dell'oggetto; buono è ciò che soddisfa l'impulso, non ciò che tende al bene. Lo spirito è idea del corpo: tendendo a perseverare e potenziare il suo essere, tende anche a conservare il corpo. Le passioni nascono dalla coscienza di questo potenziamento - depotenziamento:
Le virtù
La distinzione tradizionale di virtù e passioni, basata sul libero esercizio dell'attività, cade assieme alla libertà. La distinzione ricompare sotto forma di attività razionale o non razionale. La quarta parte dell'Etica potrebbe intitolarsi: sull'uso razionale delle passioni. Le passioni sono dati di fatto; esse non devono distogliere però l'uomo dalla attività razionale, la sua vera attività.
Si può fare un buon uso delle passioni, quello prescritto dalla ragione:
![]()
![]()
![]() La ragione esige che ognuno ami sé stesso e cerchi il proprio utile
(conservazione e potenziamento dell'essere.
La ragione esige che ognuno ami sé stesso e cerchi il proprio utile
(conservazione e potenziamento dell'essere.
Questo è il fondamento della virtù, che porta immediatamente alla felicità.
La felicità è compimento della virtù, e non qualcosa di estraneo, un premio che ci viene da fuori. Si tratta allora di vedere cosa sia il nostro vero utile. Dal momento che siamo spirito, il nostro utile è ciò che ci porta a conoscere; il bene sommo è la conoscenza di Dio.
Ci giova ciò che ha natura simile alla nostra: niente è più simile all'uomo dell'uomo stesso, non però in quanto soggetto a passioni, ma in quanto guidato dalla ragione.
Spinoza espone poi la sua etica speciale, in cui esprime la recta vivendi ratio.
Il rapporto tra bene e piacere è positivo, il dolore è un male. L'odio, che deriva dal dolore, è un male: chi vive secondo ragione cerca di ricambiarlo con l'amore e la generosità. Non giova la compassione: il prossimo va aiutato perché lo prescrive la ragione, non perché giova condividere il dolore. Poiché tutto è necessario, non c'è male in natura, e la conoscenza del male è solo coscienza del dolore.
La quinta parte dell'etica si riferisce alla libertà umana: non si parla di libero arbitrio, bensì di liberazione dalle passioni attraverso la ragione.
La ragione non può sopprimere le passioni,
ma può esercitare su di esse un dominio conoscendole e oggettivandole: una
passione smette di essere tale quando ne ho idea chiara e distinta. Allora
la passione non suscita più odio né amore verso la causa, perché ci si
rende conto che quella causa era determinata da infinite altre realtà.

Lo spirito può considerare ogni passione
come momento necessario di quell'eterno ordine delle cose che è Dio. In tal
modo la mente ha un'idea chiara e distinta, che porta gioia. E poiché la
gioia unita alla causa di essa e l'amore,la coscienza chiara e distinta
delle passioni diventa amore di Dio.![]()
![]()
Lo spirito però non si esaurisce nella vita assieme al corpo, poiché in Dio c'è l'idea che esprime l'essenza di ogni corpo umano "sub specie aeternitatis": lo spirito non rimane distrutto assieme al corpo. La vita dello spirito è conoscenza, e in ciò esso trova la suprema gioia. Questa, unita alla coscienza della sua causa, Dio, porta all'amore per lui. In questo consiste la beatitudine, che non è premio alla virtù, ma la virtù stessa.
Trattato teologico - politico
Tema centrale: la libertà di pensiero e la libertà religiosa sono condizione della pace sociale.
Sviluppo del concetto di religione.
Teoria dello stato.
La religione, così come è professata dai più, è uno stato d'animo passionale, una superstizione. L'unica prova del valore di una religione sarebbe una condotta conforme ai dogmi professati; i cristiani però non praticano le virtù esaltate dal cristianesimo. Una religione così strutturata (solo atti di culto) è soggetta ai mutamenti delle passioni, ed è utile solo ai tiranni, per tenere sottomessi i sudditi con la paura.
![]()
![]() La libertà religiosa non
nuoce, ma giova alla stabilità dello stato.
La libertà religiosa non
nuoce, ma giova alla stabilità dello stato.
Spinoza spiega cosa sia una religione
descrivendo quella biblica.

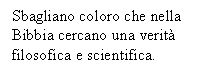
I motivi della certezza che i profeti avevano di ciò che trasmettevano non erano l'evidenza razionale, ma i seguenti tre:
Visto cosa sia la rivelazione, ci si chiede se essa sia data solo agli ebrei o a tutti i popoli. Spinoza distingue tre tipi di beni ai quali può orientarsi la nostra volontà:
I mezzi per ottenere le prime due sono dati a tutti gli uomini, mentre per il terzo contano le circostanze esterne. Ogni popolo dunque ha ricevuto una rivelazione per quanto riguarda i precetti morali, ogni popolo ha avuto i suoi profeti. Da quel che si è detto consegue che:
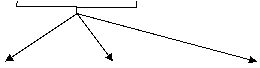
La legge divina è comune a tutti gli
uomini Questa legge non esige conoscenze di tipo
storico, e non esige atti esteriori di culto. Non comanda di agire per un premio, ma ha
i premio in sé stessa.
Basta dunque la ragione, lumen naturale, a farci conoscere la legge divina. Le leggi, che nella bibbia prescrivono atti di culto che la ragione giudicherebbe indifferenti, sono rivolte al popolo ebraico e sono in realtà leggi positive di quel popolo. Gesù Cristo non abrogò la legge mosaica, perché la sua si poneva su di un altro piano: morale e non giuridico.
Il razionalismo religioso è applicato poi anche ad alcuni problemi particolari.
Ciò che gli uomini chiamano miracolo è solo ciò di cui ignorano le cause.
Il metodo interpretativo della bibbia non deve differire da quello di interpretare la natura. Non bisogna
presupporre che essa si debba accordare con la ragione. L'intento della bibbia è quello di inculcare
precetti morali.
Se gli uomini seguissero la ragione, ricaverebbero da questa la conoscenza dei loro doveri, ma poiché seguono l'immaginazione, si rese necessaria la religione positiva per insegnare la moralità. Per vivere in pace e sicurezza gli uomini dovettero rinunciare al loro diritto di natura, e trasferirlo ad uno che avesse la forza di costringerli ad obbedire. Questo può essere una persona o tutta la società. All'autorità è dovuta obbedienza, che non è schiavitù (i comandi giovano all'utilità di tutti).
L'atteggiamento di Spinoza si può storicamente comprendere: ha vissuto in un epoca in cui le minacce aal libertà potevano venire solo dalle chiese, e le garanzie di libertà solo dallo Stato.
Wolfgang G. Leibniz (1646 - 1716)
Disputa antichi - moderni: filosofia e scienza
In una lettera al maestro Thomasius dice di aver trovato più verità nella Fisica di Aristotele che nelle meditazioni di Cartesio. Il distacco dalla fisica si era storicamente compiuto in tre punti:
La fisica, se vuole essere conoscitiva, non può adoperare la nozione di forma sostanziale, perché noi non possiamo conoscere le essenze delle cose.
In natura esistono solo estensione e movimento, le qualità sono soggettive.
Ne consegue il dualismo res extensa - res cogitans.
Ma Leibniz crede che il 2 e 3 non seguano necessariamente dal 1.
Nelle stesse nozioni scientifiche sono impliciti concetti che trascendono estensione e moto:
![]()
L'estensione (molteplicità) suppone unità
Il principio di unità e attività è la forma sostanziale.
Il moto suppone azione
Questo concetto non deve però essere usato per spiegare i fenomeni. Nonostante questo difetto, non dobbiamo respingere una cosa la cui conoscenza è necessaria in metafisica a tal punto che senza di lei non si possono conoscere nemmeno i primi principi. Volendo spiegare i fenomeni, bisogna usare grandezza, movimento e figura, ma ciò non porta ad una metafisica cartesiana, bensì aristotelica.
Sostanza come monade
![]()
![]() Estensione e moto locale non esauriscono la realtà: anche nei corpi vi
è qualcosa di analogo allo spirito. È la entelechia, o monade.
Estensione e moto locale non esauriscono la realtà: anche nei corpi vi
è qualcosa di analogo allo spirito. È la entelechia, o monade.
I corpi sono aggregati di monadi Gli spiriti sono sostanze semplici. Ogni
monade, dalle infime a Dio, è una e intelligibile.
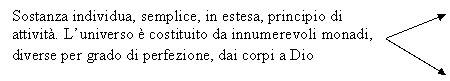
Origine del concetto di monade: logica
![]() Russell e Couturat monade come ipostatizzazione del
soggetto logico.
Russell e Couturat monade come ipostatizzazione del
soggetto logico.
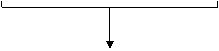
La sostanza individuale, che esiste ed
agisce, è definita come soggetto cui si attribuiscono vari predicati, e che non è predicato di alcun oggetto.
![]()
![]() Ogni predicazione vera ha un fondamento nella natura delle cose: chi
intendesse perfettamente la nozione del soggetto sarebbe anche in grado di
giudicare che il predicato gli appartiene. La natura di una sostanza
individuale, o ente completo, è di avere
una nozione così perfetta che basti a dedurre tutti i predicati del soggetto a
cui essa si attribuisce.
Ogni predicazione vera ha un fondamento nella natura delle cose: chi
intendesse perfettamente la nozione del soggetto sarebbe anche in grado di
giudicare che il predicato gli appartiene. La natura di una sostanza
individuale, o ente completo, è di avere
una nozione così perfetta che basti a dedurre tutti i predicati del soggetto a
cui essa si attribuisce.
Il principio di identità è la prima verità e la prima regola di verità. Le proposizioni vere sono sempre proposizioni identiche: sempre dunque il predicato (conseguente) inerisce al soggetto (antecedente): ecco perché la sostanza monade è soggetto logico ipostatizzato.
Da questa prima affermazione Leibniz deduce tutto il suo sistema.
Nessun effetto è senza causa.
Non si danno due cose singolari differenti solo per numero.
Non vi sono denominazioni solo estrinseche, che non abbiano fondamento nella cosa stessa.
Le sostanze singole sono in relazione con tutto l'universo, e ne esprime la causa: Dio.
Origine del concetto di monade: metafisica
La monade è unità che sta al fondamento del molteplice-composto: devono esistere sostanze semplici, perché esistano i composti.
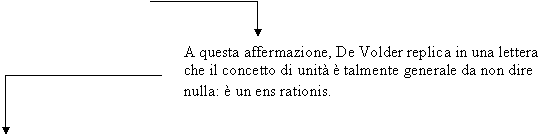
Leibniz replica che non si tratta di una
nozione logica, ma di una nozione metafisica, perché non si riferisce ad un
modo di essere pensato, ma alla realtà.
Con De Volder Leibniz insiste soprattutto sul concetto di sostanza come unità che sta alla base.
A Sturm, invece, che riteneva che nei corpi non esistesse un principio immanente di attività, ma il moto fosse stato comunicato inizialmente da Dio, Leibniz chiede se questo fatto alteri o meno la natura dei corpi.
Propendendo per la non - alterazione dei corpi (ipotesi di Malebranche), abbiamo una aporia: allora come si muovono i corpi, adesso che quella spinta è finita, se dentro di loro non c'è principio di attività? Allora è richiesto un effetto sussistente che ancora adesso duri e operi.
Una specie di effetto sussistente come
questo è chiamato da Leibniz "monade". Una cosa non può essere senza
attività: se Dio fa tutto nelle cose, allora Dio è tutto nelle cose, che
diventano modi dell'apparire dell'unica sostanza (come Spinoza).
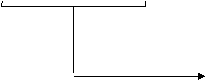
![]()
![]() Se non si può negare
l'attività nelle cose, bisogna ammettere in esse un principio di attività, una
monade. Questa argomentazione, che risale alla monade come unità a fondamento
di estensione e di attività, può essere chiamata giustificazione metafisica.
Se non si può negare
l'attività nelle cose, bisogna ammettere in esse un principio di attività, una
monade. Questa argomentazione, che risale alla monade come unità a fondamento
di estensione e di attività, può essere chiamata giustificazione metafisica.
Per Leibniz, questa giustificazione non era radicalmente diversa da quella logica: pensava che a fondamento della logica e della metafisica stessero gli stessi principi, ovvero di identità \ non contraddizione e ragion sufficiente.
Esiste anche una giustificazione fisica: è tratta dalla tesi secondo cui ciò che si conserva nel mondo non è la quantità di moto (mv, come diceva Cartesio), bensì la forza viva (mv2).
I corpi
La materia prima è l'aspetto di limitazione, di passività di ogni monade finita, la materia seconda è l'insieme di monadi subordinato ad una monade superiore dominante. Esistono dunque sostanze inestese variamente ordinate: la massa (estensione + impenetrabilità) è il modo di apparire a noi di un aggregato di sostanze.
![]() Non c'è differenza per leibniz tra qualità secondarie ed estensione.
Non c'è differenza per leibniz tra qualità secondarie ed estensione.
Sono modo di apparire di sostanze che non sono in sé stesse.
![]() L'esteso è modo di apparire alla sensibilità umana di un aggregato di
monadi.
L'esteso è modo di apparire alla sensibilità umana di un aggregato di
monadi.
Spazio e tempo
Obiezione: senza
uno spazio assoluto non si può determinare quale dei due corpi
effettivamente si muova
La nozione di uno spazio unico e infinito è un
idolo: lo spazio è relazione, è l'ordine delle coesistenze, così come il tempo
è l'ordine delle successioni. Lo spazio segna l'ordine e il rapporto di quelle
cose che esistono nello stesso tempo.
![]()
![]() Il moto è variazione di
distanze
Il moto è variazione di
distanze
L'unico modo è
considerare se il rapporto dei due corpi in movimento relativo con gli
altri corpi è cambiato o meno.
Vinculum substantie
Il problema si acutizza a contatto con il
dogma cattolico della transustanziazione. Da luterano, leibniz concilia
comunque la sua teoria delle sostanze con questo dogma: il vincolo tra le
monadi è indistruttibile solo naturalmente.
![]()
![]() Ogni sostanza composta è un insieme di monadi unificato da una monade
dominante (l'anima spirituale nell'uomo): come va inteso questo vincolo fra
monadi? Permette la sostanzialità del composto o solo delle sue parti?
Ogni sostanza composta è un insieme di monadi unificato da una monade
dominante (l'anima spirituale nell'uomo): come va inteso questo vincolo fra
monadi? Permette la sostanzialità del composto o solo delle sue parti?
Caratteri della monade
Ogni monade è ingenerabile e indistruttibile, e dotata di percezione. Percezione non significa però coscienza, quanto "principio di unità del molteplice". Allora percezione non indica niente di più che monade (monade si riferisce alla sostanza, percezione alla qualità caratteristica della monade).
La percezione è paragonata alla percezione
inconsapevole degli uomini.

La percezione consapevole è appercezione,
è non è di tutte le monadi, ma solo delle anime.
Distinzioni chiarificatrice
L'armonia prestabilita
Esiste una gerarchia tra le monadi. Ce ne sono capaci di percezione o appercezione, e tra queste quelle solo sensibili o anche intelligenti. Le monadi non possono essere in contatto tra loro, in quanto inestese, eppure tra gli enti del mondo vige una armonia prestabilita.
Significato ampio: teoria metafisica generale.
Significato ristretto: spiega i rapporti anima-corpo nell'uomo (è l'aspetto più noto).
Il problema di questi rapporti era reso spigoloso dal dualismo cartesiano. Leibniz trova tre possibili soluzioni al problema.
Teoria dell'influsso reciproco, attribuita agli scolastici.
Teoria delle cause occasionali, sostenuta da Malebranche.
Anziché far intervenire Dio in ogni
momento, è più ragionevole dire che egli abbia creato le monadi in modo che
armonizzino tra loro, ad esempio nel moto di volizione a cui corrisponde un
moto del corpo.![]()
![]()
Teoria dell'armonia prestabilita, la sua.
La tesi generale dell'armonia prestabilita nasce dalla concezione della sostanza come realtà che contiene in sé la ragione di tutti i suoi attributi. Gli eventi non accadono alla sostanza, ma conseguono da lei.
Teoria della conoscenza
A Cartesio obietta:
Il criterio dell'evidenza è troppo semplicistico: non basta definire vero tutto ciò che vedo chiaramente e distintamente: bisogna anche spiegare cosa questo significhi.
Il dubbio metodologico è una cerimonia inutile: il cogito è la prima verità immediatamente evidente, così come la non-contraddizione è la prima verità di ragione.
Una conoscenza è oscura è quella che
non basta a far riconoscere la cosa
rappresentata.
![]()
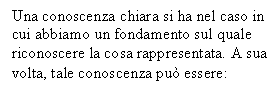
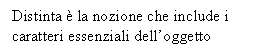
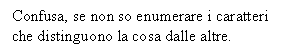

![]()
Se tutti i caratteri di una nozione distinta sono a loro volta distinti, si ha una conoscenza adeguata. La conoscenza umana non è quasi mai adeguata; non sempre possiamo intuire la realtà dell'oggetto pensato: in questo caso ci serviamo di segni, ed abbiamo una conoscenza simbolica.
Idea vera è l'idea di una realtà possibile, idea falsa è quella che unisce elementi contraddittori. Leibniz ammonisce a non appellarsi troppo facilmente alle idee, senza provarle sull'esperienza.
Contro Locke
Ma ciò non vuol dire che ogni conoscenza derivi dall'esperienza. Leibniz discute le teorie di Locke nei Nuovi saggi sull'intelletto umano, pubblicati postumi.
![]() Negazione dell'Innatismo:
Negazione dell'Innatismo:
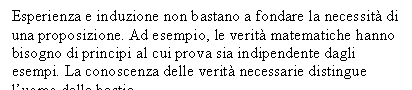
Tutti i pensieri e le azioni della nostra anima vengono dal suo intimo, senza che possano esserle date dai sensi, sebbene i sensi ce ne diano l'occasione di accorgercene.
|
LOCKE |
LEIBNIZ |
|
Oggetto immediato della coscienza è l'idea |
L'idea è l'oggetto interno, che è espressione della natura della cose. Solo Dio è oggetto esterno immediato |
L'anima è un microcosmo, nel quale le idee distinte sono una rappresentazione di Dio, le idee confuse sono una rappresentazione dell'universo.
Nozioni universali e conoscenze delle essenze specifiche
Noi non cogliamo qualità staccate appoggiate su un qualche substrato ignoto, ma cogliamo un concretum, una realtà che ci si presenta sotto vari aspetti. La difficoltà di Locke dipende, secondo Leibniz, dal confondere immagine con idea.
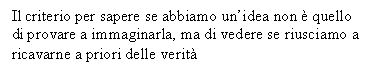
![]()
![]()
![]()
![]()
Il problema della sostanza è collegato con quello dell'essenza specifica. Per Locke avere un'idea della sostanza equivale a conoscere l'essenza specifica della cosa, che rende tale quella cosa. Ma per Leibniz tali nozioni universali non sono somma di idee specifiche, bensì sono un modo originario di esprimere le cose.
L'astrazione non va intesa come separazione di un carattere dagli altri, ma come modo originario di apprendere l'individuo. Non possiamo cogliere l'individualità, perché essa implica infinito. Le proposizioni universali sulle cose di natura non ci fanno conoscere le essenze specifiche, ma ci aiutano ad orientarci nella vita quotidiana (sono provvisorie e solo proabili).

![]() Le verità
necessarie. Gli assiomi
Le verità
necessarie. Gli assiomi
![]()
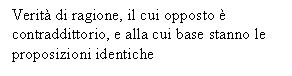 Forte opposizione a Locke.
Leibniz distingue
Forte opposizione a Locke.
Leibniz distingue
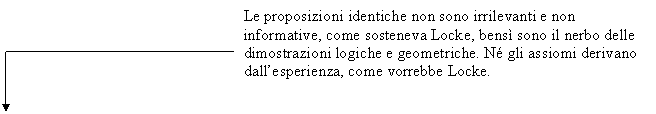
Egli affermava che è molto più evidente la proposizione particolare dell'assioma, ma Leibniz lo contraddice: solo i principi universali infatti danno ragione delle affermazioni particolari.
Leibniz non condivide nemmeno il disprezzo di Cartesio per la logica: per lui l'invenzione del sillogismo è una delle più considerevoli dello spirito umano. La sillogistica aristotelica è il primo tentativo di stabilire leggi infallibili dell'argomentazione, di scrivere matematicamente anche fuori dalla matematica.
Non contraddizione e ragione sufficiente
I primi principi della conoscenza sono anche le leggi fondamentali della realtà. Tali principi sono:
![]() Principio di non contraddizione,
per il quale giudichiamo falso ciò che implica contraddizione.
Principio di non contraddizione,
per il quale giudichiamo falso ciò che implica contraddizione.
![]() Principio di ragion sufficiente,
secondo cui niente potrebbe essere tale (esistente, vero...) se non avesse una
causa sufficiente.
Principio di ragion sufficiente,
secondo cui niente potrebbe essere tale (esistente, vero...) se non avesse una
causa sufficiente.
In effetti entrambi i principi sono una esplicitazione del principio di identità: il pnc è la sua formulazione negativa, il prs è una sua esplicitazione nella nozione di sostanza individuale.
Verità di ragione e verità di fatto
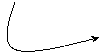 Verità di ragione e di fatto: data
Verità di ragione e di fatto: data
|
ARNAULD |
LEIBNIZ |
|
Ammesso che Dio abbia voluto creare Adamo, non ha potuto non crearlo con tutto quello che ha fatto. |
Ma si tratta solo di una necessità ipotetica. |
|
Nega alle verità di fatto anche la necessità ipotetica. |
La nozione di Adamo va considerate come essa è in Dio. |
|
Non ci dobbiamo domandare come è la nozione di Adamo in Dio, ma come è in sé stessa |
Il ricorso alla nozione di Adamo come è nella mente divina è dovuto al fatto che solo Dio ha la nozione dell'individuo nella sua individualità |
Differenza tra verità necessarie e verità di fatto è dunque che il soggetto logico delle verità di fatto è un individuo, che è inesauribile per l'intelletto umano: per scoprire l'inerenza del predicato nel soggetto bisognerebbe procedere all'infinito nell'analisi del soggetto.
Se la contingenza delle verità di fatto dipendesse però solo da un difetto di conoscenza, questa posizione sarebbe uguale a quella di Spinoza. Ma Leibniz introduce un altro aspetto: l'esistenza del soggetto di tali verità di fatto, che derivano necessariamente proprio dal quel soggetto, dipende da un libero decreto divino.
Esistenza di Dio
Attraverso principio di ragion sufficiente. Contingente è ciò che potrebbe anche non essere, e non ha quindi in sé la ragione sufficiente del suo essere, né può averla in altri contingenti, perché sono nella stessa situazione. Perciò la ragione ultima è una sostanza necessaria, che noi chiamiamo Dio.
Nella "dissertatio da arte combinatoria" si trova una dimostrazione simile, ma riferita al moto.
Nella teodicea parla del limite come segno di contingenza. Bisogna cercare la ragione dell'esistenza del mondo (insieme delle cose contingenti) nella sostanza che ha in sé la ragione della sua esistenza.
Nella Monadologia si trova un argomento che risale a Dio come ragion d'essere delle essenze sulle quali si fondano le verità necessarie. L'intelletto divino è la regione delle verità interne, o delle cause dalle quali dipendono: senza di esso non esisterebbe nulla di reale né di possibile.
Argomento a priori fondato sull'idea di Dio, preso da Anselmo e Cartesio, che avevano però taciuto la premessa più importante: Dio è possibile. Come l'idea di Dio implica la sua esistenza ? Se Dio è possibile, allora esiste. Ma Dio è possibile, dunque esiste. Nulla infatti può essere di ostacolo alla possibilità di ciò che non ha alcun limite.
I possibili e la libertà divina
Cartesio aveva detto che le verità eterne dipendono da un libero decreto divino. Se così fosse, la libertà divina sarebbe un potere assoluto e irrazionale (l'estremo volontarismo è assoluto necessitarismo).
Per Leibniz le essenze delle cose non dipendono dall'arbitrio divino, ma dall'essenza divina. "Le cose sono create" significa che ciò che è possibile (in quanto idea di Dio) è attuato dalla volontà di Dio. Solo Dio è l'essere che, se è possibile, allora esiste; le cose contingenti sono fatte essere, create della libera Volontà divina.
![]()
![]()
![]()
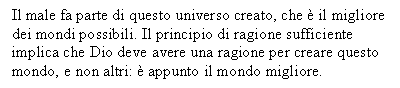
Questo vuol dire che Dio è necessitato a creare il migliore mondo possibile, e che di conseguenza tutto è necessario? No: bisogna distinguere necessità metafisica, il cui opposto è contraddittorio, da necessità morale. La necessità secondo cui crea Dio è morale .
Quando Dio ha decretato di creare qualcosa, c'è stata una lotta fra tutti i possibili che pretendenti l'esistenza. È una lotta ideale; tuttavia Dio è moralmente necessitato a creare in modo che non possa attuarsi nulla di meglio.
![]() Dio non è necessitato a creare,
altrimenti tutti i possibili si attuerebbero.
Dio non è necessitato a creare,
altrimenti tutti i possibili si attuerebbero.
![]() I possibili non si attuano tutti
perché non tutti sono compossibili.
I possibili non si attuano tutti
perché non tutti sono compossibili.
Questa impossibilità non dipende dalla volontà divina: non è morale, bensì metafisica.
La libertà umana
Giuda tradì il maestro perché poteva peccare, e lo volle. Il potere lo ebbe da Dio, il volere dal fatto che lo stimò come un bene. Ma come ha potuto stimare un bene ciò che non lo era? Ogni opinione ha due cause:
Il temperamento di chi opina.
Lo stato della persona, che dipende dalle circostanze.
![]()
![]()

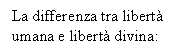
![]()
La differenza sta solo nella conoscenza, infallibile quella divina e fallibile quella umana, non nel poter optare, che manca nell'uno e nell'altro. La libertà implica tre condizioni:
Intelligenza: conoscenza di ciò che si vuole fare.
Spontaneità: un atto deve procedere unicamente dalla volontà dell'agente.
Contingenza: non indifferenza, ma solo esclusione di necessità metafisica. Un atto libero potrebbe anche non essere compiuto.
Non si parla qui di necessità morale: la conoscenza chiara di ciò che è meglio determina la volontà ma non la necessita (metafisicamente).
Morale e diritto naturale
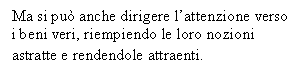
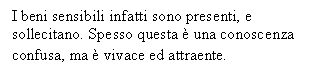
![]()
![]()
![]()
![]()
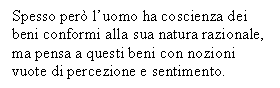
![]()
![]() Nei nuovi saggi sull'intelletto umano sembra dare più spazio alla
libertà: "la scelta è sempre determinata dalla percezione". L'uomo vuole il
bene così come la conoscenza glielo presenta.
Nei nuovi saggi sull'intelletto umano sembra dare più spazio alla
libertà: "la scelta è sempre determinata dalla percezione". L'uomo vuole il
bene così come la conoscenza glielo presenta.
Leibniz parla di piaceri luminosi e ragionevoli: il piacere è sempre un bene, in quanto coscienza di una perfezione. Certe perfezioni portano però con sé imperfezioni maggiori.
Le norma morali, quasi caratteri impressi da Dio nel nostro spirito, possono essere lette dalla ragione in noi stessi. Per la loro importanza, Dio ha fatto in modo che le più fondamentali di queste norme fossero raggiungibili anche senza un esplicito ragionamento: diritto naturale e socialità interpersonale.
![]()
![]()
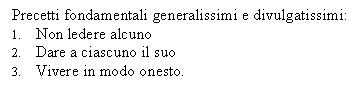
![]()
![]()
Dio è fondamento dell'essenza delle cose, e il diritto naturale esprime i rapporti fondamentali tra uomini considerati nella loro essenza, in quanto uomini: è l'eterno diritto naturale razionale. Poiché il diritto naturale, fondato sulla natura delle cose, esprime le esigenze della giustizia, che quindi è indipendente dalla volontà di Dio e da quella dl principe. Questo punto è una polemica diretta contro Hobbes.
Immanuel Kant (1724 - 1804)
La filosofia teoretica
La preparazione della critica. Primi scritti
Contatto con la nuova scienza Galileiano -
Newtoniana, che riusciva a prevedere i fenomeni: essa realizzava l'ideale
scientifico meglio che la metafisica tradizionale. Partenza dalla filosofia di Wolff
![]()
Il sistema kantiano nasce da una lunga
elaborazione di pensieri sorti quasi spontaneamente nello studio dei vari
problemi, e non da un progetto.
Fisica e metafisica negli scritti del 1755 - 56
![]() Monadologia fisica
conciliare le tesi di Leibniz e Newton sul problema della divisibilità
dell'esteso.
Monadologia fisica
conciliare le tesi di Leibniz e Newton sul problema della divisibilità
dell'esteso.
La metafisica è ancora valida, ma va unita
alla geometria per costruire una filosofia della natura solida.
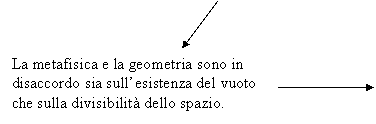
Alla metafisica dedica la dissertazione sui primi principi:
Identità
Ragion determinante (sufficiente).
Nella nova delucidatio aggiungerà anche:
Successione: una sostanza non può mutare se non è connessa ad altre.
Coesistenza: non si darebbero relazioni tra sostanze se non dipendessero tutte da un principio comune, ossia dall'intelletto divino.
Vi è un Dio proprio perché la natura non
può procedere se non regolarmente e con ordine![]()
![]() Prosegue l'intreccio di metafisica e scienze naturali come momenti
necessari per la comprensione della realtà: quando espone una cosmologia
meccanica, si chiede se tale spiegazione escluda Dio. La differenza (con
democrito, ad esempio) sta nel concepire il tutto come risultato di leggi
necessarie, e non del caso.
Prosegue l'intreccio di metafisica e scienze naturali come momenti
necessari per la comprensione della realtà: quando espone una cosmologia
meccanica, si chiede se tale spiegazione escluda Dio. La differenza (con
democrito, ad esempio) sta nel concepire il tutto come risultato di leggi
necessarie, e non del caso.
Critica alla metafisica nel 1762 - 66
![]()
![]() Lettura di Hume risveglio dal sonno dogmatico.
Lettura di Hume risveglio dal sonno dogmatico.
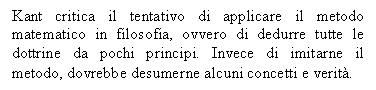
La filosofia non deve mai partire da
definizioni.![]()
![]() Kant lo spiega: la matematica costruisce i suoi oggetti, e quindi può
partire dalle definizioni di essi, può passare agli assiomi e può dedurre
teoremi; la metafisica invece indaga che cosa sia la realtà esistente, e deve
ricavare da essa i propri concetti.
Kant lo spiega: la matematica costruisce i suoi oggetti, e quindi può
partire dalle definizioni di essi, può passare agli assiomi e può dedurre
teoremi; la metafisica invece indaga che cosa sia la realtà esistente, e deve
ricavare da essa i propri concetti.
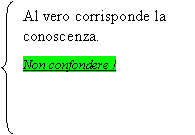
Quanto alla morale, Kant rileva che i suoi fondamenti sono ancora insufficienti
Al bene corrisponde il sentimento.
Molto significativo è lo scritto "L'unico argomento possibile per la dimostrazione di Dio": vi si sostiene che l'uso della ragione, entro i limiti delle cognizioni comuni, offre argomenti sufficientemente persuasivi dell'esistenza di Dio. Poiché si tratta di una dimostrazione dell'esistenza di Dio, Kant chiarisce i concetti:
![]()
![]()
![]() Di esistenza: l'esistenza di una cosa può
essere attestata solo dall'esperienza della cosa stessa, o da testimonianze
indirette.
Di esistenza: l'esistenza di una cosa può
essere attestata solo dall'esperienza della cosa stessa, o da testimonianze
indirette.
"Dio è
esistente": non esprimo una relazione soggetto - predicato, ma dico che ad
un esistente spettano quei predicati il cui insieme definiamo col nome di
Dio.
![]() Di possibilità: la non-contraddittorietà è
necessaria ma non sufficiente; bisogna anche che siano dati gli elementi che
non si contraddicono.
Di possibilità: la non-contraddittorietà è
necessaria ma non sufficiente; bisogna anche che siano dati gli elementi che
non si contraddicono.
La non contraddizione è il formale della possibilità.
I dati compatibili sono il materiale della possibilità.
![]()
Toglie il materiale![]()
![]() Di necessità: necessario è ciò il cui opposto
è impossibile
Di necessità: necessario è ciò il cui opposto
è impossibile
Ciò la cui soppressione elimina ogni possibilità è assolutamente necessario, dunque esiste qualcosa in modo assolutamente necessario. L'unico argomento kantiano arriva a Dio come fondamento della possibilità delle cose: Dio non si rivela nel miracoloso, nello straordinario, ma nelle stesse leggi di natura.
La dissertazione del 1770
Una tesi platonica che rimarrà anche nel Kant critico è la distinzione di sensibilità e intelletto:
Nuova è invece la dottrina sullo spazio e il tempo come forme a priori della conoscenza sensibile, o intuizioni pure (la ritroveremo immodificata nella ragion pura).
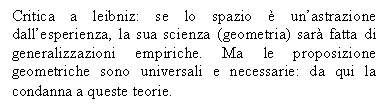
![]()
![]()
![]()
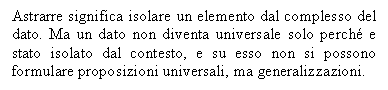 Kant condivide il concetto
empirista di astrazione:
Kant condivide il concetto
empirista di astrazione:
Intuizioni: in quanto condizioni della conoscenza
sensibile (è sinonimo di conoscenza sensibile).
![]()
Pure: in quanto sono a priori, non
ricavate dall'esperienza. Sono modi in cui lo spirito umano coglie
necessariamente gli oggetti sensibili
![]() Spazio e tempo sono allora:
Spazio e tempo sono allora:
Approdo più importante della dissertazione: si può avere scienza universalmente valida anche del mondo fenomenico.
Lettera a Hertz e problema della ragione pura
Il passo avanti della critica della ragion pura è che solo del mondo fenomenico si dà scienza universale: i concetti dell'intelletto non fanno conoscere la cosa in sé, ma danno solo una unità ulteriore rispetto a quella di spazio e tempo alle intuizioni sensibili.
Il nostro
intelletto non è causa dell'oggetto, l'oggetto non è causa delle
rappresentazioni intellettuali. I concetti puri dell'intelletto non debbono
essere astratti dalle impressioni dei sensi, e non devono esprimere la
recettività delle rappresentazioni ottenute mediante i sensi.
Su cosa si fonda il rapporto
![]()
![]() tra rappresentazione ed oggetto?
tra rappresentazione ed oggetto?
I presupposti del problema Kantiano:
![]() Il soggetto può ricevere
dall'oggetto solo mediante sensibilità (intuizione è solo sensibile).
Il soggetto può ricevere
dall'oggetto solo mediante sensibilità (intuizione è solo sensibile).
![]() Con l'intuizione sensibile si
coglie solo il singolare. I concetti astratti non danno scienza rigorosa.
Con l'intuizione sensibile si
coglie solo il singolare. I concetti astratti non danno scienza rigorosa.
![]() Un concetto puro è indipendente
dai dati della sensibilità.
Un concetto puro è indipendente
dai dati della sensibilità.
Dati questi presupposti, come può un concetto puro rappresentare un oggetto? Se avessimo concetto delle cose senza ricevere da esse un influsso, la nostra conoscenza sarebbe intuizione creatrice divina.
I giudizi sintetici a priori
![]() Problema: com'è possibile collegare necessariamente concetti diversi in
un giudizio(proposizione)?
Problema: com'è possibile collegare necessariamente concetti diversi in
un giudizio(proposizione)?
![]()
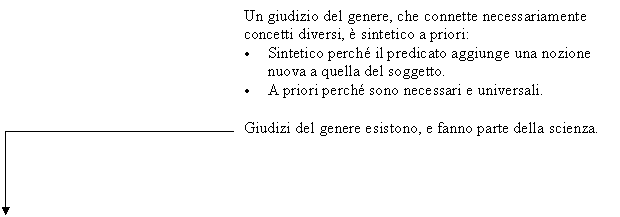
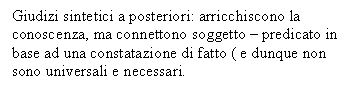
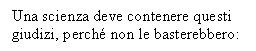
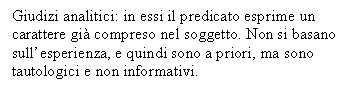

Devono esserci giudizi sintetici a priori. Ma come sono possibili? (è il problema centrale della c. r. pura)
Soluzione del problema: deduzione trascendentale delle categorie
Nella critica della ragion pura i concetti dell'intelletto sono intesi come forme unificatrici dei dati della sensibilità, e non come capaci di esprimere le cose in sé. La soluzione al problema sulla possibilità dei giudizi sintetici a priori è enunciata nel "principio supremo".
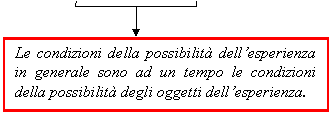
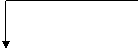
La deduzione trascendentale delle categorie intende cioè dimostrare che senza concetti puri, senza categorie, non ci sono nemmeno oggetti d'esperienza: le categorie entrano, come forme unificatrici dei dati sensibili, nella costituzione dei dati dell'esperienza.
La deduzione trascendentale delle categorie è una delle parti più tormentate della ragion pura. Nella prima edizione, si dice che essa presenti
Soggettiva: mostra che le facoltà dello
spirito umano (sensibilità e intelletto) contribuiscono a costituire
l'oggetto dell'esperienza. Oggettiva: mostra come l'oggetto sia
costituito dai dati della sensibilità e dai concetti dell'intelletto.
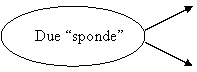
Da entrambi i punti di vista, la deduzione trascendentale vuole essere la dimostrazione che le categorie sono necessarie per la costituzione dell'oggetto.
L'unità viene
dall'intelletto, dall'io penso, che è unità trascendentale d'appercezione. L'unità non può
venire dai dati sensibili, perché essi sono il caos delle impressioni.![]()
![]()
![]()
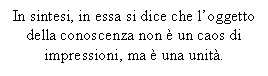
![]()
![]() Nella seconda edizione prevale l'aspetto oggettivo della deduzione
trascendentale.
Nella seconda edizione prevale l'aspetto oggettivo della deduzione
trascendentale.
![]()
![]() L'unità dell'oggetto è l'unità che tiene insieme le sue proprietà, e
questo legame si esprime nel giudizio. In questo modo è dedotta (giustificata e
dimostrata) la presenza unificatrice dell'intelletto per costituire l'oggetto,
ed è risolto il problema del come siano possibili giudizi sintetici a priori.
L'unità dell'oggetto è l'unità che tiene insieme le sue proprietà, e
questo legame si esprime nel giudizio. In questo modo è dedotta (giustificata e
dimostrata) la presenza unificatrice dell'intelletto per costituire l'oggetto,
ed è risolto il problema del come siano possibili giudizi sintetici a priori.
Se l'oggetto è
costituito da tale attività unificatrice dell'intelletto, allora le leggi
di natura (degli oggetti) sono conosciute a priori, e non per
generalizzazione. Esse infatti sono imposte dall'intelletto-autore.
I principi della ragion pura
Appurato ciò, sorgono nuovi problemi.
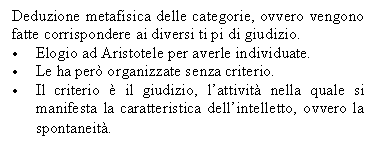
![]()
![]() Quali e quante sono le
categorie?
Quali e quante sono le
categorie?
Kant dimostra
la necessità delle categorie della relazione (sostanza, causa, azione
reciproca). Esse sono le categorie centrali del suo sistema.![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Come entrano in funzione
le categorie nei principi dell'intelletto?
Come entrano in funzione
le categorie nei principi dell'intelletto?
L'applicazione di tali categorie dà luogo a quei principi che Kant chiama analogie dell'esperienza. Esse sono le leggi fondamentali:
I ANALOGIA: Principio di permanenza della sostanza: in ogni mutamento dei fenomeni la sostanza permane. Il mutamento infatti suppone un substrato che permanga identico, altrimenti non ci sarebbe mutamento ma solo molteplicità.
Dobbiamo anche presupporre un tempo unico, rispetto a cui fissare un prima e un poi; il substrato che rappresenta il tempo in generale è la sostanza.
II ANALOGIA: Legge di causalità: tutti i mutamenti avvengono secondo la legge del nesso di causa ed effetto. Il concetto di causa aggiunge a quello di antecedente nel tempo la nozione di necessità.
Contaminazione di fisica e metafisica: è principio di inerzia e principio di ragion sufficiente.
III ANALOGIA: Tutte le sostanze, in quanto possono essere percepite nello spazio come contemporanee, sono in continua azione reciproca. (azion
Lo schematismo
Nella formulazione delle analogie è costante il riferimento al tempo. Esso ha la funzione di:
![]() Condizione della conoscenza
sensibile.
Condizione della conoscenza
sensibile.
Devono necessariamente applicarsi ad esse
per costituire l'oggetto. MA I concetti puri sono affatto eterogenei
alle intuizioni sensibili. Condizione
universale di applicabilità delle categorie alle intuizioni: come tale il
tempo è schema dei concetti puri. Infatti:![]()
![]()

![]()
![]()
![]() Intermediario tra concetto puro e dati della sensibilità.
Intermediario tra concetto puro e dati della sensibilità.
Poiché nella deduzione trascendentale Kant aveva descritto l'immaginazione come intermedia tra intelletto e sensibilità, lo schema è prodotto dell'immaginazione (immagine come esempio di concetto).
Motivo non dichiarato dello schematismo è che la nozione di tempo è implicita nell'applicazione dei concetti di materia, forza, azione per la spiegazione dei fenomeni.
La dialettica trascendentale
L'intelletto da solo non basta a rappresentare un oggetto: ha bisogno di dati sensibili come materiale da unificare. Nella ragion pura, qui si ferma l'Analitica trascendentale, la parte positiva, e inizia la negativa.
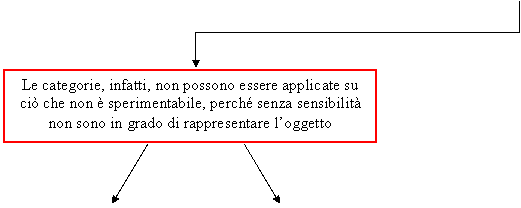
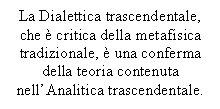
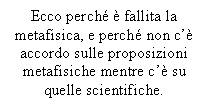
La metafisica è il risultato dell'uso dialettico (ovvero puramente formale) dei concetti dell'intelletto, per determinare cosa sia ciò a cui tali concetti si applicano.
![]()
![]() I concetti dell'intelletto,
infatti, sono forme vuote, fatte per unificare i dati sensibili.
I concetti dell'intelletto,
infatti, sono forme vuote, fatte per unificare i dati sensibili.
L'incondizionato che fonda: Il suo errore è
l'illusione di aver trovato la condizione ultima, l'incondizionato. Kant
chiama appunto ragione la facoltà
che cerca l'incondizionato. Nasce da una
esigenza dell'intelligenza umana: il non fermarsi mai nella ricerca delle
ragioni, delle condizioni di ciò che è dato.![]()
![]() I fenomeni psichici è l'anima.
I fenomeni psichici è l'anima.![]() I fenomeni fisici è il cosmo.
I fenomeni fisici è il cosmo.![]() Ogni realtà è Dio.
Ogni realtà è Dio.![]()
![]()
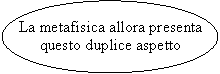
![]()
![]()
![]() Usati per conoscere delle realtà in sé, superando il mondo
dell'esperienza, danno conoscenza illusoria.
Usati per conoscere delle realtà in sé, superando il mondo
dell'esperienza, danno conoscenza illusoria.
Queste sono le tre idee della ragione: ci danno un punto di convergenza al quale tendono i ragionamenti, ma un punto solo ipotetico e problematico. Non costituiscono un oggetto.
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025