|
|
| |
CAMPIONAMENTO
Un momento fondamentale di una analisi è rappresentato dal campionamento, generalmente si pensa che i campioni da analizzare siano omogenei e che abbiano in ogni punto la stessa composizione, per cui la variazione dei risultati analitici dovrebbe riflettere soltanto l'abilità della persona che esegue l'analisi, nonché la variabilità intrinseca del metodo analitico.
Nella realtà, tuttavia, i campioni sono generalmente eterogenei, la loro composizione varia cioè da un punto all'altro del campione stesso.
L'acqua di uno stesso lago è eterogenea: la parte prossima alla superficie non si mescola rapidamente a quella che si trova sul fondo. Lo strato superiore dell'acqua è probabilmente in equilibrio con l'atmosfera, mentre quello inferiore è in equilibrio con il sedimento.
I vari organismi che determinano la composizione chimica dell'acqua vivono in regioni diverse. Esistono generalmente gradienti verticali di temperatura e di densità attraverso il lago e i diversi strati presentano composizioni diverse tra loro.
I campioni da analizzare presentano un problema di campionamento e necessitano di un trattamento particolare. Esistono procedure più standardizzate a cui attenersi per ogni tipo di campione.
Campionamento Un campionamento corretto è fondamentale perché l'analisi sia attendibile. L'analista deve decidere, in accordo con i suoi colleghi tecnici, come, dove e quando deve essere prelevato un campione perché sia davvero rappresentativo dei parametri che devono essere misurati.
La maggior parte delle analisi chimiche sono caratterizzate dai seguenti stadi:
Ottenimento di un campione rappresentativo dal lotto.
Estrazione di un campione da laboratorio omogeneo dal campione rappresentativo.
Conversione del campione da laboratorio in una forma adatta per l'analisi, processo che di solito implica la dissoluzione del campione. Campioni a bassa concentrazione di analita possono dover essere concentrati prima dell'analisi.
Rimozione o mascheramento delle specie che interferiscono con l'analisi chimica.
Misura della concentrazione di analita in varie aliquote. In alcuni casi vengono usati metodi analitici differenti su campioni simili per assicurarsi che ciascun metodo dia lo stesso risultato.
Interpretazione dei risultati e presentazione delle conclusioni che possono essere tratte.
Lo studio della statistica è fondamentale per lo stadio 6, perché permette di interpretare i risultati sperimentali.
![]()
![]()
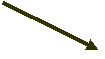
|
|
|
Il campionamento il processo di selezione dal lotto di un campione rappresentativo composito
La preparazione del campione è il processo che converte un campione composito in un campione omogeneo da laboratorio.
La preparazione del campione si riferisce anche agli stadi nei quali si eliminano specie che interferiscono con l'analisi chimica o nei quali si concentra I'analita
Per la raccolta di un campione casuale, il lotto di materiale viene suddiviso in numerosi settori reali o immaginari. I campioni vengono prelevati da alcuni dei suddetti settori scelti a caso, preferibilmente con l'ausilio di una tabella di numeri casuali.
Trattamento preliminare del campione La quantità di campione prelevato per un'analisi quantitativa generalmente viene misurata in massa o in volume. Quando il campione è già omogeneo, esso può essere suddiviso senza ulteriori trattamenti. Per molti solidi, come ad esempio per i minerali, è necessaria una macinazione e una miscelazione preliminare. Il campione necessita spesso di ulteriori pretrattamenti per l'analisi, quali essiccamento, calcinazione e solubilizzazione.
Quando si analizza un materiale eterogeneo, il risultato ottenuto dipenderà molto dal modo in cui il campione è stato prelevato dall'intero lotto di materiale.
La composizione di un campione può variare col tempo anche dopo il prelievo, ciò a causa delle variazioni chimiche interne, della reazione con l'aria, o dell'interazione del campione con il materiale del recipiente nel quale è contenuto.
Se si desidera che i risultati ottenuti abbiano una qualche validità, sarà necessario seguire un metodo rigoroso nella scelta dei campioni.
Un campione composito è realizzato appositamente per essere il più possibile rappresentativo dell'intera massa del materiale da analizzare. Se un solido presenta tre zone i cui volumi relativi sono rispettivamente e , un campione composito dovrebbe essere composto da campioni di ogni zona in rapporto di volume .
Il materiale composito viene poi reso omogeneo (spesso mediante frantumazione) e poi analizzato. Il campione che verrà analizzato dovrebbe essere rappresentativo dell'intero lotto di materiale.
STADI DI UNA ANALISI (da Desimone)
I Definizione generale del problema (cliente
II Definizione analitica del problema (cliente o analista)
III Scelta di metodo, tecnica, procedura, protocollo (analista)
IV Campionamento (cliente o analista)
V Trattamento del campione (analista)
VI Analisi (analista)
VII Valutazione dei dati (analista)
VIII Conclusioni (analista)
IX Relazione (analista o cliente
Nel primo stadio il cliente (concetto ampio) presenta all'analista il problema (determinazione del manganese in un acciaio speciale, di un componente volatile di un aroma, del glucosio nel sangue, del piombo in un particolato atmosferico, del solfato di ammonio in un concime, etc.).
Nel secondo stadio si definiscono i dettagli tecnici (analisi qualitativa o quantitativa, quanto materiale è disponibile, che informazioni esistono sulla sua composizione, il tempo a disposizione, l'errore consentito, il costo probabile, etc.).
Sulla base delle informazioni raccolte l'analista sceglie metodo, tecnica, procedura e, eventualmente, protocollo.
Segue lo stadio del campionamento, uno dei più critici di tutta la procedura : un campionamento non significativo può falsare completamente l'analisi. I problemi da risolvere sono molti:
Il campionamento deve essere casuale o sistematico?
il campione è eterogeneo?
Quanto campione deve essere prelevato per assicurare un campionamento rappresentativo?,
Devono essere analizzati i singoli campioni o un campione composito (cioè composto da aliquote di diversi campioni)?,
Il campionamento implica rischi di contaminazione personale, di avvelenamenti o di esplosioni?,
I campioni sono stati etichettati in modo esauriente (data, numero, località, lotto)?, etc.
Un corretto campionamento deve obbedire a criteri statistici specifici.
Lo stadio successivo (trattamento) può essere più o meno complesso.
È necessario far precedere la conservazione da un frazionamento (separazione delle varie fasi del campione)?
Sono previsti stadi di dissoluzione, fusione, separazione, diluizione, concentrazione, derivatizzazione?
È opportuno condizionare il contenitore, al fine di limitare le interazioni del campione con le pareti del contenitore stesso?
In definitiva, il trattamento è diretto a evitare che la conservazione pregiudichi lo stato chimico o fisico del campione e ad ottimizzare lo stadio successivo di misurazione.
La misurazione (analisi) deve essere effettuata con metodi idonei a contenere gli errori sperimentali nei limiti richiesti. Gli strumenti devono essere calibrati con standard opportuni. Devono essere effettuate repliche in numero sufficiente a diminuire il rumore che affligge la misurazione o compensare la deriva del segnale nel tempo.
Ogni segnale è costituito da due contributi, il primo originato dall'analita e il secondo da altri componenti della matrice e dalla strumentazione usata nella misurazione. Questa seconda parte è nota come rumore e determina fluttuazioni casuali del segnale.
Talvolta, come nel caso di analisi legali, può essere necessario seguire rigorosamente protocolli di analisi specifici.
I dati ottenuti devono poi essere valutati mediante uso di opportune tecniche statistiche al fine di stimare la precisione e, se possibile e/o necessario, l'accuratezza, cioè la rispondenza ai requisiti precedentemente definiti dal cliente. Solo a questo punto è possibile compilare la relazione che deve riportare in modo chiaro, conciso ed esauriente i risultati del lavoro dell'analista.
Da quanto esposto si può concludere che la misurazione sperimentale è spesso lo stadio più facile della procedura analitica totale.
L'elenco sottoriportato mostra quali campioni si possono analizzare attualmente con i metodi enzimatici: mentre alcuni possono essere semplicemente diluiti, altri necessitano di un trattamento per essere analizzati.
|
CAMPIONI |
|
|
acqua di piscina |
prodotti di gastronomia |
|
acque di scarico |
prodotti di pasticceria |
|
prodotti farmaceutici |
additivi alimentari |
|
alcolici |
prodotti lattiero-caseari |
|
bevande rinfrescanti |
alimenti dietetici |
|
birra |
prodotti per l'infanzia |
|
caffè |
Salse |
|
spumante |
Sottaceti |
|
carta |
Spezie |
|
cartone |
succhi di frutta |
|
cioccolata |
succhi di verdura |
|
confetture |
Surgelati |
|
tabacco |
Conserve |
|
cosmetici |
Tè |
|
detergenti |
Uova |
|
dolciumi |
Vino |
|
fertilizzanti |
Zucchero |
|
gelato |
Latte |
|
maionese |
|
|
Campioni clinici |
|
|
|
|
|
liquor |
liquido seminale |
|
plasma |
Sangue |
|
urina |
Siero |
|
terreni per colture cellulari |
Tessuti |
Esempio: Campionamento microbiologico
H Il campionamento è parte integrante del procedimento analitico.
H I risultati sono strettamente legati al campionamento ed alla preparazione del campione.
H Campioni non rappresentativi e non preparati nel modo dovuto producono grandi errori analitici.
Risultato
![]() Fattori
influenzanti il
Fattori
influenzanti il
risultato analitico
analitico
Quanto più il campione non è omogeneo, tanto più il campionamento potrà influenzare il risultato analitico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Processo
Processo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() di
di
Preparazione analisi Materiali
![]()
![]()
![]() campione
campione
![]()
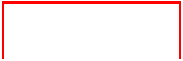
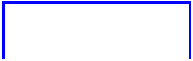
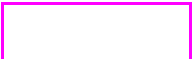
Piano di Trasporto Mezzi di
trasporto campione trasporto
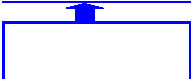
![]()
![]()
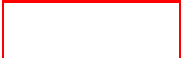
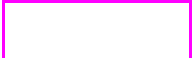
Piano di Processo di Mezzi di
campionamento campionamento campionamento
![]()
![]()
![]()

CAMPIONAMENTO omogeneo ed eterogeneo
In un'esercitazione di laboratorio ci si assicura che i campioni da analizzare siano omogenei e che abbiano in ogni punto la stessa composizione.
Quando invece si analizza un materiale eterogeneo, il risultato ottenuto dipenderà molto dal modo in cui il campione è stato prelevato dall'intero lotto di materiale.
Due punti importanti da stabilire sono:
Quale sia la quantità di campione da prelevare per l'analisi;
Quante porzioni di campione si devono analizzare.
1. Quale quantità di campione si deve prelevare per un'analisi?
v Si prende una certa quantità di campione,
v La si analizza,
v Si fa la media,
v Si definisce una costante di campionamento ks
La quantità di campione necessaria per ottenere una determinata deviazione standard è: mR2 ks dove:
m = massa di ogni campione;
R = coefficiente di variazione;
ks = costante di campionamento.
La tabella presenta i risultati sperimentali del campionamento del radioisotopo Na nel fegato umano.
Il tessuto è stato omogeneizzato in un miscelatore, ma non è realmente omogeneo dato che consiste in una sospensione di piccole particelle di tessuto in acqua.
|
Quantità di Campione (g) |
Deviazione standard (Bq/g) |
CV (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il numero medio di colpi per emissioni radioattive al secondo per grammo di campione è circa 237 Bq.
Quando la massa di campione per ciascuna analisi era di circa 0,1 g, la deviazione standard (rappresentata nel diagramma dalla fascia dell'errore) risultò essere di ± 31 Bq per grammo di fegato, che corrisponde a del valore medio ( ). Quando le dimensioni del campione furono portate a 1 g circa, la deviazione standard scese a colpi al secondo per grammo, cioè a del valore medio. Nel caso di un campione di circa 6 g, la deviazione standard si ridusse a colpi al secondo per grammo di campione, cioè a del valore medio.
![]()
![]() Colpi al
secondo
Colpi al
secondo

(Bq/g)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Media = 237
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
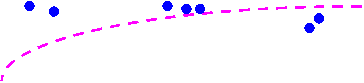
![]()
![]()
Ks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 10
Logaritmo del peso del campione (g)
Peso di campioni omogenato di fegato contenenti Na. I punti rappresentano i dati sperimentali, e le fasce dell'errore si estendono di 1 deviazione standard intorno alla media (237 Bq/g) (B.Kratovic e J.K.Taylor, Anal,Chem., 53, 925A (1981); National Bureau of Standars, ora NIST, Internal Report 80-2164, 1980, p. 66).
Le linee tratteggiate sul grafico servono a valutare che, per ridurre la deviazione standard a del valore medio, è necessaria un'aliquota di campione di 35 g.
La massa di campione richiesta per ridurre la deviazione standard a del valore medio è detta costante di campionamento Ks
La quantità di campione necessaria per ottenere una deviazione standard nel campionamento si può calcolare utilizzando l'equazione:
mR2 Ks
dove m è la massa di ogni campione analizzato e R è il coefficiente di variazione.
ESEMPIO: Quale massa di campione nella figura darà una imprecisione (coefficiente di variazione) nel campionamento di
Tale variazione è dovuta principalmente all'eterogenicità del campione e non all'errore nel metodo analitico.
2. Quante porzioni di campione si dovrebbero utilizzare?
![]() N t2sC2
N t2sC2
e2 dove:
N = numero di campioni richiesti;
![]() t = valore della t di Student per un livello di fiducia del e n-1 gradi di
libertà e dato che il valore di n non
si conosce si utilizza t
per N
t = valore della t di Student per un livello di fiducia del e n-1 gradi di
libertà e dato che il valore di n non
si conosce si utilizza t
per N
s2c = deviazione standard dell'operazione di campionamento;
e2 = incertezza richiesta sul valore medio.
Dato che il valore di N non si conosce, è necessario un calcolo iterativo, utilizzando inizialmente il valore di t per N = per calcolare N. Una volta calcolato un valore N, si utilizza il valore t per quel dato valore di N e si calcola il nuovo valore di N. Si ripete lo stesso procedimento alcune volte fino a ottenere un valore di N costante.
ESEMPIO: Campionamento di una massa di materiale a distribuzione casuale.
Si voglia calcolare quanti campioni da 0,7 g debbano essere analizzati per poter affermare, ad un livello di fiducia del , che il valore medio sia conosciuto entro .
Massa campione = 0,7 g
Si esprimeranno entrambe le incertezze in forma relativa.
Imprecisione relativa sC = 7%
Incertezza relativa e = 5% del campione.
Nel caso dei calcoli precedenti si richiedeva una conoscenza preliminare di sc e di X medio. É importante svolgere un'analisi del campione prima di organizzare il resto delle analisi. Nel caso in cui si debbano analizzare molte campioni simili, l'analisi approfondita di uno solo tra questi, potrebbe permettere all'analista di eseguire analisi meno accurate - ma sufficienti - sul resto del materiale.
Tabella B - La distribuzione t
Livello di fiducia 0,90 0,95 0,99 0,995
Livello di significatività Â 0,10 0,05 0,01 0,005
n
1 6,31 12,71 63,66 127
2 2,92 4,30 9,92 14,1
3 2,35 3,18 5,84 7,45
4 2,13 2,78 4,60 5,60
5 2,01 2,57 4,03 4,77
6 1,94 2,45 3,71 4,32
7 1,89 2,36 3,50 4,03
8 1,86 2,31 3,36 3,83
9 1,83 2,26 3,25 3,69
10 1,81 2,23 3,17 3,58
11 1,80 2,20 3,11 3,50
12 1,78 2,18 3,05 3,43
13 1,77 2,16 3,01 3,37
14 1,76 2,14 2,98 3,33
15 1,75 2,13 2,95 3,29
16 1,75 2,12 2,92 3,25
17 1,74 2,11 2,90 3,22
18 1,73 2,10 2,88 3,20
19 1,73 2,09 2,86 3,17
20 1,72 2,09 2,85 3,15
21 1,72 2,08 2,83 3,14
22 1,72 2.07 2,82 3,12
23 1,71 2.07 2,81 3,10
24 1,71 2.06 2,80 3,09
25 1,71 2,06 2,79 3,08
30 1,70 2,04 2,75 3,03
40 1,68 2,02 2,70 2,97
60 1,67 2,00 2,66 2,91
120 1,66 1,98 2.62 2,86
1,64 1,96 2,58 2,81
Errore di campionamento ed errore analitico
Per conoscere tutti gli errori casuali, si può ricavare la imprecisione come deviazione standard complessiva, sT, che è legata alla deviazione standard del metodo analitico (misura finale), sA, e alla deviazione standard di campionamento (prelievo del campione), sC, secondo la formula seguente:
s2T = varianza totale del metodo;
sA deviazione standard del metodo analitico;
sS deviazione standard dell'operazione di campionamento
Un metodo analitico più affidabile (meno impreciso) ma più dispendioso, sia in termini economici che di tempo, la cui deviazione standard sA sia soltanto dell' , migliorerebbe il risultato totale di quanto?
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025