|
|
| |
Il clima esprime la media delle condizioni climatiche in svariati anni.
Macroclima: clima che si manifesta in un territorio più o meno vasto in stretta relazione con la situazione geografica (longitudine, latitudine, lontananza dai mari e oceani, orografia). Esempio: regione alpina, mediterranea, ecc.
Microclima: clima che si manifesta in un punto limitato dalla superficie terrestre (grotta, sottobosco, cave, rupe soleggiata, radure, ecc.).
Mesoclima: variazioni che subisce il macroclima di una regione a seconda degli influssi locali. Esempio: nelle valli alpine parallele ai paralleli il clima e più secco, ciò si ripercuote sulla vegetazione: pino silvestre, quindi mesoclima di tipo steppico.
L'indicatore più usato il clima è la temperatura, è rappresentata attraverso le isoterme (linee ad uguale temperatura) si fanno delle carte in cui vengono rappresentate le zone considerate. Le misure che si fanno sono: T media giornaliera, T media diurna (era più usata una volta, media tra Tmin e Tmax), T media mensile, T media annuale, poi si fanno misurazioni sull'escursione termica diurna (Tmax-Tmin) e annua (T media del mese più caldo - T media del mese più freddo).
Un altro indicatore molto comune è l'umidità che, assieme alla temperatura, sono in grado di definire direttamente i processi di radiazione solare (latitudine, atmosfera, orografia), movimenti delle masse d'aria e d'acqua, la rotazione terrestre e la struttura termica dell'atmosfera.
Un altro dato di cui si può disporre facilmente sono le precipitazioni (in mm), su carta si mettono in questo caso le isoiete (linee di uguale precipitazione) e l 252j97c e misura fatte sono: P totale giornaliera, mensile e annuale.
(Esempio della carta dell'Emilia Romagna. T e P media annuale: sugli Appennini le isoterme sono molto ravvicinate fra loro, notare la differenza di P fra la zona montuosa del piacentino (ovest) in cui sono molto alte (2000) e la costa romagnola (est) in cui piove relativamente meno (700), si ha un gradiente altitudine che influenza le precipitazioni.)
Il sistema più usato per rappresentare temperatura e precipitazione è il diagramma ombrotermico[1]. È un diagramma a doppia scala, si basa sulla relazione 1 P = 2 T, in ascissa ci sono i mesi dell'anno e sulle ordinate T in °C e P in mm. I valori delle medie mensili si devono riferire ad un periodo di almeno 10 anni.
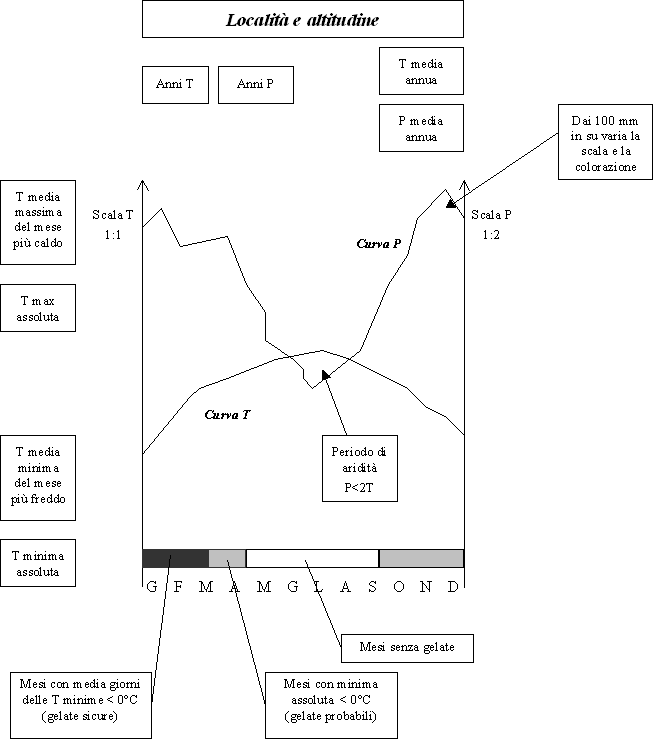
I regimi pluviometrici (distribuzioni delle piogge) sono vari:
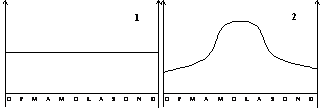
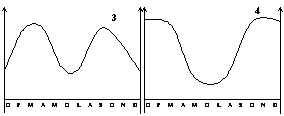
Regime oceanico: precipitazioni durante tutto l'anno (non presente in Italia).
Regime continentale: massime precipitazioni all'inizio dell'estate (in alcune valli alpine parallele ai paralleli, ad esempio in Val Venosta, si ha un massimo estivo invece che invernale con vegetazione di pino silvestre (si piantano i meli)).
Regime equinoziale o prealpino: due massimi in autunno e primavera (pianura padana e prealpi, vedi clima centroeuropeo e di transizione, come a Bologna dove si ha un piccolo periodo di aridità in giugno-luglio).
Regime mediterraneo: piogge dall'autunno alla primavera con vasta zona di aridità estiva (sulla zone costiere, vedi clima mediterraneo).
E solo per l'Italia: Regime appenninico montano: ha andamento simile a 4) ma con P>
Sono regioni ecologiche distinte da diversi tipi di vegetazione naturale. I biomi sono ottimi indicatori climatici e ci danno più informazioni dei singoli parametri fisici.
I principali fattori limitanti per la vita delle piante sono la possibilità di fissare azoto, la disponibilità di certi elementi nel suolo (metalli rari, come molibdeno) e soprattutto la disponibilità d'acqua. Quindi i biomi saranno disposti secondo le precipitazioni e successivamente a seconda dell'altitudine.
Noi considereremo i vari biomi terrestri
sezionando
Area in cui la traspirazione e l'evaporazione superano le precipitazioni (250 mm/anno), si ha una grande escursione termica dal giorno alla notte e a seconda di questo fattore si differenziano in (con escursione termica crescente):
Tipo tropicale (Sahara)
Tipo temperato (California)
Tipo freddo (il freddo è solo d'inverno naturalmente, Gobi)
La vegetazione è assente o scarsa, e di tipo basso. Le piante grasse si chiamano così perché trattengono l'acqua all'interno delle loro foglie spinose, che hanno uno spesso rivestimento cerato. Il deserto fiorisce ad ogni pioggia grazie alle terofite (hanno un ciclo vitale ridotto). I cactus in Arizona fanno la fotosintesi, sono di tipo C4 e aprono i loro stami solo di notte per risparmiare acqua. Gli animali sono notturni e vivono in gallerie.
Regioni in cui le precipitazioni sono irregolari, ma sufficienti a far crescere erbe (graminacee) e qualche albero isolato (baobab, acacie a ombrello), la siccità e gli incendi prevengono la formazione di boschi. Il manto erboso si rinnova se non è sottoposto a pascolo eccessivo[2]. Si distinguono tre tipi di praterie.
Alte temperature (21-
Inverni molto freddi, con un solo breve
periodo di alte precipitazioni, ed estati calde e secche. Erbe graminacee
coprono un paesaggio piatto e quasi e su cui soffia costantemente il vento.
Esempi sono le praterie americane (ricevono più pioggia delle praterie, hanno
un suolo molto fertile, che molto spesso viene coltivato aumentandone così la
corrosione da parte del vento: desertificazione), le steppe asiatiche (T media
8-
Per la maggior parte dell'anno, queste piane
prive di alberi[3] sono
ricoperte di neve e ghiaccio e spazzate da venti gelidi. Gli inverni sono
lunghi e senza luce e l'acqua deriva dallo scioglimento della neve, non da
precipitazioni. La vegetazione è scarsissima: licheni, muschi, erbe e piccoli
cespugli, la loro crescita avviene nei 3-4 mesi estivi, quando è disponibile
acqua e il sole non tramonta. La decomposizione è lenta a causa della bassa
temperatura e la sostanza organica parzialmente decomposta si accumula e
acidificandosi diventa torba. Un altro effetto del freddo estremo è il
permafrost, uno strato di ghiaccio (
Coprono aree con precipitazioni da moderate ad alte e sono formate da diversi tipi di alberi a seconda del clima.
L'aria è sempre calda e umida, le oscillazioni termiche sono minime e piove quasi in continuazione (3000-10000 mm/anno), quindi acqua e temperatura non sono fattori limitanti. Lo sono invece i sali nutritivi, di cui il suolo è povero.
Le piante sono sempreverdi, a foglia larga, e
cortecce molto spesse[5]
e hanno radici poco penetranti e superficiali, infatti le piante trattengono
nel loro corpo le sostanze nutritive, anziché cederle al suolo e riprenderle.
Si sono così organizzate in un ciclo chiuso dal punto di vista
chimico-energetico, esse hanno anche un proprio ciclo dell'acqua e del carbonio ,
chiusi entrambi. Alcune piante vivono in simbiosi con funghi micorrizici, che
si sono attaccati alle radici per aumentare, per velocizzare l'assorbimento di
sostanze nutrienti ,
altre invece sono nate direttamente sui rami delle piante più alte (anche
In una foresta pluviale vi è una biodiversità maggiore che in ogni altro bioma, ad esempio le piante sono stratificate a seconda dell'altezza e quindi dell'intensità di luce che penetra.
Se vengono disboscate ampie aree, queste si trasformano in praterie o deserti. Il suolo diventa sterile in poco tempo perché la maggior parte dei nutrienti sono contenuti nelle piante (molte di loro sono addirittura indipendenti dal terreno), una volta tolti gli alberi il suolo perde, per dilavamento, i pochi sali che possiede e viene esposto all'erosione. Questo perché, a differenza di una foresta temperata, lo strato di humus è molto sottile e le piogge lo portano, via lasciando una corazza dura su cui non si può coltivare. Un suolo tropicale può essere coltivato solo per un paio d'anni senza il massiccio apporto di fertilizzanti artificiali, si tende quindi ad abbandonarlo per tagliare[8] un'altra porzione di foresta .
Ogni anno vengono distrutti 17-18 milioni di ettari di foreste tropicali (di cui 2,5 incendiati), le cause principali sono la richiesta di legno crescente (per mobili e riscaldamento), l'agricoltura itinerante, allevamenti di bestiame estensivi e, anche, il taglio selettivo contribuisce al degrado[10].
Gli effetti sono molteplici: aumento dell'albedo che porta a un clima con precipitazioni irregolari, aumento dell'anidride carbonica (effetto sera) [11]. Il danno maggiore è, comunque, la scomparsa di tantissime specie vegetali e animali, con riduzione della biodiversità.
Interposte fra le foreste pluviali e le savane. Vivono sempre nei climi caldi, però le precipitazioni (1000 mm/anno), pure abbondanti, sono limitate alla stagione delle piogge, seguita da una lunga stagione secca, in cui le foglie cadono per risparmiare acqua e ridurre la traspirazione. Il suolo è sempre povero di sali.
Si trovano in aree esposte a venti umidi marittimi o nebbie oceaniche (Nord America). Sono dominate da grandi conifere (abeti e sequoie). Le precipitazioni sono abbondanti, ma la temperatura media è abbastanza bassa.
Crescono in zone con temperature medie di 15°C: lunghe estati, inverni freddi ma non troppo e precipitazioni abbondanti distribuite uniformemente. Hanno una composizione più semplice delle precedenti: prevalgono alberi con foglie larghe e decidue (querce, faggi). È presente un sottobosco più ricco che nelle foreste pluviali perché la luce riesce a filtrare meglio. Inoltre il suolo è ricco di sostanze nutritive, grazie alla caduta delle foglie e alla loro decomposizione.
Si trovano nelle regioni settentrionali dove
il clima è subartico: inverni lunghi e secchi, con poca neve (200-600 mm/anno)
e poca luce, le estati sono corte con molte ore di luce. Temperatura media
minore di
La taiga è particolarmente vulnerabile alle piogge acide (vedi pagina 26) cui le foglie sono esposte in continuazione dato che non si rinnovano. L'acidità naturale del terreno non può neutralizzare la deposizione acida, che indebolisce gli alberi.
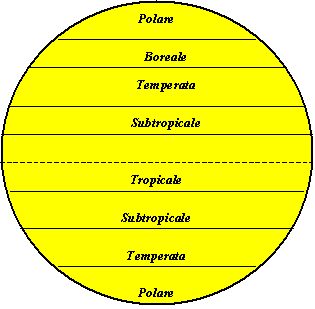 La figura rappresenta le reali zone climatiche
globali, nell'emisfero sud manca la zona boreale. La zona subtropicale corre
lungo tutto il mediterraneo e lambisce le coste italiane. In Australia vi si
trovano tre tipi di zone: tropicale, subtropicale e temperata.
La figura rappresenta le reali zone climatiche
globali, nell'emisfero sud manca la zona boreale. La zona subtropicale corre
lungo tutto il mediterraneo e lambisce le coste italiane. In Australia vi si
trovano tre tipi di zone: tropicale, subtropicale e temperata.
Ogni zona a seconda della latitudine comprende diversi biomi (tutta l'Europa sta nella zona temperata), analoga variazione si ha con l'altitudine: salendo dal livello del mare lungo il fianco di una montagna incontriamo, nello stesso ordine, gli stessi tipi di vegetazione.
|
|
| ||
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per i cambiamenti climatici naturali a seconda dei movimenti astrologici vedi pagina
Negli ultimi 100 anni si è avuto un aumento di CO2 come negli ultimi 20000 anni in modo naturale! Dopo la rivoluzione industriale la quantità di anidride carbonica nell'aria è aumentata da 270 ppm a 360 ppm.
In 10000 anni la temperatura è aumentata
naturalmente di
L'effetto serra è dovuto ai gas CO2
e vapore acqueo (sono il 50%), CH4 (18%[13]),
CFC (14%) e NO2 (6%). Le principali fonti sono: 57% sono gas di
combustione (combustibili fossili), 17% CFC, il resto sono derivati dal
disboscamento, agricoltura pesante, ecc. Se le previsioni corrisponderanno alla
realtà, la rapidità di cambiamento sarà troppo veloce e le variazioni non
daranno tempo ai viventi e all'ambiente di adattarsi (con spostamento delle
zone e vegetazioni calde verso quelle temperate). Risparmieremo sul
riscaldamento, ma aumenterà il condizionamento d'aria che produce CFC. Aumenterà
l'agricoltura, ma anche gli insetti infestanti (maggior uso di pesticidi).
Aumenterà, anche, la respirazione e l'evaporazione che produrrà molta siccità.
Nella tundra il permafrost potrebbe liberare metano (gas serra) a causa
dell'eutrofizzazione degli acquitrini. E inoltre sono probabili aventi meteorologici
estremi (tifoni, cicloni, uragani), diffusioni di nuove malattie e incendi. Da
non sottovalutare sarà anche l'innalzamento del livello del mare causato dallo
scioglimento dei ghiacci polari. Se
consideriamo che la maggior parte della popolazione mondiale vive molto vicino
al mare, con soli
L'unica speranza, in questa situazione paradossalmente disastrosa, è una retroazione negativa: con T più alta, ci sarà più evaporazione che porterà ad un aumento della copertura nuvolosa, a cui segue un minor riscaldamento e quindi maggiori nevicate ai poli, raffreddamento della terra e successivo bilanciamento, tutto questo a livello teorico.
L'unica cosa certa e misurabile adesso è l'aumento della CO2, le altre sono solo ipotesi. Comunque sarebbe meglio "prevenire che curare", i rimedi sono: ridurre drasticamente l'emissione, cessare il disboscamento, migliorare l'uso energetico e cercare di abituarsi ad un livello del mare più alto.
La fascia d'ozono O3 sta ad una
altezza di
Nel 1974 due ricercatori osservarono che i CFC[14] erano in grado di influire in modo negativo sull'ozono. I CFC sotto i raggi ultravioletti si spezzano e liberano un atomo di cloro che attacca l'ozono formando monossido di Cl e ossigeno, il primo reagisce a catena attaccando ancora l'ozono formando ossigeno e Cl, così il ciclo ricomincia. A volte poi si formano anche nitrati di Cl. I CFC per arrivare nella stratosfera, tramite i moti convettivi, impiegano 10-20 anni e ogni molecola sta nell'atmosfera per 65-110 anni e in tutto questo tempo una molecola di CFC può distruggere 100000 molecole di ozono.
Al polo sud durante l'estate antartica (settembre/dicembre) viene distrutto il 50% dell'ozono che fa allargare il buco: nel '93 era 3 volte le dimensioni degli USA. Durante l'inverno si formano dei vortici sopra al polo sud che intrappolano in goccioline i CFC, facendoli diventare inerti, poi però durante l'estate entrano in azione. Al polo nord l'assottigliamento è pari al 25%nel periodo febbraio/giugno. Si sono avuti aumenti significativi del buco anche in Cile, Argentina, Sudafrica, nuova Zelanda, Australia[15], con aumento del 20% delle radiazioni.
Altri responsabili sono: aloe, bromuro di etili, metil-cloroformio, tetracloruro di carbonio.
Il problema più grave è che il buco lascia
passare gli UV che possono provocare il cancro alla pelle, danneggiare il DNA e
modificare gli embrioni. Un
assottigliamento dell'1% lascia passare il 2% in più degli UV, così aumentano
del 5-6% le malattie. Inoltre diminuisce
I grandi organi mondiali si sono incontrati due volte per discutere il problema dell'ozono, prima a Montreal per diminuire la produzione di CFC, poi a Londra per bloccarne la produzione entro il 2000, oggi, 1998, la produzione è calata moltissimo, ma non ancora annullata.
Nella savana l'ordine di successione di animali al pascolo è molto preciso: per prime avanzano le zebre (erba alta e dura), gli gnu (steli), poi le gazzelle di Thompson (foglie tenere), questo ordine rende massima l'utilizzazione dell'erba (che dopo la pioggia cresce molto rapidamente).
Perché le radici non si possono sviluppare a causa del permafrost, del freddo invernale e del forte vento.
L'acqua che piove è la stessa che evapora e traspira dalle piante. Mentre l'anidride carbonica prodotta dalla decomposizione e dalla respirazione delle piante è la stessa usata per la fotosintesi.
Gli indios disboscavano una piccola parte di foresta, poi dopo qualche tempo si spostavano e lasciavano che la foresta recuperasse la zona tagliata (ci impiega più o meno un paio d'anni).
Questo in realtà è un falso problema, in quanto l'ossigeno che era prodotto dalla piante eliminate era consumato dalle stesse.
Il metano è in aumento, deriva dalle paludi, risaie, discariche, incendi e dagli apparati digestivi dei ruminanti.
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025