|
|
| |
|
ORGANULI E SISTEMI DI MEMBRANE |
I mitocondri
Per compiere le loro funzioni le cellule consumano
energia che proviene da reazioni chimiche; queste reazioni chimiche avvengono
principalmente nei mitocondri, organuli siti nel citoplasma che possono
essere paragonati a microscopiche centrali energetiche.
I mitocondri hanno forma cilindrica e sono lunghi circa 7 micron con un
diametro compreso tra 0,5 e 1 micron. Sono dotati di una doppia membrana: la
membrana esterna è liscia, quella interna è organizzata in pieghe (creste)
che fanno aumentare la superficie utile e dividono lo spazio interno in
compartimenti. All'interno dei mitocondri si trovano enzimi, coenzimi, acqua, fosfati e molte
altre molecole necessarie per il processo di respirazione cellulare attraverso
il quale viene prodotta energia.
I mitocondri hanno il loro proprio DNA e sono dotati di ribosomi
e di RNA, fatto che consente loro di sintetizzare alcune proteine. Un'altra
caratteristica importante dei mitocondri degli animali superiori è che al momento
della riproduzione sessuata vengono trasmessi ai figli solo dalla madre.
Alcune caratteristiche dei mitocondri, come la possibilità di sintetizzare
proteine e la capacità di autoriprodursi, rendono
questi organuli estremamente interessanti per gli studi sull'evoluzione delle
cellule eucariote. Secondo alcuni ricercatori, tra i
quali la biologa Lynn Margulis,
i mitocondri sarebbero stati in origine dei batteri, che utilizzavano ossigeno
per la propria respirazione. Questi batteri sarebbero stati incorporati nel
citoplasma delle cellule eucariote di altri organismi
unicellulari e sarebbero passati a condurre una vita in stretta associazione
con questi organismi: in questo modo la cellula ospite avrebbe beneficiato
dell'energia prodotta dal batterio, mentre quest'ultimo, in cambio, avrebbe
potuto disporre di una fonte di sostanze nutritive. Con il tempo l'evoluzione
avrebbe reso sempre più stretto questo legame fino a trasformare i batteri in
organuli delle cellule eucariote.
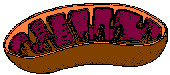
Organuli del sistema di membrane interne
Alcuni organuli collaborano tra loro in modi diversi; nel loro
insieme essi costituiscono il sistema di membrane interne o sistema endomembranoso. Alcuni di questi organuli sono connessi
direttamente uno all'altro, altri interagiscono per mezzo di vescicole che
trasportano materiali da un luogo all'altro all'interno della cellula. Le
strutture più importanti tra quelle che costituiscono questo sistema endomembranoso sono: il reticolo endoplasmatico,
la membrana nucleare esterna, il complesso del Golgi,
i lisosomi e i vacuoli.
Il reticolo endoplasmatico è una rete
complessa di cisterne appiattite e tubuli intercomunicanti nella quale vengono
costruite quasi tutte le macromolecole destinate sia all'interno che
all'esterno della cellula: le proteine di membrana, i lipidi del reticolo endoplasmatico stesso, del Golgi,
dei lisosomi e della membrana plasmatica.
Sempre in questa struttura vengono incanalate le sostanze che devono essere
trasportate nella cellula.
Nel reticolo endoplasmatico si distinguono due
porzioni: il reticolo endoplasmatico liscio, e il
reticolo endoplasmatico rugoso. Il reticolo endoplasmatico rugoso presenta la superficie esterna coperta
di ribosomi, che sono i siti in cui vengono
costruite le proteine.
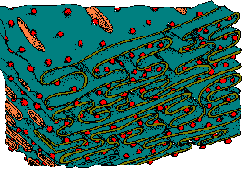
L'apparato del Golgi è una sede di transito e di elaborazione di molte sostanze; è composto da insiemi di cisterne rivestite da una membrana e disposte a formare una struttura che assomiglia a una pila di piatti. Questi insiemi vengono chiamati complessi del Golgi o dittiosomi.
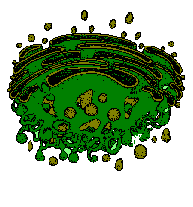
I lisosomi sono vescicole contenenti un'altissima concentrazione di enzimi digestivi. Questi organuli vengono prodotti dall'apparato del Golgi, dalle cui cisterne successivamente si distaccano, e svolgono fondamentalmente due diverse funzioni: la prima consiste nella digestione di materiali provenienti dall'esterno (eterofagia), la seconda è quella di digerire alcune porzioni della cellula stessa (autofagia). L'autofagia permette alle cellule di liberarsi di sostanze tossiche che, accumulandosi, potrebbero danneggiarla.
I vacuoli sono vescicole piene d'acqua contenente in soluzione sali e varie sostanze. La membrana che delimita ogni vacuolo, detta tonoplasto, è responsabile del "tono" o tensione cellulare nelle cellule vegetali. Attraverso questa membrana, infatti, il vacuolo assume o perde acqua modificando il turgore della cellula. Altri componenti del succo vacuolare sono amminoacidi, zuccheri, proteine, sostanze minerali o di riserva, prodotti di rifiuto. Il vacuolo contiene anche alcuni pigmenti, detti antocianine, responsabili dei colori blu, viola, rosso porpora o rosso scuro di fiori, frutti e steli: gli stessi pigmenti che si formano ogni anno in risposta al freddo, contemporaneamente alla degradazione della clorofilla, dando alle foglie la tipica colorazione autunnale.
Il vacuolo delle cellule vegetali è capace di inglobare e degradare organuli cellulari invecchiati come ribosomi, mitocondri o plastidi.
Perossisomi e ribosomi
I perossisomi o
microsomi sono organuli specializzati in
particolari reazioni di ossidazione. Questi organuli si trovano in abbondanza
nelle cellule del fegato (cellule epatiche), in quelle renali e in molti altri
tipi di cellule sia animali che vegetali. Il loro nome deriva dalle particolari
reazioni ossidative che si svolgono al loro interno:
le perossidazioni. Questo tipo di reazione è
particolarmente importante nelle cellule epatiche e renali, poiché contribuisce
a eliminare sostanze tossiche che entrano nel circolo sanguigno.
Sia le cellule eucariote che le cellule procariotie contengono ribosomi, piccoli corpi sferoidali formati da due parti più piccole, cioè da due subunità, entrambe di forma tondeggiante. Ciascuna subunità è formata da molecole di RNA associate a proteine. È a livello di questi organuli che avviene la sintesi delle proteine. Nelle cellule eucariote i ribosomi possono essere liberi nel citoplasmatica oppure aderire alle membrane del reticoloendoplasmatico. Nelle cellule eucariote si trovano ribosomi anche all'interno dei mitocondri e dei cloroplasti.
Il nucleo
Il nucleo delle cellule eucariote
è il compartimento in cui è racchiuso il materiale genetico depositario delle
informazioni che determinano la struttura della cellula, dirigono le sue
funzioni e le danno la possibilità di duplicarsi.
Il nucleo è delimitato da una membrana nucleare ed è costituito da una porzione
fluida, il nucleoplasma, in cui è dispersa la cromatina. Al suo interno si
trovano inoltre una o più zone maggiormente dense, i nucleoli.
Il nucleoplasma è una matrice gelatinosa contenente ioni, proteine, enzimi e nucleotidi.
La cromatina è la forma in cui appare il materiale genetico (DNA) quando la
cellula non è impegnata nella divisione cellulare. Nel momento in cui la
cellula deve riprodursi, cioè dividersi per dare luogo a due cellule figlie, la
cromatina subisce una spiralizzazione, cosicché il
materiale genetico appare in una forma diversa: i cromosomi, corpi di
forma bastoncellare intensamente colorati. Oltre al
DNA i cromosomi contengono molecole di proteine chiamate istoni.
I nucleoli sono piccoli corpi sferici che scompaiono quando ha inizio la
divisione cellulare; queste formazioni sono i siti in cui viene sintetizzato
l'RNA ribosomale.
Il nucleo ha forma, dimensioni, posizione e aspetto variabili nelle diverse
cellule in relazione al differenziamento delle funzioni e in una stessa cellula
nelle varie fasi del ciclo vitale. Tutte le cellule eucariote
ne sono provviste, con poche eccezioni, come quella rappresentata dai globuli
rossi dei mammiferi, e alcune ne contengono più di uno.
Particolarità delle cellule vegetali
Ogni cellula vegetale è delimitata da una parete
situata esternamente alla membrana plasmatica e
costituita essenzialmente da cellulosa. La parete cellulare costituisce una
protezione per la cellula, ne determina la forma ed è responsabile del suo
turgore. Il turgore delle cellule vegetali fa sì che le piante abbiano una
posizione eretta e che le foglie siano distese.
Le pareti cellulari costituiscono anche un sistema di canali entro cui circola
l'acqua con le varie sostanze in essa disciolte. Un altro componente importante
della parete è la lignina, molecola complessa, rigida, che si deposita
soprattutto nelle cellule con funzione di sostegno come quelle formano il legno.
Cutina, suberina e cere sono sostanze grasse e
impermeabili che si depositano sulle pareti delle cellule di rivestimento allo
scopo di limitare la perdita d'acqua da parte della pianta.
Le cellule vegetali contengono i plastidi, organuli
contenenti DNA e capaci di dividersi entro la cellula. In base alle funzioni
svolte si dividono in cloroplasti, cromoplasti e leucoplasti.
I cloroplasti sono la sede in cui avviene la fotosintesi, e hanno colore
verde perché, tra i vari pigmenti che contengono, prevale la clorofilla. Entro
ciascun cloroplasto alcune serie di membrane interne dette tilacoidi,
sono immerse in una sostanza incolore chiamata stroma. I tilacoidi, simili a sacchi appiattiti, sono disposti l'uno
sull'altro come monete formando pile che vengono chiamate grana. I grana
a loro volta sono collegati da connessioni chiamate intergrana. Nei
grana sono inglobate le molecole di clorofilla, che insieme ad altri pigmenti
come i carotenoidi svolgono un ruolo importante nella
fotosintesi.
I leucoplasti sono plastidi incolori perché privi di pigmenti. Hanno la
funzione di accumulare sostanze di riserva come amido, oli e proteine e sono
abbondanti in alcune parti della pianta come le radici, i bulbi o i tuberi.
I cromoplasti si trovano soprattutto nei fiori o nei frutti gialli, arancioni e rossi perché contengono i pigmenti così
colorati detti carotenoidi.
Comunicazione tra cellule
Le cellule devono comunicare tra loro per coordinare
le attività dei tessuti e degli organi e la comunicazione riguarda sia cellule
contigue che cellule tra loro distanti. La comunicazione tra cellule distanti
si realizza attraverso sostanze che fungono da messaggeri chimici; queste
sostanze vengono trasportate da una cellula all'altra e, una volta raggiunta la
cellula bersaglio, si legano a recettori presenti sulla superficie, oppure ne
attraversano la membrana, innescando modificazioni chimiche all'interno della
cellula.
Le cellule che si trovano a stretto contatto possono comunicare direttamente e scambiarsi materiali. Le cellule vegetali comunicano attraverso i plasmodesmi, canali che attraversano le pareti cellulari collegando il citoplasma di una cellula con quello delle cellule adiacenti.
Le cellule animali sono invece collegate da diverse strutture, tra cui le giunzioni comunicanti, aggregati proteici contenenti canali che permettono il transito di ioni e piccole molecole, come ATP e amminoacidi, da una cellula all'altra.
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025