|
|
| |
Leonardo da Vinci
Introduzione
L'epoca in cui vive Leonardo e' sicuramente tra le piu' stimolanti, tra le piu' ricche di fermenti innovativi e creativi. Dopo il rifiorire della cultura umanistica e la "rinascita" delle arti, l'uomo, ormai "centro del mondo", nel periodo compreso tra il 1450 e il 1550, allarga enormemente l'ambito delle proprie conoscenze: l'invenzione della stampa, insostituibile strumento di diffusione della cultura, la scoperta di nuovi mondi, di nuove civilta', sono solo alcune tappe di quell'irripetibile periodo della storia dell'umanita' in cui vanno intese e inquadrate la vita e l'opera di Leonardo da Vinci. La sua personalita' e' diventata quasi l'emblema della straordinaria sete di conoscenza, della sconfinata cur 828i88i iosita' dell'uomo verso tutti gli aspetti di una realta' da sempre in profondo ed inarrestabile mutamento. L'amore per la conoscenza e la ricerca segnarono profondamente la sua produzione artistica e scientifica. Le innovazioni che porto' nella pittura influenzarono l'arte italiana per oltre un secolo e i suoi studi scientifici, soprattutto di anatomia, ottica e idraulica, anticiparono molte conquiste della scienza moderna.
La vita
Il 15 aprile 1452 nasce a Vinci, presso Firenze, Leonardo, figlio naturale del notaio ser Piero Fruosino d'Antonio e di una tal Caterina. Leonardo cresce nella casa paterna. Nel 1469 si reca a Firenze con il padre.
Secondo Vasari, ser Piero presenta alcuni disegni del figlio all'amico Andrea del Verrocchio che, sorpreso dal precoce talento del giovane, lo prende nella sua bottega frequentata da Botticelli, Ghirlandaio, Perugino e Lorenzo di Credi. Leonardo lavora nella bottega del Verrocchio collaborando alla tavola col Battesimo di Cristo per la chiesa di San Salvi a Firenze; esegue inoltre dipinti, apparati per feste e tornei e un cartone per arazzo oggi distrutto.
Nel 1472 è iscritto alla Compagnia di San Luca dei pittori fiorentini. Probabilmente è in quest'anno che si accinge a dipingere la Madonna della melagrana (Madonna Dreyfus) terminata, presumibilmente, nel 1474. Realizza il suo primo disegno autografo "nel giorno di Santa Maria della neve", un Paesaggio della vallata dell'Arno, conservato agli Uffizi; tra il 1474 e il 1478 circa realizza la Madonna del garofano.
Riceve il primo incarico per un'opera pubblica nel 1478: la pala d'altare per la cappella di San Bernardo nel palazzo della Signoria, che non porterà a termine.
Molto probabilmente lavora per Lorenzo de'Medici nel giardino di San Marco dove esegue sculture per il Magnifico. In questo periodo inizia il San Girolamo penitente, terminato verso il 1482.
Con una lettera del 1482 offre i suoi servigi a Ludovico il Moro, descrivendo i suoi progetti di ponti militari, strumenti d'assedio, artiglierie, macchine per l'escavazione di cunicoli, carri protetti con artiglierie semoventi, navi militari, e solo in ultima istanza accenna ad opere d'idraulica, architettura, pittura e scultura, tra cui l'impresa del cavallo bronzeo per il monumento a Francesco Sforza.
Il 25 aprile del 1483 con Evangelista e Giovanni Ambrogio De Predis stipula con i frati dell'Immacolata Concezione il contratto per la Vergine delle rocce, una pala da collocare sull'altare della cappella della confraternita nella chiesa di San Francesco Grande a Milano.
In giugno si reca a Pavia dove esegue alcuni dei suoi più celebri ritratti: La dama con l'ermellino, Ritratto di donna (forse di Beatrice d'Este) e Ritratto di musico.
Nel 1495, a Milano, inizia l'Ultima cena nel refettorio di Santa Maria delle Grazie e i camerini del castello Sforzesco. Risalgono a questo periodo i progetti d'inondazione dei fossati del castello, gli studi per le macchine tessili e la teoria delle proporzioni. Viene anche menzionato come "ingegnere ducale". Termina probabilmente in questo periodo il ritratto di donna La Belle Ferronière. Il duca di Milano nel 1497 lo sollecita a portare a termine l'Ultima cena. A questo periodo risalgono appunti per composizioni allegoriche, per il bagno della duchessa e per una pala poi eseguita da Romanino in San Francesco a Brescia. Progetta i meccanismi per una sorta d'automa di guerriero. Continua gli studi d'idraulica e di meccanica.
Alla fuga di Ludovico il Moro, che lascia Milano conquistata dai francesi, anche Leonardo abbandona la città, recandosi a Firenze. Qui', per il convento dell'Annunziata, nel 1501, esegue il cartone di un San Giovannino, una piccola Madonna e il primo grande cartone per Sant'Anna, la Madonna, il Bambino e san Giovannino; probabilmente lavora anche alla Madonna dei fusi. Nel 1503 inizia la Gioconda per Giuliano de'Medici. In aprile ottiene, con Michelangelo, la commissione per la Battaglia d'Anghiari per il salone dei Cinquecento nel palazzo della Signoria.
Nel 1506 Charles d'Amboise, governatore francese di Milano, e lo stesso sovrano Luigi XII, richiedono con insistenza la sua presenza. Il 30 maggio Leonardo ottiene dalla repubblica fiorentina un permesso per allontanarsi dalla città per tre mesi. Porta a termine il dipinto con Sant'Anna, la Madonna, il Bambino e san Giovannino.
Il 24 settembre parte per Roma. Alloggia nel Vaticano, al Belvedere, protetto dal cardinale Giuliano de'Medici. Risale forse a questo periodo il San Giovanni Battista.
Francesco I lo invita in Francia. Leonardo alloggia nel castello di Cloux vicino Amboise. Gli è conferito il titolo di "premier peintre, architecte, et mecanicien du roi". Esegue i disegni del Diluvio, oggi al castello di Windsor. Muore al castello di Cloux il 2 maggio 1519.
Leonardo comprese l'importanza della sperimentazione scientifica meglio di ogni altro scienziato del suo secolo. Le sue teorie scientifiche, cosi' come le sue innovazioni artistiche, erano basate su una attenta osservazione dei fenomeni naturali. Purtroppo, come accadde spesso per i progetti artistici, molti suoi trattati scientifici non furono mai portati a termine. I suoi manoscritti constano di cinquemila pagine di appunti, quasi tutti leggibili soltanto allo specchio poiche' Leonardo, essendo mancino, scriveva alla rovescia, da destra verso sinistra.
Anticipando numerose scoperte dell'era moderna, Leonardo studio', nel campo dell'anatomia, la circolazione sanguigna e il movimento degli occhi; indago' profondamente i fenomeni meteorologici e geologici; studio' l'effetto della luna sulle maree; presagi' alcune concezioni moderne riguardo alla formazione dei continenti ed approfondi' lo studio delle origini dei fossili.
Fu anche uno degli iniziatori della scienza dell'idraulica progettando efficaci sistemi di canalizzazione dei fiumi e inventando macchine quali lo scafandro.
Per tutta la vita studio' e analizzo' il volo degli uccelli, tema trattato in numerosi disegni: le sue scoperte in proposito comprendono principi di aerodinamica tuttora validi.
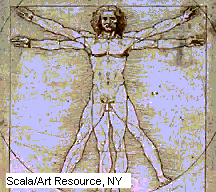 Disegno: Studio
anatomico del corpo umano
Disegno: Studio
anatomico del corpo umano
Le opere di Leonardo, molte delle quali rimaste incompiute, non sono numerose, ma per la loro straordinaria novita' hanno esercitato una grandissima influenza sulla pittura. Nei dipinti giovanili l'artista aderi' allo stile del Verrocchio, ma risenti' anche dell'influsso dell'arte fiamminga nella resa della luce e sviluppo' un interesse particolare per la rappresentazione della natura fino a concepire la pittura come una vera e propria scienza, utile per comprendere e raffigurare fedelmente i fenomeni naturali.
Leonardo fu tra i primi a usare la prospettiva aerea: la profondita'e la lontananza degli oggetti rappresentati vengono rese attraverso un sapiente uso del colore, in straordinari giochi di effetti atmosferici.
La Gioconda Il dipinto testimonia ancora oggi l'ideale leonardesco di grazia, e quanto questo si traducesse nella ricerca di un sottile gioco di accordi, di equilibri tonali, che fondono uomo e natura. Tanta attenzione per i particolari più minuti comporta inevitabilmente tempi lunghissimi d'esecuzione. Leonardo studia il ritratto per quattro anni, prima ancora di iniziarne la stesura. La Gioconda, o Monna Lisa come preferisce chiamarla il mondo anglosassone, riassume tutta una vita di studi. Per esempio, il paesaggio col ponte è probabilmente ripreso dalla Madonna dei fusi, quella con il paesaggio alpestre, mentre il particolare delle mani si riallaccia agli studi degli apostoli appoggiati alla tavola nel Cenacolo, in particolare l'efebico Giovanni. Sembra inoltre che l'artista avesse studiato anche una versione nuda del ritratto, la cosiddetta Monna Vanna. Non tutti concordano, già a partire dal Cinquecento, con l'identificazione del personaggio proposta da Vasari (Lisa Gherardini ) e c'è perfino chi dubita che il quadro visto ad Amboise nel 1517 sia quello oggi al Louvre, o avanza dubbi sulla sua datazione. Tuttavia il fatto che il braccio destro, e soprattutto la mano della Gioconda si ritrovino nella cosiddetta piccola Madonna Cowper di Raffaello, un quadro databile al 1504-1505, dimostra che a Firenze intorno a questi anni Leonardo stava già lavorando all'opera. Il ritratto potrebbe nascondere un messaggio simbolico, un riferimento alla virtù che sopravvive al ciclo eterno del tempo, all'inarrestabile trasmutazione della materia. Il paesaggio, denso di umori, magmatico e quasi irriconoscibile, è parte integrante del ritratto femminile. Il tutto condivide un moto intimo, permeato di vapori, aliti e palpiti: una pittura eseguita con una tecnica che non tradisce mai la meccanica del gesto o il segno del pennello. Solo velature liquide sottilissime, sovrapposte in anni di lavoro: quella "sottigliezza" che è a un tempo intellettuale e tecnica.
Nella realizzazione del ritratto Leonardo fece uso di due tecniche fondamentali della pittura, delle quali e' considerato il primo grande maestro: lo sfumato e il chiaroscuro. Lo sfumato consiste nel risolvere in modo quasi impercettibile i contorni delle figure, fondendo inoltre i colori in sottili gradazioni e ammorbidendo i passaggi dalle zone di luce a quelle d'ombra, creando cosi' un effetto di trasparenza che renda quasi evanescente il sorriso della donna ritratta. Il chiaroscuro consiste nel modellare e definire le forme per mezzo del contrasto luminoso; ad esempio, le mani sono raffigurate prevalentemente con una modulazione di luce ed ombra, senza contrasto di colore.
A Cura Di Donatella Gallori & Marta Daniotti
Classe V A
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025