|
|
| |
ESPERIENZA N° 6: CARICA E SCARICA DI UN CONDENSATORE: MISURA DELLA CAPACITA' DI UN CONDENSATORE.
OBIETTIVO:
Studio della capacità di un condensatore ed analisi della carica e scarica.
STRUMENTI :
N° 1 Basetta;
N°1 Commutatore, ovvero un interruttore con 3 posizioni possibili per inserire il generatore, eliminarlo e lasciarlo aperto;
N° 1 Generatore di forza elettromotrice e continua;
N° 1 Resistenza da 5.6 kW con tolleranza del 5%;
N° 1 Condensatore da 2.2 mF ± 20%;
N° 1 Condensatore da 1 mF± 20%;
N° 1 Cronometro digitale;
N° 1 Voltmetro digitale.
INTRODUZIONE TEORICA :
Sarà fondamentale nello studio dell'esperienza la conoscenza del circuito indicato in figura seguente:
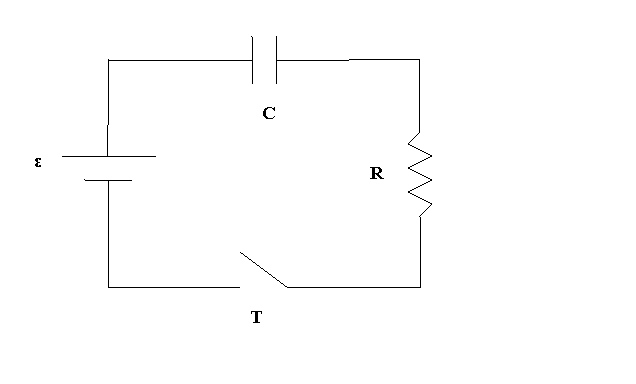
Esso è costituito da un generatore di forza elettromotrice, un condensatore ed una resistenza. Alla chiusura dell'interruttore (T in figura), il generatore inizia a prelevare cariche dall'armatura connessa al polo negativo per portarle all'armatura collegata al polo positivo in modo tale che sulle armature del condensatore compaiano le cariche +q e -q.
Il processo continua fino a quando la carica del condensatore raggiunge il valore massimo qo = C*e. In un generico istante t valgono le relazioni:
![]()
![]()
ove si è
posto:
![]()
![]()
Mettendo
insieme le relazioni appena scritte, otteniamo:
![]()
Integrando tra l'istante t= 0 e l'istante generico t in corrispondenza dei quali sulle armature del condensatore ha le cariche q= 0 e q, otteniamo:
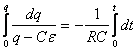
![]()
![]()
che porta, una
volta risolta, a:
Queste ultime due equazioni regolano la carica elettrica e la differenze di potenziale del condensatore con il tempo ed è evidente che entrambe le grandezze citate dipendono dalla costante di tempo t = RC.
Relativamente alle grandezze da misurare, in fase di carica conviene misurare la tensione ai capi del condensatore e poi calcolare quella ai capi della resistenza. Infatti poi sarà possibile linearizzare la curva rappresentando in scala semilogaritmica (t,VR) poiché:
![]()
Se in un determinato istante e dopo aver fatto caricare il condensatore (in parte o totalmente) si esclude il generatore, questo inizierà a perdere la carica posseduta che sarà dissipata nella resistenza.
![]()
![]()
Nell'istante generico
t la differenza di potenziale VC ai capi del condensatore è uguale a
quella VR ai capi della resistenza quindi valgono le relazioni:

e passando ad
integrare:
Risolvendo quest'ultimo integrale ottiene:
![]()
![]()
In fase di scarica conviene misurare la tensione ai capi del condensatore:
![]()
Infatti è possibile cambiando variabili linearizzare la curva rappresentandola in scala semilogaritmica (t,VC) poiché:
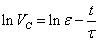
Dalle relazioni appena esposte si evince che la carica e la differenza di potenziale decrescono esponenzialmente nel tempo con una rapidità caratterizzata dalla costante di tempo t = RC.
PROCEDIMENTO :
Si è proceduto a realizzare il circuito indicato in figura seguente:
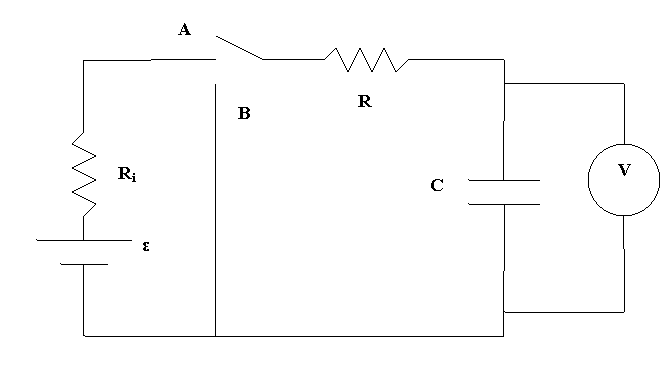
dotato di un commutatore al posto dell'interruttore in modo da potere studiare con lo stesso circuito sia la carica (posizione A) che la scarica (posizione B).
Quindi si è fissata la forza elettromotrice erogata dal generatore a circa 12 V e posizionato il commutatore in A si è fatto partire il cronometro annotando il valore del potenziale ai capi del condensatore ad ogni intervallo di tempo prescelto.
Si è fatto un certo numero di misure fino a quando si è notato che la differenza di potenziale ai capi del condensatore C, cambiava troppo lentamente.
A questo punto si è escluso il generatore, spostando il commutatore nella posizione B in modo da fare iniziare il processo di scarica, si è avviato il cronometro e si sono annotati i tempi in cui la differenza di potenziale subiva una variazione prescelta DV fino a quando la differenza di potenziale ha assunto un valore molto prossimo allo zero.
A questo punto si è utilizzato il metodo del confronto per determinare il valore della capacità incognita.
Il metodo del confronto consente di misurare CX facendolo scaricare attraverso la resistenza R e confrontando questo processo con quello di scarica di un condensatore noto C'. Nel processo di scarica di CX tra i valori di tensione di V1 e V2 esistono le seguenti relazioni:
![]() e
e ![]()
Ne deriva:

Dove Δt è l'intervallo di tempo in cui la tensione ai capi di CX passa da V1 a V2.
Passando ai logaritmi:
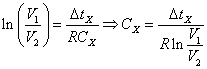
Ed analogamente per il condensatore C':

Si deve fare in modo che i valori di tensione tra cui si lascia scaricare i due condensatori siano gli stessi, ma purtroppo ciò è possibile entro gli errori di misura pertanto assumendo che:
![]()
Poiché C' è noto, misureremo gli intervalli temporali.
![]()
ANALISI DEI DATI :
Dai dati sperimentali, riportati nelle tabelle seguenti si sono ottenuti gli andamenti di carica e scarica dei condensatori che come si può ben vedere mostrano un andamento esponenziale (crescente nella carica e decrescente nella scarica).
Come è stato già detto valgono per la carica e per la scarica le due relazioni:
![]()
![]()
![]()
le quali
possono essere linearizzate passando ai logaritmi, ottenendo:
ponendo in questa:
x = t a = ln e y = ln (e-VC) b = 1 / (RC)
si ha y = a - bx, quindi noto b = 1 / (RC) e noto R si può trovare la capacità incognita C.
Per la seconda relazione si ottiene:
![]()
Ponendo in questa:
y = ln VC x = t a = ln V0 b = -1 / (RC)
con queste sostituzioni otteniamo una relazione lineare y = a + bx.
Rettificheremo la seconda relazione per non introdurre una nuova fonte di errore dovuta a e. Per applicare il metodo dei minimi quadrati si è supposto trascurabile l'errore sui tempi.
Il fondo scala del voltmetro era di 20 V e quindi l'errore commesso nelle misurazioni delle differenze di potenziale è di 0.01 V. Questo valore è stato portato a 0.05 V per tenere conto del tempo di reazione nel leggere il valore del tempo t sul cronometro digitale al potenziale Vt.
Si è sfruttato questo errore per calcolare quello sulla pendenza ed infine propagando l'errore relativo su pendenza e sulla R (tolleranza) si è trovato l'errore su C.
Tale errore è risultato di circa il 5% infatti C = 2.4 mF 0.12 mF.
Passando invece al metodo del confronto, i limiti di V sono stati Vmax= 10 V ed Vmin= 0.5 V. Questo metodo ha fornito per Cx = 2.2 mF 0.2 mF. Quest'ultimo errore si è ottenuto dalla somma in quadratura degli errori relativi su tx , t0 e C0.
Da una media pesata sui due valori risulta Cx 2.3 mF 0.1 mF.
|
Tempo t (sec) |
Differenza di potenziale VC (V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
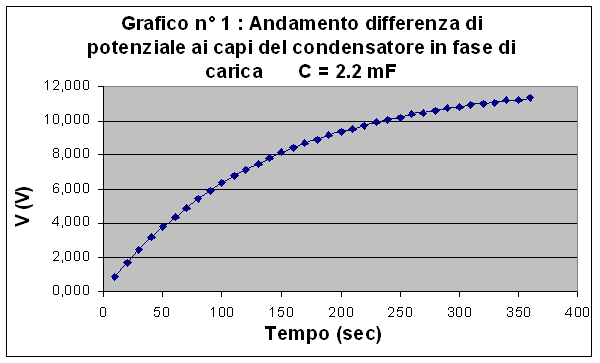
|
Tempo (sec) |
Differenza di potenziale VC (V) |
Ln VC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pendenza -0.00742 Errore su Pendenza 6.71e-05
Intercetta 2.27 Errore su Intercetta 0.01104
Coefficiente correlazione 0.9993
Resistenza 5600 W
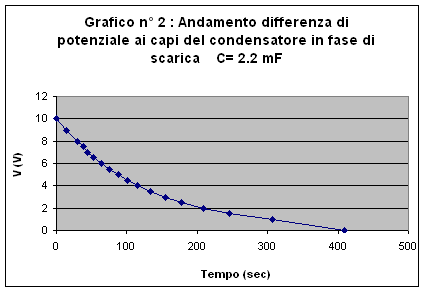
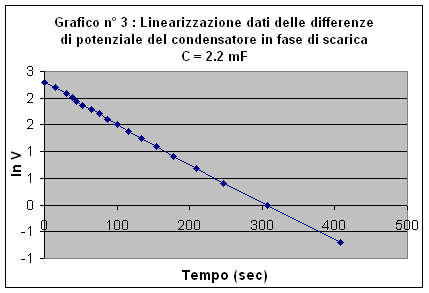
|
Tempo (sec) |
Differenza di potenziale VC (V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
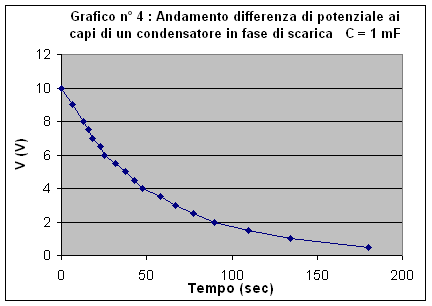
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025