|
|
| |
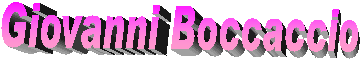
Giovanni Boccaccio nasce tra il giugno e il luglio del 1313, a Firenze, figlio illegittimo del ricco mercante, dipendente e poi socio del Banco dei Bardi, Boccaccino di Chellino. Leggendaria è la notizia della sua nascita a Parigi da una nobildonna di stirpe principesca.
Dopo aver ricevuto i fondamentali insegnamenti grammaticali e letterari, verso il 1327-'28 viene mandato dal padre a far pratica bancaria a Napoli, nella succursale dei Bardi: la compagnia fiorentina che insieme ai Peruzzi e agli Acciaiuoli detiene il monopolio delle imprese finanziarie del Regno di Roberto d'Angiò. Questo apprendistato mercantile e bancario si rivela un totale fallimento. Per sei anni non fa altro che sprecare tempo in un'attività per lui odiosa; sempre per volontà paterna ripiega sul diritto canonico, frequentando le lezioni di Cino da Pistoia (noto maestro di diritto e fam 444i86e oso rimatore stilnovista, amico di Dante e Petrarca), ma vi perde circa altri sei anni. Così finalmente abbandona gli studi ingrati, e da autodidatta, leggendo sia i classici sia la contemporanea produzione romanzesca cortese, si dedica interamente e avidamente alla poesia, a cui «un'antichissima disposizione dello spirito lo faceva tendere con tutte le sue forze».
La sua formazione intellettuale e umana si compie dunque nel più importante centro culturale italiano: lo Studio napoletano, la ricchissima biblioteca reale e la stessa raffinata corte angioina si configurano come punto d'incontro tra la cultura italo-francese e quella arabo-bizantina, attirando da ogni parte poeti, letterati, eruditi, scienziati e anche artisti come Giotto, che in quegli anni sta lavorando agli affreschi del Castel Nuovo. Questo vivace mondo culturale, l'aristocratica, elegante e gaia società della corte, gli svaghi, i diletti e gli amori di questi anni spensierati e felici si intravedono nella sua prima produzione letteraria, ispirata dall'amore per la leggendaria Maria dei conti D'Aquino, figlia illegittima del re Roberto d'Angiò: le Rime, la Caccia di Diana, il Filostrato, il Filocolo, il Teseida (terminato poi a Firenze).
Nel 1340-'41, in seguito al fallimento della Compagnia dei Bardi, richiamato dal padre torna a Firenze a una vita di ristrettezze economiche. Compone la Commedia delle Ninfe Fiorentine (1341-'42), l'Amorosa visione (1342), l'Elegia di madonna Fiammetta (1343-'44), piena di rimpianto per il mondo napoletano, ed infine il Ninfale fiesolano (1344-'46).
Soggiorna a Ravenna, alla corte di Ostasio da Polenta (1345-'46); e poi a Forlì, al seguito di Francesco degli Ordelaffi (1347-'48). Rientrato a Firenze, nel 1348 assiste agli orrori e alla tragedia della peste (durante la quale perde il padre), poi rievocata nell'opera che rappresenta il culmine della sua esperienza creativa, il Decameron (1349-'51).
Grazie alla sua fama letteraria riceve da parte del Comune di Firenze importanti e onorifici incarichi ufficiali, come le ambascerie in Romagna (1350), presso Ludovico di Baviera (1351), e presso i papi Innocenzo VI (1354) e Urbano V ad Avignone e a Roma (1365, 1367). Nel '50 è inviato a Ravenna per consegnare alla figlia di Dante, suor Beatrice, un simbolico risarcimento per l'esilio del padre. Nel '51 si reca a Padova dal Petrarca per restituirgli il patrimonio familiare confiscatogli dal Comune, e per offrirgli una cattedra del nuovo Studio.
Dopo la composizione del Decameron, inizia un periodo di ripiegamento spirituale e di vocazione meditativa. Boccaccio si dedica appassionatamente allo studio dei classici, scambiando testi antichi col Petrarca, a cui è inoltre legato da un'affettuosa amicizia. Diffonde in Italia e in Europa le più recenti e mirabili scoperte di codici e opere letterarie (Varrone, Marziale, Tacito, Apuleio, Ovidio, Seneca). Nel 1359 fa istituire presso lo Studio di Firenze la prima cattedra di greco, assegnandola a Leonzio Pilato, a cui commissiona anche la traduzione dei poemi omerici. Nell'ambito di questa ampia attività filologico-erudita di tipo umanistico si collocano i suoi repertori sulle divinità classiche (De genealogiis deorum gentilium), sulla geografia (De montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus, et de nominibus maris), sulle più illustri figure femminili (De claris mulieribus), e maschili (De casibus virorum illustrium).
Nel 1355 o nel 1365 compone il Corbaccio. Forti scrupoli morali lo portano a meditare persino la distruzione del Decameron , ma il Petrarca in una lettera del 1364 lo dissuade, invitandolo a riflettere sui valori spirituali dell'attività letteraria. Dopo aver ricevuto gli ordini minori, nel 1360 ottiene da papa Innocenzo VI l'autorizzazione ad aver cura di anime; e l'anno successivo, si ritira a Certaldo nella casa paterna, in cui crea con Filippo Villani, Luigi Marsili e Coluccio Salutati un centro di cultura umanistica.
Nel 1362, e poi ancora nel 1370, si reca a Napoli nella speranza di trovarvi una decorosa sistemazione, ma entrambe le volte torna a Certaldo deluso e amareggiato. Nel 1373 riceve l'incarico da parte del Comune di Firenze di commentare pubblicamente la Commedia di Dante nella chiesa di Santo Stefano di Badia, ma dopo pochi mesi, essendo sofferente di idropisia, è costretto a rinunciare alle sue pubbliche letture, interrompendole al canto XVII dell'Inferno.
Stanco, malato e angustiato dalle solite ristrettezze economiche, si ritira a Certaldo, dove muore il 21 dicembre 1375, un anno e mezzo dopo il suo amico Petrarca.
Vita e opere di Boccaccio
1313
Boccaccio nasce (nel mese di giugno o luglio) a Firenze da una donna d'
identità non accertata e da Boccaccino di Chellino, un agiato mercante che lo
riconosce senza esitazione.
1319-20
Boccaccino sposa la nobildonna Margherita de' Mardoli. Nasce Francesco,
fratellastro di Boccaccio.
1327
Boccaccio compie un viaggio a Napoli assieme al padre, agente del Banco dei
Bardi.
1330
Frequenta forse le lezioni di Cino da Pistoia, giurista, poeta e amico di Dante
e Petrarca, e intraprende gli studi di diritto canonico.
1332
Boccaccino si trasferisce a Parigi. Giovanni si dedica con più grande libertà
ai suoi interessi letterari, come è testimoniato dalle sue prime opere latine
(la Elegia di Costanza e la Allegoria mitologica, entrambe sicuramente composte
prima del 1334) e dalle sue prime prove in vernacolo.
1333-34
Primo contatto di Boccaccio con la poesia di Petrarca.
1334-37
Composizione della Caccia di Diana.
1336-39
Boccaccio termina il Filocolo. Nello stesso periodo termina i suoi studi.
1339
Giovanni compone le seguenti epistole latine: Crepor celsitudinis, dedicata a
Carlo, duca di Durazzo; Mavortis milex, dedicata a Petrarca; Nereus amphitribus
e Sacre famis, per amici ignoti.
1339-40
Composizione del Teseida.
1340
Porta a termine, fra l'autunno e l'inverno, il Filostrato (alcuni studiosi
anticipano la data al 1335 circa).
1340-41
Boccaccio ritorna a Firenze.
1341-42
Composizione della Comedia Ninfe (nota anche come Commedia delle ninfe
fiorentine e più tardi con il controverso titolo di Ninfale d'Ameto) dedicato a
Niccolò di Bartolo Del Buono. Primo abbozzo del De vita et moribus domini
Francisci Petracchi.
1342-43
Prima stesura dell'Amorosa visione.
1343-44
Composizione dell'Elegia di Madonna Fiammetta.
1344-45
Composizione del Ninfale fiesolano.
1347-48
Si reca a Forlì presso la corte di Francesco Ordelaffi. Boccaccio e il
grammatico Checco di Meletto Rossi si scambiano sonetti e carmina. In questo
periodo viene a conoscenza delle vicende che caratterizzano gli ultimi anni di
Dante. Compone le prime egloghe successivamente riunite sotto il titolo di
Buccolicum carmen.
1348
A Firenze si avvertono i primi effetti della peste nera, che causerà la morte
del padre, della matrigna e di numerosi amici di Boccaccio.
1349-51
Composizione del Decameron ...
1350
Primo incontro con Petrarca a Firenze. Comincia a lavorare alla Genealogia
deorum gentilium, opera che non terminerà fino al 1374.
1351
Boccaccio si traferisce a Padova dove incontra nuovamente Petrarca.
Rappresenta, con la carica di ambasciatore, il comune di Firenze presso la
corte di Luigi di Brandeburgo. Conclude il primo abbozzo del Trattatello in
laude di Dante.
1355
Boccaccio ritorna a Napoli. Quest'anno rappresenta il termine post quem della
seconda redazione della Amorosa visione che sarà definitivamente completata nel
1360. Comincia a lavorare al De casibus virorum illustrium e al De montibus,
silvis, fontibus et de nominibus maris liber conclusi rispettivamente nel 1363
e nel 1364.
1357
Boccaccio è a Ravenna, dove probabilmente riceve da Petrarca le Invective
contra medicum.
1359
Terzo incontro con Petrarca a Milano. Boccaccio viene nominato ambasciatore in
Lombardia, forse alla corte di Bernabò Visconti.
1360
Completa la prima stesura del De casibus e il primo compendio del Trattatello.
Papa Innocenzo VI gli attribuisce la facoltà di ottenere ufficio, prebenda o
cura d'anime. Dopo un tentativo di colpo di stato, a seguito del quale molti
suoi amici (tra cui Niccolò di Bartolo Del Buono) sono condannati a morte, Boccaccio
non riceve per i quattro anni successivi alcun incarico ufficiale.
1361
Boccaccio si ritira a Certaldo. Comincia a lavorare al De mulieribus claris.
1361-62
Ritorna, per ragioni non chiare, a Ravenna. Qui, per conto di Petrarca, che sta
lavorando al De vita solitaria, raccoglie informazioni su San Pier Damiani.
1362
Versione definitiva del De mulieribus. Compone la Vita sanctissimi patris Petri
Damiani.
1363
In seguito a una profonda crisi religiosa, Boccaccio si dedica esclusivamente
ad attività spirituali. Si reca nuovamente a Napoli, ma vi si trattiene
brevemente a causa della freddezza con cui viene accolto e ritorna a Firenze.
Va a Padova da Petrarca che incontra però a Venezia, dove nel frattempo questi
si è trasferito. A luglio Boccaccio torna a Certaldo e porta a compimento le
Genealogie.
1364-65
Boccaccio intrattiene un impegnativo dibattito epistolare con Petrarca sulle
composizioni in volgare.
1365
Si trasferisce alla corte papale di Urbano V ad Avignone come ambasciatore di
Firenze. Compone il Corbaccio. Si dedica al secondo compendio del Trattatello.
1367
Dopo un viaggio a Firenze si reca a Venezia dove incontra la figlia e il genero
di Petrarca. Assume l'incarico di ambasciatore a Roma.
1368
A Padova incontra Petrarca che attira attorno a sé numerosi letterati.
1369-70
Boccaccio presiede alla pubblicazione del Buccolicum carmen.
1370-71
Dopo un ultimo viaggio a Napoli, si rititra a Certaldo.
1372
Boccaccio è sempre più afflitto dall'obesità e da una forma di idropisia che
gli rende difficoltosi i movimenti; è anche tormentato dalla scabbia e da
attacchi di febbre.
1373
Dedica la versione definitiva del De casibus a Mainardo Cavalcanti. Prosegue la
revisione delle Genealogie. Boccaccio riceve dalla città di Firenze l'incarico
di fare letture pubbliche della Divina Commedia.
1374
In serie difficoltà economiche e di salute, ritorna a Certaldo dove viene a
conoscenza della morte di Petrarca. Il triste evento gli ispira l'ultimo
sonetto delle sue rime senili. Continua a lavorare alle Genealogie.
1375
Boccaccio muore il 21 dicembre nella sua casa di Certaldo.
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2026