|
|
| |
"La corrente neorealista
tra letteratura, cinema e storia"
I.T.C "Caio Plinio Secondo" Indirizzo Mercurio Multimediale
INDICE:
Pag. 4: il concetto generale di neorealismo
Pag. 5: Italo Calvino ed "I sentieri dei nidi di ragno"
Pag. 11: Il cinema neorealista
Pag.14: Il secondo dopoguerra Italiano
Pag. 20: La nascita della repubblica
Pag. 23: L'ordinamento inglese
IL NEOREALISMO:
"È la tendenza a rappresentare la realtà in modo realistico, con i suoi problemi e le sue ingiustizie. Questa tendenza nasce da un nuovo impegno che incomincia a manifestarsi già verso il 1930 come opposizione alla cultura fascista dominante e come superamento dei temi tipici del Decadentismo. In quegli anni infatti si sviluppa la concezione secondo la quale gli intellettuali devono assumersi delle responsabilità storiche e farsi portavoce dei bisogni del popolo. Per questo essi adottano un linguaggio semplice e diretto che spesso ricalca la lingua quotidiana. Gli anni di maggiore affermazione del neorealismo sono quelli che vanno dal 1943 al 1950: sono gli anni di resistenza contro il fascismo e il nazismo e gli anni del dopoguerra, durante i quali molti scrittori sono attivamente impegnati nella lotta partigiana prima e nel dibattito politico poi.I temi più frequenti nelle opere neorealistiche sono la lotta dei partigiani, le rivendicazioni degli operai e la rivolta dei contadini."
ITALO CALVINO:
"Nostro padre si sporse sul davanzale. -Quando sarai stanco di star lì cambierai idea!- gli gridò. -Non cambierò mai idea,- fece mio fratello, dal ramo. -Ti farò vedere io, appena scendi!- -E io non scenderò più!- E mantenne la parola." (Il barone rampante)
LA VITA:
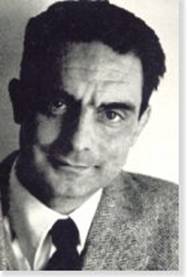 Italo Calvino nasce il
Italo Calvino nasce il
L'ESPERIENZA NEOREALISTA:
Il romanzo d'esordio di Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (1947), si colloca nell'ambito del Neorealismo. Affrontando l'argomento della lotta partigiana, sulla base di un'esperienza vissuta in prima persona, lo scrittore trasferisce sulla pagina il clima di fervore degli anni postbellici, il bisogno di dare voce ad una vicenda collettiva che viene sentita come decisiva e che alimenta speranze in un cambiamento profondo della vita nazionale e nella costituzione di un'Italia più civile e più giusta. Tuttavia Calvino non vuol offrire un quadro celebrativo ed agiografico della Resistenza, come egli stesso precisa un'illuminante prefazione aggiunta al libro nel 1964: la banda partigiana che egli rappresenta è costituita dagli scarti di tutte le altre formazioni, da una serie di emarginati, di balordi, di "picari". Con questo però, in polemica con i detrattori della Resistenza, egli intende dimostrare che anche chi si era impegnato nella lotta senza chiare motivazioni ideali sentiva "un'elementare spinta di riscatto umano" e s trasformava così in forza storica attiva. Si manifesta in tal modo quell'indipendenza intellettuale che contraddistinguerà poi sempre la posizione di Calvino, il suo rifiuto di sottostare ad una direzione "politica" della cultura, di ridurre la letteratura a celebrazione, a propaganda o a pedagogia, secondo normative imposte dall'esterno. Ciò che allontana Calvino dagli standard neorealistici è ancora il fatto, pur rappresentando figure e ambienti proletari e sottoproletari, il suo libro non rivela alcun intento documentario di tipo naturalistico. Anzi, la vicenda della lotta partigiana è trasferita in un clima fantastico, di fiaba. L'effetto è ottenuto presentando tutti gli eventi attraverso il punto di vista di un bambino. Nel Sentiero appaiono così in germe le due direzioni che Calvino seguirà nel suo percorso letterario degli anni successivi: il realismo e la dimensione fantastica. Nel clima neorealistico, sia pur trascritto in chiave fiabesca, si inseriscono ancora i racconti di Ultimo viene il corvo (1949). La guerra partigiana vi conserva un posto importante, tuttavia rispetto al Sentiero la fiducia nella storia appare incrinata ed affiorano inquietudini nuove: progressivamente si fa strada il timore che il sacrificio della lotta sia stato inutile e la vittoria possa essere vanificata. Si chiude qui il periodo neorealista dello scrittore da questo momento in poi Calvino sceglierà di puntare decisamente solo sulla componente fantastica della sua ispirazione.
"IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO" (1947)
" ...Fu Pavese il primo a parlare in tono fiabesco a mio proposito, e io, che fino ad allora non me ne ero reso conto, da quel momento in poi lo seppi fin troppo, e cercai di confermare la definizione..."
Italo Calvino (prefazione edizione 1964)
Testo:
"Ha fame. Di quest'epoca sono mature le ciliege. Ecco un albero,
distante da ogni casa: che sia sorto lì per incantesimo? Pin si arrampica tra i
rami e comincia a sfondarli con diligenza. Un grosso uccello gli piglia il volo
quasi tra le mani: era lì che dormiva. Pin si sente amico di tutti, in quel
momento, e vorrebbe non averlo disturbato. Quando sente che la fame s'è un po'
chetata si riempie di ciliege le tasche e scende, e riprende la strada sputando
noccioli. Poi pensa che i fascisti possono seguire la scia dei noccioli di
ciliegia e raggiungerlo. Ma nessuno può essere così furbo da pensare quello,
nessuno tranne una persona al mondo: Lupo Rosso! Ecco: se Pin lascerà una scia
di noccioli di ciliegia Lupo Rosso riuscirà a trovarlo, dovunque sia! Basta
lasciar cadere un nocciolo ogni venti passi. Ecco: girato in quel muretto, Pin
mangerà una ciliegia, poi un'altra, da quel vecchio frantoio, un'altra passato
l'albero di nespolo: così via fino ad arrivare al sentiero delle tane di ragno.
Ma ancora non ha raggiunto il 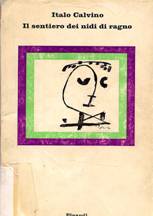 fossato che già le ciliegie sono finite:
Pin allora che Lupo Rosso non lo ritroverà mai più. Pin cammina nel letto del
fossato quasi secco, fra grandi sassi bianchi e il frusciare cartaceo delle
canne. In fondo alle pozze dormono le anguille, lunghe quanto un braccio umano,
che a togliere l'acqua si possono acchiappare con le mani. Alla foce del
torrente nella città vecchia chiusa come un pigna, dormono gli uomini ubriachi
e le donne sazie d'amore. La sorella di Pin dorme sola o in compagnia e s'è già
dimenticata di lui, non pensa né se è vivo né se è morto. Sulla paglia della
sua cella unico veglia il suo padrone Pietromagro, vicino a morire, col sangue
che diventa giallo di piscio nelle vene. Pin è arrivato ai propri posti: ecco
il buedo, ecco la scorciatoia con i nidi. Riconosce le pietre, guarda se la
terra è stata mossa: no, nulla è stato toccato. Scava con le unghie, con ansia un po' voluta: a toccare la fondina ha un
senso di commozione dolce, come da un piccola a un giocattolo sotto il
guanciale. Estrae la pistola e passa il dito sugli incavi per togliere la
terra. Dalla canna, svelto svelto, esce
un ragnetto: era andato a farsi il nido dentro. E' bella la sua pistola : è
l'unica cosa che resti al mondo a Pin. Pin impugna la pistola e immagina essere
Lupo Rosso, cerca di pensare a cosa farebbe Lupo Rosso se avesse quella pistola
in mano. Ma questo gli ricorda che è solo, che non può cercar aiuto da nessuno,
né da quelli dell'osteria così ambigui e incomprensibili, né da sua sorella
traditrice, né da Pietromagro carcerato. [. ]"
fossato che già le ciliegie sono finite:
Pin allora che Lupo Rosso non lo ritroverà mai più. Pin cammina nel letto del
fossato quasi secco, fra grandi sassi bianchi e il frusciare cartaceo delle
canne. In fondo alle pozze dormono le anguille, lunghe quanto un braccio umano,
che a togliere l'acqua si possono acchiappare con le mani. Alla foce del
torrente nella città vecchia chiusa come un pigna, dormono gli uomini ubriachi
e le donne sazie d'amore. La sorella di Pin dorme sola o in compagnia e s'è già
dimenticata di lui, non pensa né se è vivo né se è morto. Sulla paglia della
sua cella unico veglia il suo padrone Pietromagro, vicino a morire, col sangue
che diventa giallo di piscio nelle vene. Pin è arrivato ai propri posti: ecco
il buedo, ecco la scorciatoia con i nidi. Riconosce le pietre, guarda se la
terra è stata mossa: no, nulla è stato toccato. Scava con le unghie, con ansia un po' voluta: a toccare la fondina ha un
senso di commozione dolce, come da un piccola a un giocattolo sotto il
guanciale. Estrae la pistola e passa il dito sugli incavi per togliere la
terra. Dalla canna, svelto svelto, esce
un ragnetto: era andato a farsi il nido dentro. E' bella la sua pistola : è
l'unica cosa che resti al mondo a Pin. Pin impugna la pistola e immagina essere
Lupo Rosso, cerca di pensare a cosa farebbe Lupo Rosso se avesse quella pistola
in mano. Ma questo gli ricorda che è solo, che non può cercar aiuto da nessuno,
né da quelli dell'osteria così ambigui e incomprensibili, né da sua sorella
traditrice, né da Pietromagro carcerato. [. ]"
"Più che come un'opera mia lo leggo come un libro nato anonimamente dal clima generale d'un'epoca, da una tensione morale, da un gusto letterario che era quello in cui la nostra generazione si riconosceva, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'esplosione letteraria di quegli anni in Italia fu, prima che un fatto d'arte, un fatto fisiologico, esistenziale, collettivo. Avevamo vissuto la guerra, e noi più giovani - che avevamo fatto appena in tempo a fare il partigiano - non ce ne sentivamo schiacciati, vinti, «bruciati», ma vincitori, spinti dalla carica propulsiva della battaglia appena conclusa, depositari esclusivi d'una sua eredità. Non era facile ottimismo, però, o gratuita euforia; tutt'altro: quello di cui ci sentivamo depositari era un senso della vita come qualcosa che può ricominciare da zero, un rovello problematico generale, anche una nostra capacità di vivere lo strazio e lo sbaraglio; ma l'accento che vi mettevamo era quello d'una spavalda allegria. Molte cose nacquero da quel clima, e anche il piglio dei miei primi racconti e del primo romanzo." Italo Calvino (Postfazione prima edizione)
Commento:
Calvino scrisse Il sentiero dei nidi di ragno nel 1946, giovane scrittore alle prime armi, fresco di Resistenza, portato inaspettatamente al successo da quella che lui stesso avrebbe definito «l'esplosione letteraria» del secondo dopoguerra: «prima che un fatto d'arte, un fatto fisiologico, esistenziale, collettivo», la pulsione irrefrenabile a dire, a raccontare a illustrare gli anni della lotta silenziosa, della paura, della morte e anche del disinganno. Una pulsione tanto forte da sopraffare anche la volontà artistica dei singoli autori, il loro stile, il timbro, le scelte narrative, tanto che ciò che rimane di quegli anni è soprattutto «la voce anonima dell'epoca, più forte delle nostre inflessioni individuali ancora incerte», perché «la carica esplosiva di libertà che animava il giovane scrittore non era tanto nella sua volontà di documentare e informare, quanto in quelle di esprimere» (dalla Prefazione all'edizione 1964 de Il sentiero dei nidi di ragno). Il prorompente prevalere della vita sull'arte, insomma. Ma sarà davvero così? Nel Sentiero, troviamo il neorealismo, che non fu una scuola ma «un insieme di voci periferiche», il modello dei Malavoglia, seguito, ma nello stesso tempo tenuto a distanza, perché quel nuovo realismo, sgorgato dalle ferite della storia insieme al sangue e alle lacrime, doveva essere «il più possibile distante dal naturalismo». E poi il problema, così peculiarmente italiano, di scegliere una lingua per parlare a tutti ma senza perdere il ricco tesoro espressivo dei dialetti; e ancora l'America, sogno lontano, lontano baluginio di un mondo desiderato e insieme temuto, perché ancora in gran parte ignoto. Qualcosa in più, che rende Il sentiero dei nidi di ragno un romanzo particolare, quasi unico nella tradizione letteraria italiana. È lo sguardo dal basso: la guerra è raccontata attraverso lo sguardo trasognato e dispettoso di un bambino, che vede il mondo con l'asciutta chiarezza di una macchina fotografica, non per una raggiunta consapevolezza di stile, ma perché non possiede ancora gli strumenti etici con cui gli adulti distinguono il bene dal male (scegliendo poi, quasi sempre, la seconda alternativa). Calvino si è volontariamente scelta una posizione minore, secondaria, da cui osservare di scorcio i movimenti tumultuosi e a volte incomprensibili della Storia Grande: lo scrittore dà voce ad un protagonista che rappresenta, come lui stesso dice, «un'immagine di regressione». Ma quello che rimane dalla lettura del Sentiero non è il complesso d'inferiorità del borghese Calvino dinanzi alla durezza di una scelta storica che non ammette incertezze: l'infanzia agra e selvaggia di Pin va oltre il valore puramente metaforico. Nella letteratura italiana la storia non era mai stata filtrata dallo sguardo spietato ed indifeso di un bambino, ed è qui, piuttosto che in una vaga simbologia sociale, che troviamo il valore più profondo del romanzo.
Pin osserva dal suo mondo fiabesco di «bambino vecchio» le esistenze misteriose e ingarbugliate dei grandi: e a volte sono gli amplessi animaleschi della sorella, che Pin spia con «occhi come punte di spillo» dal ripostiglio stretto e scuro che è la sua camera, a volte sono parole oscure e affascinanti alle quali il bambino attribuisce significati favolosi, a volte è l'umanità storta e rabberciata del distaccamento del Dritto. E tutto questo è la Storia, ma Pin non lo sa, non sa ancora cosa sia la storia, quest'oggetto incomprensibile che nei suoi sogni di bambino prende la forma di una pistola, una P38 rubata ad un ufficiale tedesco, uno degli amanti di sua sorella. La pistola diventa allora l'oggetto magico delle favole, è l'anello che rende invisibili, è l'Olifante di Orlando, la bacchetta magica che permette a Pin di entrare nel mondo favoloso dei grandi. Pin è un personaggio di confine, sospeso tra un'infanzia che non gli è mai appartenuta e un mondo adulto ancora lontano ed estraneo, ma che tuttavia lo attrae, perché sente che lì forse potrà avere un'occasione di riscatto, potrà trovare l'Amico, il compagno, l'anima con cui condividere il castello di sogni e segreti su cui poggia la sua piccola vita di picaro senza affetti. In questa sua ricerca sconclusionata, senza guide e senza direzioni preordinate, Pin diventa a volte un inconsapevole moralista: guarda gli adulti con i suoi occhi vuoti di esperienza, e da questa osservazione sa trarre una saggezza tutta sua, che lo rende ancora più solo, ancora più in bilico tra desiderio, rabbia e paura.
IL CINEMA NEOREALISTA:
CARATTERISTICHE:
 Il movimento
noto come neorealismo fa la propria comparsa in Italia intorno alla seconda
guerra mondiale: sua principale caratteristica è quella di rappresentare la
quotidianità nel suo farsi, adottando un taglio tra il reale ed il documentario
e servendosi sovente di individui presi dalla strada in luogo di attori
professionisti. La scarsità di mezzi, la indisponibilità di teatri di posa dopo
il 1944 crea l'obbligo di girare nelle strade, di ambientare i lungometraggi
nei luoghi autentici: ciò diviene una sorta di cifra stilistica del
neorealismo, che attinge una inusuale misura di verità da codeste apparenti
limitazioni. Altri tratti salienti sono rinvenibili in uno spostamento
d'accento dal singolo alla collettività, nella palese predilezione per una
narrazione di tipo corale; ultima, ma non per importanza, è la valenza di
lucida analisi dei dolorosi scenari evocati, di aperta critica verso la
crudeltà o l'indifferenza dell'autorità costituita. L'accezione di
"nuovo" realismo si origina dalla necessità di sottolineare il
carattere invero inedito della corrente: ché mere connotazioni realistiche
avevano già talune pellicole nostrane nel periodo del muto -
Il movimento
noto come neorealismo fa la propria comparsa in Italia intorno alla seconda
guerra mondiale: sua principale caratteristica è quella di rappresentare la
quotidianità nel suo farsi, adottando un taglio tra il reale ed il documentario
e servendosi sovente di individui presi dalla strada in luogo di attori
professionisti. La scarsità di mezzi, la indisponibilità di teatri di posa dopo
il 1944 crea l'obbligo di girare nelle strade, di ambientare i lungometraggi
nei luoghi autentici: ciò diviene una sorta di cifra stilistica del
neorealismo, che attinge una inusuale misura di verità da codeste apparenti
limitazioni. Altri tratti salienti sono rinvenibili in uno spostamento
d'accento dal singolo alla collettività, nella palese predilezione per una
narrazione di tipo corale; ultima, ma non per importanza, è la valenza di
lucida analisi dei dolorosi scenari evocati, di aperta critica verso la
crudeltà o l'indifferenza dell'autorità costituita. L'accezione di
"nuovo" realismo si origina dalla necessità di sottolineare il
carattere invero inedito della corrente: ché mere connotazioni realistiche
avevano già talune pellicole nostrane nel periodo del muto -
Se l'elaborazione teorica del movimento trova nelle riviste "Cinema"
(e "Bianco e nero") insperati luoghi d'elezione, i segnali d'un
mutamento imminente si coagulano di contro in titoli quali "Quattro passi
fra le nuvole" (1942) di Alessandro Blasetti e "I bambini ci
guardano" (1943) di Vittorio De Sica. Una ragazza madre, una moglie adultera, un
marito suicida ne sono protagonisti, dissolvendo la plumbea, forzosa cappa di
decoro e di perbenismo propria della cinematografia del ventennio. A rompere
ancor più recisamente gli indugi, ci pensa Luchino Visconti con
"Ossessione" (1943), torrida trasposizione sulle rive del Po de
"Il postino suona sempre due volte" di James M.Cain: irrompe qui,
finalmente, sugli schermi, un'Italia vera, abitata dalla miseria e dalla
disoccupazione, vessata da una polizia occhiuta e persecutoria. Passione,
tradimento, morte scandiscono una storia raccontata senza timori: la censura
s'impenna ancora una volta, ed il film conosce - segnatamente nell'Italia
del nord - problemi di circolazione. Ma la strada per una svolta epocale,
oramai, è stata aperta.
OPERE E AUTORI:
 L'atto di
nascita ufficiale del neorealismo può dirsi costituito dall'uscita di
"Roma città aperta", girato in condizioni di fortuna (ad esempio,
servendosi di pellicola muta e sovente scaduta) tra il '44 e il '45 da Roberto
Rossellini. L'esperienza dolorosa della guerra, il trauma dell'occupazione,
l'afflato resistenziale trovano qui efficace rappresentazione, pur se a volte
in chiave populistico-melodrammatica: l'impatto è comunque enorme, e apre la
strada a tutte le grandi opere del triennio successivo. In "Sciuscià"
(1946), Vittorio De Sica indaga i disastri provocati dall'esperienza bellica
nell'animo dei più deboli, i fanciulli del proletariato; in "Paisà"
(1946), ancora Rossellini dà vita - in sei episodi di guerra e di resistenza -
ad una sorta di affresco stilisticamente nervoso e frammentato sull'Italia
sconvolta del '44; Dipoi, mentre Rossellini esce dai confini patri per
raccontare in "Germania anno zero" (1947) la deriva morale di un
paese che si esplicita nel suicidio di un bimbo, De Sica offre con "Ladri
di biciclette" (1948) - attraverso le peripezie d'un uomo qualunque, che
non si rassegna alla disoccupazione forzosa - l'attendibile ritratto d'una
nazione sospesa fra speranze e frustrazioni; laddove Visconti rilegge con
maestria ed aggiorna in chiave marxista "I Malavoglia" del Verga nel
mirabile "La terra trema" (1948) e De Santis persegue con il
celeberrimo "Riso amaro" (1949) una sua personale via al cinema
popolar-realistico, portando alle conseguenze ultime certe intuizioni
gramsciane nel mescolare valenze sociali e gusto del melò, istanze progressiste
ed esplosiva carnalità. Frattanto, la Storia fa il suo corso: le elezioni del
'48 segnano la netta sconfitta delle sinistre, ricacciate all'opposizione dopo
la parentesi post-resistenziale. Il clima culturale, di conserva, prende a
mutare: inizia così il lento, ma inesorabile declino dell'esperienza
neorealistica, che produrrà ancora un'estrema fioritura prima di avvizzire.
L'atto di
nascita ufficiale del neorealismo può dirsi costituito dall'uscita di
"Roma città aperta", girato in condizioni di fortuna (ad esempio,
servendosi di pellicola muta e sovente scaduta) tra il '44 e il '45 da Roberto
Rossellini. L'esperienza dolorosa della guerra, il trauma dell'occupazione,
l'afflato resistenziale trovano qui efficace rappresentazione, pur se a volte
in chiave populistico-melodrammatica: l'impatto è comunque enorme, e apre la
strada a tutte le grandi opere del triennio successivo. In "Sciuscià"
(1946), Vittorio De Sica indaga i disastri provocati dall'esperienza bellica
nell'animo dei più deboli, i fanciulli del proletariato; in "Paisà"
(1946), ancora Rossellini dà vita - in sei episodi di guerra e di resistenza -
ad una sorta di affresco stilisticamente nervoso e frammentato sull'Italia
sconvolta del '44; Dipoi, mentre Rossellini esce dai confini patri per
raccontare in "Germania anno zero" (1947) la deriva morale di un
paese che si esplicita nel suicidio di un bimbo, De Sica offre con "Ladri
di biciclette" (1948) - attraverso le peripezie d'un uomo qualunque, che
non si rassegna alla disoccupazione forzosa - l'attendibile ritratto d'una
nazione sospesa fra speranze e frustrazioni; laddove Visconti rilegge con
maestria ed aggiorna in chiave marxista "I Malavoglia" del Verga nel
mirabile "La terra trema" (1948) e De Santis persegue con il
celeberrimo "Riso amaro" (1949) una sua personale via al cinema
popolar-realistico, portando alle conseguenze ultime certe intuizioni
gramsciane nel mescolare valenze sociali e gusto del melò, istanze progressiste
ed esplosiva carnalità. Frattanto, la Storia fa il suo corso: le elezioni del
'48 segnano la netta sconfitta delle sinistre, ricacciate all'opposizione dopo
la parentesi post-resistenziale. Il clima culturale, di conserva, prende a
mutare: inizia così il lento, ma inesorabile declino dell'esperienza
neorealistica, che produrrà ancora un'estrema fioritura prima di avvizzire.
ULTIMI FUOCHI:
Instauratosi un governo moderato di impronta filostatunitense, la rottura della solidarietà postbellica diviene definitiva: mentre il grande capitale torna ad affermarsi, venti di conservazione spirano vigorosi sul paese. La politica culturale tende verso un ottimismo di facciata, l'esposizione dei dolori e delle miserie d'un popolo vinto inizia ad esser vista con fastidio dal potere. Lo scopre a suo spese Vittorio De Sica che - già al centro di polemiche per le sue opere - viene attaccato per il magnifico "Umberto D." (1952), lucida e rigorosa descrizione della miserrima solitudine d'un pensionato: l'accusa è quella di presentare un quadro troppo impietoso della vita quotidiana, s'invoca a gran voce un raggio di sole da parte di giovani politici democristiani destinati a fare carriera.
Alla fine della
seconda guerra mondiale, l'Italia è un paese profondamente ferito dai
bombardamenti anglo-americani e dalle distruzioni lasciate dai nazisti, stanco,
sfiduciato, senza prospettive  precise, incerto addirittura sulla sua stessa unità. L'economia è prostrata; la società è sostanzialmente la stessa di inizio
secolo: agricola, arretrata e provinciale; la presenza di un fortissimo partito
comunista rende incerta la posizione stessa dell'Italia sullo scacchiere
internazionale. Negli ultimi mesi di guerra e nel periodo immediatamente
successivo alla Liberazione, i Governi che si succedettero furono condotti con
la partecipazione unitaria e con la collaborazione di tutti i partiti antifascisti, e, in particolare,
dei tre grandi partiti di massa: la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista
e il Partito Socialista. Ma gli sviluppi della situazione politica
internazionale ben presto ebbero un effetto dirompente anche sulle condizioni
politiche italiane. La fine del secondo conflitto mondiale sancì anche la fine
dell'egemonia delle potenze europee nel mondo; Stati Uniti e Unione Sovietica,
fino a quel momento alleati contro il nazifascismo, in quanto principali
vincitori della guerra, emersero come i nuovi protagonisti dei futuri scenari
politici internazionali. Già prima della fine del conflitto, nella conferenza
di Yalta, Stalin, Roosvelt e Churchill definirono la politica da seguire dopo
la resa della Germania, dividendosi, nel mondo, le aree di rispettivo controllo
e alleanza, che sarebbero state condizionate dai relativi sistemi politico
economici. L'equilibrio internazionale che ne risultò e che caratterizzò la
storia mondiale per oltre quarant'anni, era basato sulla contrapposizione
bipolare di USA e URSS, ormai superpotenze, e delle rispettive aree di influenza.
Da una parte i sistemi politici occidentali basati su un'economia di mercato,
dall'altra i sistemi politici comunisti a economia pianificata dallo Stato.
L'originaria alleanza contro il nazifascismo ben presto si ruppe e il
deterioramento dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica sfociò in
un'epoca di contrapposizione frontale e di gravissime tensioni, nella ricerca
della superiorità militare con una folle corsa agli armamenti, in un equilibrio
del terrore che rischiò di trascinare il mondo in un ultimo tremendo conflitto.
Fu la guerra fredda. La partecipazione delle truppe alleate anglo-americane al
processo di liberazione dell'Italia dal nazifascismo determinò la collocazione
del Paese nella sfera occidentale di influenza statunitense, sanzionata
successivamente, nel 1949, con l'adesione al Patto Atlantico. Nel corso del
1947, ancor prima delle elezioni politiche del
precise, incerto addirittura sulla sua stessa unità. L'economia è prostrata; la società è sostanzialmente la stessa di inizio
secolo: agricola, arretrata e provinciale; la presenza di un fortissimo partito
comunista rende incerta la posizione stessa dell'Italia sullo scacchiere
internazionale. Negli ultimi mesi di guerra e nel periodo immediatamente
successivo alla Liberazione, i Governi che si succedettero furono condotti con
la partecipazione unitaria e con la collaborazione di tutti i partiti antifascisti, e, in particolare,
dei tre grandi partiti di massa: la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista
e il Partito Socialista. Ma gli sviluppi della situazione politica
internazionale ben presto ebbero un effetto dirompente anche sulle condizioni
politiche italiane. La fine del secondo conflitto mondiale sancì anche la fine
dell'egemonia delle potenze europee nel mondo; Stati Uniti e Unione Sovietica,
fino a quel momento alleati contro il nazifascismo, in quanto principali
vincitori della guerra, emersero come i nuovi protagonisti dei futuri scenari
politici internazionali. Già prima della fine del conflitto, nella conferenza
di Yalta, Stalin, Roosvelt e Churchill definirono la politica da seguire dopo
la resa della Germania, dividendosi, nel mondo, le aree di rispettivo controllo
e alleanza, che sarebbero state condizionate dai relativi sistemi politico
economici. L'equilibrio internazionale che ne risultò e che caratterizzò la
storia mondiale per oltre quarant'anni, era basato sulla contrapposizione
bipolare di USA e URSS, ormai superpotenze, e delle rispettive aree di influenza.
Da una parte i sistemi politici occidentali basati su un'economia di mercato,
dall'altra i sistemi politici comunisti a economia pianificata dallo Stato.
L'originaria alleanza contro il nazifascismo ben presto si ruppe e il
deterioramento dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica sfociò in
un'epoca di contrapposizione frontale e di gravissime tensioni, nella ricerca
della superiorità militare con una folle corsa agli armamenti, in un equilibrio
del terrore che rischiò di trascinare il mondo in un ultimo tremendo conflitto.
Fu la guerra fredda. La partecipazione delle truppe alleate anglo-americane al
processo di liberazione dell'Italia dal nazifascismo determinò la collocazione
del Paese nella sfera occidentale di influenza statunitense, sanzionata
successivamente, nel 1949, con l'adesione al Patto Atlantico. Nel corso del
1947, ancor prima delle elezioni politiche del  democristiano, accondiscendendo alle sempre
più insistenti pressioni politiche statunitensi, provocò, con un pretesto, una
crisi di Governo che sfociò nella costituzione di un nuovo Ministero dal quale
vennero esclusi i socialisti e i comunisti, responsabili di mantenere legami
politici con l'Unione Sovietica, appartenente al blocco politico militare
contrapposto. Le elezioni politiche del 18 aprile, le prime dell'Italia
democratica, si tennero in un clima di feroce ostilità, con da una parte la
Democrazia Cristiana e dall'altra il Fronte Popolare che riuniva socialisti e
comunisti. La prima impostò, come spesso fece anche in seguito, la campagna
elettorale nei termini di un'alternativa secca tra libertà e dittatura
comunista, nonostante il PCI e il PSI avessero dato un evidente e fondamentale
contributo alla lotta di Liberazione e alla stesura della Costituzione,
dimostrando di accettare il metodo democratico nella lotta politica. La DC ebbe
inoltre il massiccio appoggio delle gerarchie ecclesiastiche che ricorsero pure
alla minaccia della scomunica nei confronti degli appartenenti ai partiti di
matrice marxista. Il suo simbolo era un eloquente scudo con al centro una
croce. Il Fronte Popolare, che aveva come simbolo il ritratto di Garibaldi,
fece leva invece sulle difficoltà economiche provocate dalle scelte
apparentemente liberiste del Governo in carica e sulla politica di
restaurazione che esso seguiva; in nome dell'anticomunismo dilagante, in realtà
tali orientamenti governativi costituivano un aiuto insperato per le vecchie
classi dirigenti reazionarie. La vittoria andò alla Democrazia Cristiana che
ottenne quasi la maggioranza assoluta dei voti dando inizio al periodo del
centrismo, caratterizzato da governi guidati da leader democristiani con la
partecipazione di tre piccoli partiti laici intermedi, il Partito Repubblicano,
il Partito Socialdemocratico e il Partito Liberale. L'opposizione era
rappresentata a sinistra dalle consistenti forze dei socialisti e dei comunisti
con il 31% dei voti, a destra dal Movimento Sociale Italiano, nuovo partito che
più o meno direttamente si ispirava all'esperienza e all'ideologia fascista, e
dai monarchici. L'unità delle diverse forze politiche che aveva consentito la
Resistenza e l'elaborazione della Costituzione era stata spazzata via dalla
guerra fredda e non si sarebbe più ricostituita per molto tempo. Si instaurò un
clima politico di repressione nei confronti delle forze più innovatrici del
Paese che a volte sfociò anche in episodi di violenze poliziesche e morti tra i
lavoratori che manifestavano per i loro diritti. Sul piano istituzionale le
forze politiche di maggioranza tentarono di rafforzare ulteriormente il loro
potere con l'approvazione, nel 1953, di una legge elettorale di tipo
maggioritario, ribattezzata dai suoi oppositori come "legge truffa";
ma il risultato ottenuto nelle elezioni dai partiti dell'opposizione ne impedì
l'attivazione concreta. La preoccupazione principale della classe al Governo
era quella di favorire lo sviluppo dell'economia del libero mercato, contrastando
in ogni modo, oltre che i partiti della sinistra, anche le altre organizzazioni
dei lavoratori. La guerra fredda travolse anche il loro sindacato unitario
determinando la creazione di due nuove organizzazioni in concorrenza con la
CGIL ad opera delle correnti politiche filogovernative: la CISL e la UIL.
Furono anni di grave, anche se non completa, non attuazione o ritardo
nell'attuazione della Costituzione, durante i quali si mantenne, per certi
versi, una sostanziale e preoccupante continuità con il precedente Stato
fascista. Le leggi emanate dal regime dittatoriale e non espressamente
abrogate, rimasero in vigore anche se in palese contrasto con le norme
costituzionali. La stessa Corte Costituzionale venne istituita solo nel 1956 e
il suo lavoro di massiccia "bonifica" dell'ordinamento giuridico si
protrasse per parecchi anni. Gli apparati burocratici dello Stato, ed in
particolare quelli che attenevano alla sfera della sicurezza nazionale
(diplomazia, forze armate, polizia), nonostante la sia pur limitata epurazione
di funzionari legati al fascismo, non subirono radicali trasformazioni. La
guerra fredda era spietata e senza esclusione di colpi. L'equilibrio tra le due
superpotenze uscito dalla seconda guerra mondiale non consentiva rilevanti
mutamenti all'interno degli Stati alleati. Mentre i sovietici spesso imposero
direttamente e brutalmente la loro egemonia, gli statunitensi condizionarono il
gioco democratico di molti Paesi in modo indiretto e clandestino, ma non per
questo meno cruento ed efficace, proprio perché incompatibile con la legalità
democratica. Non va dimenticato che l'Italia non solo rivestiva una posizione
geografica rilevante da un punto di vista strategico-militare, ma vedeva
nascere anche un forte schieramento di sinistra e, negli anni successivi al
dopoguerra, il più grande Partito Comunista dell'occidente. Il PCI, pur nella
sua originalità politica, che poteva essere strumentalmente ignorata, nel 1956
solidarizzava con l'invasione sovietica dell'Ungheria e, solo dopo il 1968, con
la condanna dell'invasione della Cecoslovacchia, aveva dato vita a un graduale,
ma definitivo processo di allontanamento da Mosca. In questo contesto, gli
interventi dei servizi segreti statunitensi in Italia furono particolarmente
evidenti, determinando quella "sovranità limitata" che le inchieste
giudiziarie e parlamentari, probabilmente solo in modo parziale, portarono alla
luce. Nonostante il clima politico, nella seconda metà degli anni cinquanta
furono istituiti alcuni importanti organi previsti dalla Costituzione. Come già
ricordato, nel 1956 la Corte Costituzionale; nel 1958 il Consiglio Superiore
della Magistratura, organo fondamentale per garantire l'autonomia e
l'indipendenza dei giudici. Tra le non attuazioni della Costituzione, invece,
particolarmente eclatante fu la mancata attivazione dell'ordinamento regionale
che, in base alla Costituzione, avrebbe dovuto essere reso operativo entro
cinque anni dalla sua entrata in vigore. Per quanto riguarda la politica
economica e sociale, l'intervento dello Stato fu favorito dagli aiuti americani
del Piano Marshall di cui l'Italia poté fruire grazie alla scelta di campo
occidentale. Nel 1950 venne istituita la Cassa per il
democristiano, accondiscendendo alle sempre
più insistenti pressioni politiche statunitensi, provocò, con un pretesto, una
crisi di Governo che sfociò nella costituzione di un nuovo Ministero dal quale
vennero esclusi i socialisti e i comunisti, responsabili di mantenere legami
politici con l'Unione Sovietica, appartenente al blocco politico militare
contrapposto. Le elezioni politiche del 18 aprile, le prime dell'Italia
democratica, si tennero in un clima di feroce ostilità, con da una parte la
Democrazia Cristiana e dall'altra il Fronte Popolare che riuniva socialisti e
comunisti. La prima impostò, come spesso fece anche in seguito, la campagna
elettorale nei termini di un'alternativa secca tra libertà e dittatura
comunista, nonostante il PCI e il PSI avessero dato un evidente e fondamentale
contributo alla lotta di Liberazione e alla stesura della Costituzione,
dimostrando di accettare il metodo democratico nella lotta politica. La DC ebbe
inoltre il massiccio appoggio delle gerarchie ecclesiastiche che ricorsero pure
alla minaccia della scomunica nei confronti degli appartenenti ai partiti di
matrice marxista. Il suo simbolo era un eloquente scudo con al centro una
croce. Il Fronte Popolare, che aveva come simbolo il ritratto di Garibaldi,
fece leva invece sulle difficoltà economiche provocate dalle scelte
apparentemente liberiste del Governo in carica e sulla politica di
restaurazione che esso seguiva; in nome dell'anticomunismo dilagante, in realtà
tali orientamenti governativi costituivano un aiuto insperato per le vecchie
classi dirigenti reazionarie. La vittoria andò alla Democrazia Cristiana che
ottenne quasi la maggioranza assoluta dei voti dando inizio al periodo del
centrismo, caratterizzato da governi guidati da leader democristiani con la
partecipazione di tre piccoli partiti laici intermedi, il Partito Repubblicano,
il Partito Socialdemocratico e il Partito Liberale. L'opposizione era
rappresentata a sinistra dalle consistenti forze dei socialisti e dei comunisti
con il 31% dei voti, a destra dal Movimento Sociale Italiano, nuovo partito che
più o meno direttamente si ispirava all'esperienza e all'ideologia fascista, e
dai monarchici. L'unità delle diverse forze politiche che aveva consentito la
Resistenza e l'elaborazione della Costituzione era stata spazzata via dalla
guerra fredda e non si sarebbe più ricostituita per molto tempo. Si instaurò un
clima politico di repressione nei confronti delle forze più innovatrici del
Paese che a volte sfociò anche in episodi di violenze poliziesche e morti tra i
lavoratori che manifestavano per i loro diritti. Sul piano istituzionale le
forze politiche di maggioranza tentarono di rafforzare ulteriormente il loro
potere con l'approvazione, nel 1953, di una legge elettorale di tipo
maggioritario, ribattezzata dai suoi oppositori come "legge truffa";
ma il risultato ottenuto nelle elezioni dai partiti dell'opposizione ne impedì
l'attivazione concreta. La preoccupazione principale della classe al Governo
era quella di favorire lo sviluppo dell'economia del libero mercato, contrastando
in ogni modo, oltre che i partiti della sinistra, anche le altre organizzazioni
dei lavoratori. La guerra fredda travolse anche il loro sindacato unitario
determinando la creazione di due nuove organizzazioni in concorrenza con la
CGIL ad opera delle correnti politiche filogovernative: la CISL e la UIL.
Furono anni di grave, anche se non completa, non attuazione o ritardo
nell'attuazione della Costituzione, durante i quali si mantenne, per certi
versi, una sostanziale e preoccupante continuità con il precedente Stato
fascista. Le leggi emanate dal regime dittatoriale e non espressamente
abrogate, rimasero in vigore anche se in palese contrasto con le norme
costituzionali. La stessa Corte Costituzionale venne istituita solo nel 1956 e
il suo lavoro di massiccia "bonifica" dell'ordinamento giuridico si
protrasse per parecchi anni. Gli apparati burocratici dello Stato, ed in
particolare quelli che attenevano alla sfera della sicurezza nazionale
(diplomazia, forze armate, polizia), nonostante la sia pur limitata epurazione
di funzionari legati al fascismo, non subirono radicali trasformazioni. La
guerra fredda era spietata e senza esclusione di colpi. L'equilibrio tra le due
superpotenze uscito dalla seconda guerra mondiale non consentiva rilevanti
mutamenti all'interno degli Stati alleati. Mentre i sovietici spesso imposero
direttamente e brutalmente la loro egemonia, gli statunitensi condizionarono il
gioco democratico di molti Paesi in modo indiretto e clandestino, ma non per
questo meno cruento ed efficace, proprio perché incompatibile con la legalità
democratica. Non va dimenticato che l'Italia non solo rivestiva una posizione
geografica rilevante da un punto di vista strategico-militare, ma vedeva
nascere anche un forte schieramento di sinistra e, negli anni successivi al
dopoguerra, il più grande Partito Comunista dell'occidente. Il PCI, pur nella
sua originalità politica, che poteva essere strumentalmente ignorata, nel 1956
solidarizzava con l'invasione sovietica dell'Ungheria e, solo dopo il 1968, con
la condanna dell'invasione della Cecoslovacchia, aveva dato vita a un graduale,
ma definitivo processo di allontanamento da Mosca. In questo contesto, gli
interventi dei servizi segreti statunitensi in Italia furono particolarmente
evidenti, determinando quella "sovranità limitata" che le inchieste
giudiziarie e parlamentari, probabilmente solo in modo parziale, portarono alla
luce. Nonostante il clima politico, nella seconda metà degli anni cinquanta
furono istituiti alcuni importanti organi previsti dalla Costituzione. Come già
ricordato, nel 1956 la Corte Costituzionale; nel 1958 il Consiglio Superiore
della Magistratura, organo fondamentale per garantire l'autonomia e
l'indipendenza dei giudici. Tra le non attuazioni della Costituzione, invece,
particolarmente eclatante fu la mancata attivazione dell'ordinamento regionale
che, in base alla Costituzione, avrebbe dovuto essere reso operativo entro
cinque anni dalla sua entrata in vigore. Per quanto riguarda la politica
economica e sociale, l'intervento dello Stato fu favorito dagli aiuti americani
del Piano Marshall di cui l'Italia poté fruire grazie alla scelta di campo
occidentale. Nel 1950 venne istituita la Cassa per il  venne creato l'ENI (Ente Nazionale
Idrocarburi) allo scopo di effettuare e coordinare le ricerche petrolifere e
metanifere italiane, ma anche di dare un'efficace politica energetica
all'Italia. Infine, prese avvio il lento processo di integrazione europea con
l'adesione dell'Italia nel 1951 alla Comunità Economica del Carbone e
dell'Acciaio (CECA) e nel 1957 all'Euratom e alla Comunità Economica Europea. All'inizio degli anni
sessanta cominciò una fase di distensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica e
di grandi speranze ideali per tutto il mondo, caratterizzata dall'attenuazione
del clima di contrapposizione frontale tra i due blocchi. Nel 1961 Kruscev e
Kennedy si incontrarono negli Stati Uniti e avviarono i primi accordi relativi
alla sospensione degli esperimenti atomici, nella prospettiva di una pacifica
coesistenza che riconoscesse la
venne creato l'ENI (Ente Nazionale
Idrocarburi) allo scopo di effettuare e coordinare le ricerche petrolifere e
metanifere italiane, ma anche di dare un'efficace politica energetica
all'Italia. Infine, prese avvio il lento processo di integrazione europea con
l'adesione dell'Italia nel 1951 alla Comunità Economica del Carbone e
dell'Acciaio (CECA) e nel 1957 all'Euratom e alla Comunità Economica Europea. All'inizio degli anni
sessanta cominciò una fase di distensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica e
di grandi speranze ideali per tutto il mondo, caratterizzata dall'attenuazione
del clima di contrapposizione frontale tra i due blocchi. Nel 1961 Kruscev e
Kennedy si incontrarono negli Stati Uniti e avviarono i primi accordi relativi
alla sospensione degli esperimenti atomici, nella prospettiva di una pacifica
coesistenza che riconoscesse la  diversità dei rispettivi sistemi
politico-economici. In quegli anni mutò anche l'atteggiamento della Chiesa
cattolica che, sotto il pontificato di Giovanni XXIII, assecondando il processo
di distensione e di apertura, abbandonò le sue posizioni più smaccatamente
filo-occidentali. Ancora una volta, questa situazione politica internazionale
ebbe effetti anche rispetto alla politica interna italiana, favorendo un
atteggiamento più aperto verso l'innovazione e le riforme. La Democrazia
Cristiana venne così indotta ad abbandonare l'alleanza con la destra, che dal
1957 appoggiava i suoi Governi dall'esterno, e a iniziare un processo di
riforme, sentito ormai da molti come indilazionabile, attraverso un'operazione
di apertura a sinistra nei confronti del Partito Socialista. Quest'ultimo
dapprima appoggiò il Governo dall'esterno, poi vi partecipò direttamente e,
accanto al Partito Socialdemocratico e al Partito Repubblicano, vi rimase quasi
ininterrottamente fino al 1976, dando luogo al cosiddetto centrosinistra. Questa
operazione politica significò da una parte, per i socialisti, la possibilità di
uscire da una condizione di sudditanza e dipendenza nei confronti del Partito
Comunista e da un'opposizione che non pareva dare nessun risultato concreto;
dall'altra, per i democristiani, rappresentò la possibilità concreta di
dividere la sinistra e isolare all'opposizione il Partito Comunista. Si
cominciò a consolidare quell'atteggiamento della DC, e delle forze politiche
che le gravitarono attorno per alcuni decenni anche se non ne condividevano
appieno la politica, volto ad evitare a tutti i costi che il PCI, numericamente
secondo partito del Paese, potesse conquistare o anche solo compartecipare
formalmente al Governo. Dal 1947 al 1993 la DC rappresentò l'asse portante di
tutti i Governi e di tutte le maggioranze parlamentari e il PCI, se si esclude
la parentesi dell'unità nazionale dal 1976 al
diversità dei rispettivi sistemi
politico-economici. In quegli anni mutò anche l'atteggiamento della Chiesa
cattolica che, sotto il pontificato di Giovanni XXIII, assecondando il processo
di distensione e di apertura, abbandonò le sue posizioni più smaccatamente
filo-occidentali. Ancora una volta, questa situazione politica internazionale
ebbe effetti anche rispetto alla politica interna italiana, favorendo un
atteggiamento più aperto verso l'innovazione e le riforme. La Democrazia
Cristiana venne così indotta ad abbandonare l'alleanza con la destra, che dal
1957 appoggiava i suoi Governi dall'esterno, e a iniziare un processo di
riforme, sentito ormai da molti come indilazionabile, attraverso un'operazione
di apertura a sinistra nei confronti del Partito Socialista. Quest'ultimo
dapprima appoggiò il Governo dall'esterno, poi vi partecipò direttamente e,
accanto al Partito Socialdemocratico e al Partito Repubblicano, vi rimase quasi
ininterrottamente fino al 1976, dando luogo al cosiddetto centrosinistra. Questa
operazione politica significò da una parte, per i socialisti, la possibilità di
uscire da una condizione di sudditanza e dipendenza nei confronti del Partito
Comunista e da un'opposizione che non pareva dare nessun risultato concreto;
dall'altra, per i democristiani, rappresentò la possibilità concreta di
dividere la sinistra e isolare all'opposizione il Partito Comunista. Si
cominciò a consolidare quell'atteggiamento della DC, e delle forze politiche
che le gravitarono attorno per alcuni decenni anche se non ne condividevano
appieno la politica, volto ad evitare a tutti i costi che il PCI, numericamente
secondo partito del Paese, potesse conquistare o anche solo compartecipare
formalmente al Governo. Dal 1947 al 1993 la DC rappresentò l'asse portante di
tutti i Governi e di tutte le maggioranze parlamentari e il PCI, se si esclude
la parentesi dell'unità nazionale dal 1976 al
LA NASCITA DELLA REPUBBLICA:
VERSO LE ELEZIONI:
La guerra era terminata e la parola dalle
armi doveva passare alle urne, ma, sia per difficoltà tecniche relative
all'apprestamento delle nuove liste degli elettori, sia a causa di pressioni
politiche delle forze più moderate che temevano nell'immediato dopoguerra una
reazione popolare troppo favorevole alle forze più innovative, dovettero
trascorrere ancora tredici mesi perché si giungesse alle prime elezioni libere
attraverso le quali gli italiani avrebbero dovuto porre le fondamenta delle
nuove istituzioni del Paese. Dal 1928 il popolo italiano non era più stato
chiamato alle urne e, finalmente, il
LA PROCLAMAZIONE:
Circa
12 milioni e settecentomila italiani, contro 10 milioni e settecentomila,
decisero che l'Italia doveva trasformarsi da Regno in Repubblica, con un Capo
dello Stato elettivo. Il  costituzionale", a sottolineare il valore
perenne e irrevocabile di quella scelta popolare. Il primo Presidente della
Repubblica italiana fu Luigi Einaudi, eletto dal Parlamento secondo le regole
contenute nella nuova Costituzione (tit. II della seconda parte) il
costituzionale", a sottolineare il valore
perenne e irrevocabile di quella scelta popolare. Il primo Presidente della
Repubblica italiana fu Luigi Einaudi, eletto dal Parlamento secondo le regole
contenute nella nuova Costituzione (tit. II della seconda parte) il
Gli
esiti dell'elezione dei 556 componenti dell'Assemblea Costituente che, in
rappresentanza del popolo, avrebbero elaborato la nuova Costituzione, furono
per lo più favorevoli a quei partiti politici che avevano combattuto la
dittatura e, in particolare nel corso della Resistenza, si erano riorganizzati
assumendo un ruolo guida nella lotta armata contro il nazifascismo e nella
transizione dallo Stato fascista al nuovo Stato.Si trattava principalmente dei
tre grandi partiti di massa che avrebbero caratterizzato anche la vita politica
italiana nei decenni successivi all'entrata in vigore della Costituzione: la
Democrazia Cristiana, che ebbe il 35,2% dei voti; il Partito Socialista di
Unità Proletaria, con il 20,8%; il Partito Comunista italiano, con il 19%.I più
alti e valorosi nomi della Resistenza italiana, accanto al fior fiore dei
giuristi democratici dell'epoca e di una nuova classe politica che si stava
formando, comparivano tra i Costituenti scelti dagli italiani. Il  l'incarico di redigere un progetto che
avrebbe dovuto servire da base per la successiva discussione. Dopo circa sei
mesi di attività, la "Commissione dei 75" presentò il suo lavoro
all'Assemblea che nel corso di quasi tutto il 1947 discusse, integrò, modificò,
articolo per articolo, quella prima proposta e, finalmente, il 22 dicembre
dello stesso anno approvò a larghissima maggioranza il testo definitivo della
Costituzione che successivamente venne promulgato dal Capo provvisorio dello
Stato ed entrò in vigore il primo gennaio 1948.
l'incarico di redigere un progetto che
avrebbe dovuto servire da base per la successiva discussione. Dopo circa sei
mesi di attività, la "Commissione dei 75" presentò il suo lavoro
all'Assemblea che nel corso di quasi tutto il 1947 discusse, integrò, modificò,
articolo per articolo, quella prima proposta e, finalmente, il 22 dicembre
dello stesso anno approvò a larghissima maggioranza il testo definitivo della
Costituzione che successivamente venne promulgato dal Capo provvisorio dello
Stato ed entrò in vigore il primo gennaio 1948.
ORDINAMENTO INGLESE:
GENERAL:

THE MONARCH:
 The Queen is the
head of state and a symbol of national unit, but she has no control over the
policies of the government. She
officially appoints the ministers of "Her Majesty's Government" but, in fact,
they have been chosen by the people in an election.
The Queen is the
head of state and a symbol of national unit, but she has no control over the
policies of the government. She
officially appoints the ministers of "Her Majesty's Government" but, in fact,
they have been chosen by the people in an election.
PARLIAMENT:
Parliament is
responsible for making the laws of the country and for giving authority to the
decisions of the government. A government cannot continue in power if
parliament votes against it. The main institution of parliament is the House of
Commons which has 659 members. These Mps
(members of parliament) are elected in the following way:  new laws. A
proposal for new legislation (called a "bill") must be approved by a majority
of MPs before it becomes a law. There is also a second institution in parliament
the House of Lords, which has over 1000 members. They are no elected by the
people. Some of them are hereditary peers (members of old aristocratic families
who inherit their titles); others are life peers(people who are given a
personal title by the government). Senior bishops of the Church of England and
senior judges are also members. The House of Lords is now being reformed with
the intention of removing the hereditary peers. The House of Lords has little
real power. The senior judges in the house of Lords have an important function. They are the
final court of the British judicial system.
new laws. A
proposal for new legislation (called a "bill") must be approved by a majority
of MPs before it becomes a law. There is also a second institution in parliament
the House of Lords, which has over 1000 members. They are no elected by the
people. Some of them are hereditary peers (members of old aristocratic families
who inherit their titles); others are life peers(people who are given a
personal title by the government). Senior bishops of the Church of England and
senior judges are also members. The House of Lords is now being reformed with
the intention of removing the hereditary peers. The House of Lords has little
real power. The senior judges in the house of Lords have an important function. They are the
final court of the British judicial system.
GOVERNMENT:
 The monarch
appoints as Prime Minister the leader of the party with most MPs in the House
of Commons. The Prime Minister then choose other leading MPs from his/her party
to become ministers in the government. Among the most important ministers are the
Chancellor of the Exchequer (responsible for financial matters), the Home
secretary (responsible for internal security, police, prisons, immigration,
etc.) and the Foreign Secretary (responsible for foreign policy). The party
with the second largest number of MPs is recognized at the official opposition,
in fact the House of Commons is physically designed to accommodate two parties,
one sitting opposite the other. The government remains in power as long as it has the support of majority in
the Commons. After five years there must be a new general elections but the
Prime Minister has the power of dissolve parliament and call a new election at
any time during those five years. If no single party has a
majority, a coalition of parties may form the government. This rarely happens
in
The monarch
appoints as Prime Minister the leader of the party with most MPs in the House
of Commons. The Prime Minister then choose other leading MPs from his/her party
to become ministers in the government. Among the most important ministers are the
Chancellor of the Exchequer (responsible for financial matters), the Home
secretary (responsible for internal security, police, prisons, immigration,
etc.) and the Foreign Secretary (responsible for foreign policy). The party
with the second largest number of MPs is recognized at the official opposition,
in fact the House of Commons is physically designed to accommodate two parties,
one sitting opposite the other. The government remains in power as long as it has the support of majority in
the Commons. After five years there must be a new general elections but the
Prime Minister has the power of dissolve parliament and call a new election at
any time during those five years. If no single party has a
majority, a coalition of parties may form the government. This rarely happens
in
POLITICAL PARTIES:
The Labour Party developed as a socialist party, with close connections to the trade unions. It was in power between 1945 and 1951, when it established the National Health Service and other welfare state institutions and also nationalized a number of important industries. In 1990s under the leadership of Tony Blair, the party modernized its image and policies. Labour won a decisive victory in the 1997 general election. The Conservative Party is a centre-right party which traditionally wins support from the middle class and business interest. When it came to power under the leadership of Margaret Thatcher in 1979 the party become more radically right-wing and reversed many of socialist policies of previous governments. The Conservative introduces policies in favour of private enterprise and the free market and also tried to reduce taxes. The Liberal Democrats regularly win 15-20% of votes but have comparatively small number of MPs because of the voting system. They are politically in the centre and are enthusiastic supporters of European Union.
BIBLIOGRAFIA:
Si ringrazia per il reperimento delle informazioni:
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025