|
|
| |
![]()
papiro
![]() Il papiro [sec. XIV; dal lat. papyrus, dal gr. pápyros]è una pianta (Cyperus
papyrus) della famiglia delle Ciperacee
che cresce in Siria, Palestina, Africa tropicale e Sicilia. È un'erba perenne
rizomatosa, con fusti verdi, trigoni, alti da 2 a 5 m, con guaine afille o
prolungate in lamina; all'apice di ogni fusto compare un'ampia ombrella con
brattee lanceolate e ombrellette tribratteate con numerosi fiori pedicellati
formati da piccole spighette rossigne. Il papiro,oggi, viene spesso coltivato
in vasche o nelle serre calde, a scopo decorativo. Anticamente veniva
utilizzato come materiale scrittorio, usato ottenuto dalla sostanza midollosa
tratta dall'interno del fusto che veniva tagliata in 525c26f strisce poi sovrapposte e
incrociate; in particolare charta papyri, era un' espressione usata in
Occidente intorno al sec. XII per indicare la carta di
Il papiro [sec. XIV; dal lat. papyrus, dal gr. pápyros]è una pianta (Cyperus
papyrus) della famiglia delle Ciperacee
che cresce in Siria, Palestina, Africa tropicale e Sicilia. È un'erba perenne
rizomatosa, con fusti verdi, trigoni, alti da 2 a 5 m, con guaine afille o
prolungate in lamina; all'apice di ogni fusto compare un'ampia ombrella con
brattee lanceolate e ombrellette tribratteate con numerosi fiori pedicellati
formati da piccole spighette rossigne. Il papiro,oggi, viene spesso coltivato
in vasche o nelle serre calde, a scopo decorativo. Anticamente veniva
utilizzato come materiale scrittorio, usato ottenuto dalla sostanza midollosa
tratta dall'interno del fusto che veniva tagliata in 525c26f strisce poi sovrapposte e
incrociate; in particolare charta papyri, era un' espressione usata in
Occidente intorno al sec. XII per indicare la carta di
stracci allora introdotta per soppiantare la pergamena (che a sua volta aveva sostituito l'uso del
papiro. Il suo utilizzo si sviluppò in Egitto verosimilmente verso il III millennio a. C.e venne introdotto in Grecia verso il sec. VI
a. C., si diffuse poi più largamente al tempo e per opera di Alessandro Magno; a Roma il papiro
egiziano incominciò a essere usato correntemente verso il sec. II a. C.
La tecnica egiziana di fabbricazione del p., descritta da Plinio nella sua Naturalis Historia (XIII, 11-13), era la seguente:
la parte inferiore, più morbida, del fusto, per un'altezza da 30 a 40 cm secondo la grossezza del
fusto, dopo essere stata scortecciata veniva tagliata con una lama particolare (acu) in strisce (
schidae o schedae), che si univano tra loro mediamente in numero di 20 (di più o di meno per
fogli di dimensioni particolari) sovrapponendo per un piccolo lembo l'una all'altra lungo il lato
maggiore; si formava così la philira a cui si sovrapponeva una seconda philira con le strisce o
schede disposte ortogonalmente rispetto a quelle della prima; ne risultava un graticcio (crates
che veniva sottoposto alla pressione di un cilindro rotante fra strati di materiale assorbente;
questo veniva poi essiccato, allisciato e lucidato per ottenere il foglio finito (plagula); si univano
infine l'una all'altra, per mezzo di una colla di farina e aceto, tante plagulae quante ne richiedeva
la lunghezza del testo che dovevano accogliere; sui lati brevi della striscia così ottenuta si
incollavano due bastoncini (umbilicus) per agevolare l'avvolgimento a rotolo (volumen). Sulla
striscia la scrittura (tracciata col calamo o cannuccia appuntita) era di norma disposta in colonne (
collema o selides) parallele tra loro e parallele al lato minore della striscia che pertanto veniva
svolta orizzontalmente (contrariamente a quanto avvenne più tardi per i rotoli di pergamena che
peraltro non ebbero altrettanto universale diffusione); la scrittura inoltre era tracciata solo sulla
facciata del papiro in cui le fibre erano orizzontali, e solo nei periodi di particolare scarsità si
utilizzarono entrambe le facciate (i p. in questo caso sono detti opistografi). Verso il sec. III d. C.
le plagulae di papiro incominciarono a essere usate in forma di codice, cioè piegate nel mezzo e
cucite a quaderno così come comunemente si faceva con i fogli di pergamena che già stavano
soppiantando il papiro, il cui uso di lì a poco fu del tutto abbandonato.
![]() La Pergamena (detta anche cartapecora)
è un materiale che veniva usato per le pagine di un libro o di un codice, costituito dalla pelle sottile di un vitello oppure pelle di pecora o di capra. Durante il Medioevo
la pelli di vitello e di pecora erano i materiali preferiti per fare la
pergamena in Inghilterra e in Francia,
la pelle di capra era più comunemente usata in Italia. In
epoca successiva (verso la fine del I millennio
in Europa),
la pergamenta venne sempre più rimpiazzata dalla carta.
La Pergamena (detta anche cartapecora)
è un materiale che veniva usato per le pagine di un libro o di un codice, costituito dalla pelle sottile di un vitello oppure pelle di pecora o di capra. Durante il Medioevo
la pelli di vitello e di pecora erano i materiali preferiti per fare la
pergamena in Inghilterra e in Francia,
la pelle di capra era più comunemente usata in Italia. In
epoca successiva (verso la fine del I millennio
in Europa),
la pergamenta venne sempre più rimpiazzata dalla carta.
La pergamena (pergaminus in latino) prende nome dalla città di Pergamo dove è stata inventata attorno al II secolo AC, come sostituto del papiro. Pergamo aveva una grande biblioteca che rivaleggiava con la famosa Biblioteca di Alessandria. Quando Alessandria smise di esportare il papiro, a causa dei blocchi commerciali dovuti all'invasione islamica del Mediterraneo, Pergamo si adattò inventando la pergamena.
Per ottenere la pergamena, la pelle dell'animale, una volta rimosso il pelo, e dopo essere stata accuratamente pulita, veniva immersa in una soluzione di acqua e calce al fine di ammorbidirla. La seconda fase della produzione era lo sbiancamento, ottenuto tramite l'uso di ammoniaca o acqua ossigenata. A questo punto la pelle veniva montata su un telaio e lasciata ad essicare.
![]() La fabbricazione del papiro è
documentata in una tomba tebana, risalente al 1400 a.C. Nella parete è
raffigurata un uomo che sporgendosi da una barca raccoglie i papiri, mentre un
altro uomo li lega a fasci; sulla riva un terzo uomo trasporta il fascio sulla
schiena per consegnarlo ad un quarto che lavora gli steli, seduto su uno
sgabello.
La fabbricazione del papiro è
documentata in una tomba tebana, risalente al 1400 a.C. Nella parete è
raffigurata un uomo che sporgendosi da una barca raccoglie i papiri, mentre un
altro uomo li lega a fasci; sulla riva un terzo uomo trasporta il fascio sulla
schiena per consegnarlo ad un quarto che lavora gli steli, seduto su uno
sgabello.
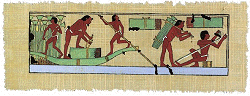
![]() Una
descrizione della lavorazione è fornita da Gaio Plinio Secondo il Vecchio (23 -
79 d.C.): "il fusto veniva tagliato in strisce sottili per il lungo con un
coltello e venivano poste l'una accanto all'altra su di una tavola fino a
formare la grandezza del foglio desiderata; sopra questo strato venivano poste
altre strisce ad angolo retto rispetto alle prime; il tutto veniva inumidito
con le acque torbide del Nilo; infine i due strati venivano pressati e fatti
essiccare al sole. Si ottenevano fogli della larghezza voluta e la striscia
veniva conservata arrotolata".
Una
descrizione della lavorazione è fornita da Gaio Plinio Secondo il Vecchio (23 -
79 d.C.): "il fusto veniva tagliato in strisce sottili per il lungo con un
coltello e venivano poste l'una accanto all'altra su di una tavola fino a
formare la grandezza del foglio desiderata; sopra questo strato venivano poste
altre strisce ad angolo retto rispetto alle prime; il tutto veniva inumidito
con le acque torbide del Nilo; infine i due strati venivano pressati e fatti
essiccare al sole. Si ottenevano fogli della larghezza voluta e la striscia
veniva conservata arrotolata".
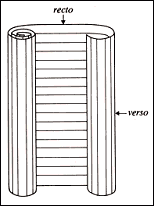


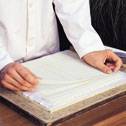

La
descrizione di Plinio lascia pensare che questi fossero i processi principali e
che venissero usate manipolazioni secondarie per perfezionare il foglio, dalle
quali dipendono le differenti qualità della carta papiro.
![]() Le
tecniche di manifattura erano diverse, come dimostrano le diverse qualità di
papiri ritrovati. La migliore carta papiro risale all'epoca faraonica (3.100 /
332 a.C.), quella riservata ai testi sacri veniva chiamata ieratica.. La carta
prodotta in epoca romana (fino al III sec. d.C.) è ancora buona, mentre
scadente è quella del periodo bizantino e arabo che veniva fabbricata in
Egitto, Sicilia, Siria, Mesopotamia.
Le
tecniche di manifattura erano diverse, come dimostrano le diverse qualità di
papiri ritrovati. La migliore carta papiro risale all'epoca faraonica (3.100 /
332 a.C.), quella riservata ai testi sacri veniva chiamata ieratica.. La carta
prodotta in epoca romana (fino al III sec. d.C.) è ancora buona, mentre
scadente è quella del periodo bizantino e arabo che veniva fabbricata in
Egitto, Sicilia, Siria, Mesopotamia.
![]() In
Egitto la produzione cessa nel XI-XII secolo d.C. e i metodi di fabbricazione
della carta ad uso scrittorio non furono più tramandati. Soltanto nel 1962
riprende una produzione simile a quella che gli antichi egizi definivano
emporetica (commerciale, da imballaggio).
In
Egitto la produzione cessa nel XI-XII secolo d.C. e i metodi di fabbricazione
della carta ad uso scrittorio non furono più tramandati. Soltanto nel 1962
riprende una produzione simile a quella che gli antichi egizi definivano
emporetica (commerciale, da imballaggio).
A Siracusa, dove la carta di papiro si produce sin dal 1781, nei laboratori
dell' Istituto del Papiro oggi rivive questo prodigio di tecnica e d'arte.
Pertanto la raccolta della pianta matura al punto giusto e l'utilizzo solo
della parte migliore di essa, il trattamento d'immunizzazione effettuato solo
con sali naturali, l'opportuna cura nella manipolazione dei fogli durante le
varie fasi d'essiccamento, fanno la differenza fra la carta pregiata ad uso
scrittorio e quella emporetica ad uso commerciale. Un foglio posto in
trasparenza farà notare il reticolato formato dalle strisce sovrapposte in
ortogonale e la cura con cui è stato realizzato.
I costi elevati della carta papiro non derivano dalla materia prima, ma dalla tecnica di fabbricazione a cui va aggiunto il valore per la scrittura e la decorazione; per questo i papiri miniati hanno un alto valore se vengono prodotti con cura e sono ricchi di significato culturale (come tutte le opere d'arte). In Egitto un rotolo costava poco meno di una tunica di lino; ad Atene un foglio costava quanto una pecora.
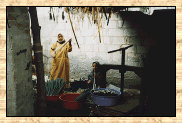
![]()
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025