|
|
| |
ALTRI DOCUMENTI
|
|||||||||

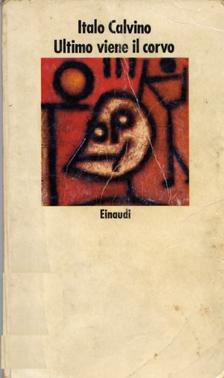
Nuovi Coralli 152
Italo Calvino
ULTIMO VIENE IL CORVO
Einaudi
e-book realizzato da filuc (2003)
Copyright 1994 by Giulio Einaudi editore, Torino
Impostazione grafica di copertina: Federico Luci
ISBN 88-06-21490-7
INDICE
Nota
Un pomeriggio, Adamo
Un bastimento carico di granchi
Il giardino incantato
Alba sui rami nudi
Di padre in figlio
Uomo nei gerbidi
L'occhio del padrone
I figli poltroni
Pranzo con un pastore
I fratelli Bagnasco
La casa degli alveari
La stessa cosa del sangue
Attesa della morte in un albergo
Angoscia in caserma
Paura sul sentiero
La fame a Bévera
Andato al comando
Ultimo viene il corvo
Uno dei tre è ancora vivo
Il bosco degli animali
Campo di mine
Visti alla mensa
Furto in una pasticceria
Dollari e vecchie mondane
L'avventura di un soldato
Si dorme come cani
Desiderio in novembre
Impiccagione di un giudice
Il gatto e il poliziotto
Chi ha messo la mina nel mare?
Il testo di Ultimo viene il corvo in questa edizione dei «Nuovi Coralli» è in tutto identico a quello della prima edizione, uscita nel 1949 nei Coralli (in una tiratura di sole millecinquecento copie) e comprendente trenta racconti brevi, scritti da Italo Calvino tra l'estate del 1945 e la primavera del 1949.
Di questi trenta racconti, venti venivano inclusi dall'autore nel 1958 nella sua raccolta più ampia intitolata I racconti.
Nel 1969 usciva sempre nei Coralli una nuova edizione di Ultimo viene il corvo, in cui figuravano venticinque racconti della prima edizione più cinque di poco posteriori, in un diverso ordine.
Questa edizione (1976) riproduce invece i trenta racconti del 1949 nello stesso ordine, compresi i racconti «rifiutati» dall'autore nelle raccolte successive. Tra essi, come testimonianza d'epoca, sono i primi racconti che Italo Calvino scrisse nel 1945, nei mesi seguenti alla Liberazione (La stessa cosa del sangue, Attesa della morte in un albergo, Angoscia in caserma), e che l'autore non aveva più voluto ripubblicare perché l'esperienza della Resistenza vi viene resa ancora attraverso una evocazione emotiva, che contrasta con lo stile da lui elaborato in seguito.
Il nuovo giardiniere era un ragazzo coi capelli lunghi, e una crocetta di stoffa in testa per tenerli fermi. Adesso veniva su per il viale con l'innaffiatoio pieno, sporgendo l'altro braccio per bilanciare il carico. Innaffiava le piante di nasturzio, piano piano, come versasse caffelatte: in terra, al piede delle piantine, si dilatava una macchia scura; quando la macchia era grande e molle lui rialzava l'innaffiatoio e passava a un'altra pianta. Il giardiniere doveva essere un bel mestiere perché si potevano fare tutte le cose con calma. Maria-nunziata lo stava guardando dalla finestra della cucina. Era un ragazzo già grande, eppure portava ancora i calzoni corti. E quei capelli lunghi che sembrava una ragazza. Smise di risciacquare i piatti e batté sui vetri.
- Ragazzo, - disse.
Il ragazzo-giardiniere alzò la testa, vide Maria-nunziata e sorrise. Anche Maria-nunziata si mise a ridere, per rispondere a lui, e perché non aveva mai visto un ragazzo coi capelli così lunghi e con una crocetta come quella in testa. Allora il ragazzo-giardiniere le fece «vieni-qui» con la mano e Maria-nunziata continuava a ridere per quel suo modo buffo di fare i gesti, e si mise anche lei a fare gesti per spiegargli che aveva da rigovernare i piatti. Ma il ragazzo- giardiniere le faceva «vieni-qui» con una mano e con l'altra indicava i vasi delle dalie. Perché indicava i vasi delle dalie? Maria-nunziata schiuse i vetri e mise la testa fuori.
- Cosa c'è? - disse, e si mise a ridere.
- Di': vuoi vedere una bella cosa?
- Cos'è?
- Una bella cosa. Vieni a vedere. Presto.
- Dimmi cosa.
- Te la regalo. Ti regalo una bella cosa.
- Ho i piatti da lavare. Poi viene la signora, e non mi trova.
- La vuoi o non la vuoi? Alé, vieni.
- Aspetta lì, - disse Maria-nunziata, e chiuse la finestra.
Quando uscì dalla porticina di servizio, il ragazzo-giardiniere era sempre lì che bagnava i nasturzi.
- Ciao, - disse Maria-nunziata.
Maria-nunziata sembrava più alta perché aveva le scarpe belle coi sugheri, che era un peccato tenerle anche per i servizi, come piaceva a lei. Ma aveva una faccia bambina, piccola in mezzo al riccio dei capelli neri, e anche le gambe ancora magre e bambine, mentre il corpo, negli sbuffi del grembiule, era già pieno e adulto. E rideva sempre: a ogni cosa detta dagli altri o da lei, rideva.
- Ciao, - disse il ragazzo-giardiniere. Aveva la pelle marrone, sulla faccia, sul collo, sul petto: forse perché stava sempre così, mezzo nudo.
- Come ti chiami? - disse Maria-nunziata.
- Libereso, - disse il ragazzo-giardiniere.
Maria-nunziata rideva e ripeté: - Libereso... Libereso... che nome, Libereso.
- É un nome in esperanto, - disse lui. - Vuol dire libertà, in esperanto.
- Esperanto, - disse Maria-nunziata. - Sei esperanto, tu?
- L'esperanto è una lingua, - spiegò Libereso. Mio padre parla esperanto.
- Io sono calabrese, - disse Maria-nunziata.
- Come ti chiami?
- Maria-nunziata, - e rideva.
- Perché ridi sempre?
- Ma perché ti chiami Esperanto?
- Non esperanto: Libereso.
- Perché?
- E perché tu ti chiami Maria-nunziata?
- É il nome della Madonna. Io mi chiamo come la Madonna e mio fratello come san Giuseppe.
- Sangiuseppe?
Maria-nunziata scoppiava dal ridere: - Sangiuseppe! Giuseppe, non Sangiuseppe! Libereso!
- Mio fratello, - disse Libereso, - si chiama Germinal e mia sorella Omnia.
- Quella cosa, - disse Maria-nunziata, - fammi vedere quella cosa.
- Vieni, - disse Libereso. Posò l'innaffiatoio e la prese per mano.
Maria-nunziata s'impuntò: - Dimmi cos'è, prima.
- Vedrai, - disse lui, - mi devi promettere che la terrai da conto.
- Me la regali?
- Sì, te la regalo. - L'aveva condotta nell'angolo vicino al muro del giardino. C'erano delle piante di dalia in vaso alte quanto loro.
- É lì.
- Cosa?
- Aspetta.
Maria-nunziata faceva capolino dietro le sue spalle. Libereso si chinò per spostare un vaso, ne alzò un altro, vicino al muro, e indicò per terra.
- Lì, - disse.
- Cosa? - disse Maria-nunziata. Non vedeva niente: era un angolo in ombra, con foglie umide e terriccio.
- Guarda che si muove, - disse il ragazzo. Allora lei vide una pietra di foglie che si muoveva, una cosa umida, con occhi e piedi: un rospo.
- Mammamia!
Maria-nunziata era scappata saltando tra le dalie con le scarpe belle di sughero. Libereso era accoccolato vicino al rospo e rideva, con i denti bianchi in mezzo alla faccia marrone.
- Hai paura! É un rospo! Perché hai paura?
- É un rospo! - gemette Maria-nunziata.
- É un rospo. Vieni, - disse Libereso.
Lei gli puntò contro un dito: - Uccidilo.
Il ragazzo mise le mani avanti, quasi a ripararlo: - Non voglio. È buono.
- É un rospo buono?
- Sono tutti buoni. Mangiano i vermi.
- Ah, - disse Maria-nunziata, ma non s'avvicinava. Si mordeva il colletto del grembiule e cercava di vedere torcendo gli occhi.
- Guarda che bello, - disse Libereso e mise giù la mano.
Maria-nunziata s'avvicinò: non rideva più, guardava a bocca aperta: - No! Non lo toccare!
Libereso con un dito stava carezzando il rospo sulla schiena verde-grigia, piena di verruche bavose.
- Sei matto? Non sai che brucia, a toccarlo, e ti fa gonfiare la mano?
Il ragazzo le mostrò le sue grosse mani marrone, con le palme rivestite da uno strato giallo calloso.
- A me non fa niente, - disse. - É così bello.
Aveva preso il rospo per la collottola come fosse un gattino e se l'era posato sul palmo d'una mano. Maria-nunziata, mordendosi il collarino del grembiule, s'avvicinò e gli s'accoccolò vicino.
- Mammamia che impressione, - disse.
Erano accoccolati tutt'e due dietro le dalie, e i ginocchi rosa di Maria-nunziata sfioravano quelli marrone tutti sbucciature di Libereso. Libereso passava una mano sul dorso del rospo, di palma e di dorso, e ogni tanto lo riacchiappava quando voleva scivolar giù.
- Carezzalo anche tu, Maria-nunziata, - disse.
La ragazza si nascose le mani in grembo.
- No, - disse.
- Come? - lui disse, - non lo vuoi?
Maria-nunziata abbassò gli occhi, poi guardò il rospo e li riabbassò subito.
- No, - disse.
- É tuo. Te lo regalo, - disse Libereso.
Maria-nunziata aveva gli occhi annuvolati, adesso: era triste rinunciare a un regalo, nessuno le faceva mai regali, ma il rospo proprio le metteva schifo.
- Te lo lascio portare in casa, se vuoi. Ti terrà compagnia.
- No, - disse. Libereso rimise in terra il rospo che s'andò subito ad acquattare tra le foglie.
- Ciao, Libereso.
- Aspetta.
- Devo finire di lavare i piatti. La signora non vuole che esca in giardino.
- Aspetta. Ti voglio regalare qualcosa. Una cosa proprio bella. Vieni.
Lei si mise a seguirlo per i vialetti di ghiaia. Era uno strano ragazzo, Libereso, con i capelli lunghi e che pigliava in mano i rospi.
- Quanti anni hai, Libereso?
- Quindici. E tu?
- Quattordici.
- Compiti o da compire?
- Li compio il giorno dell'Annunciazione.
- É già passato?
- Come, non sai quand'è l'Annunciazione?
S'era rimessa a ridere.
- No.
- L'Annunciazione, quando c'è la processione. Non ci vai alla processione?
- Io no.
- Al mio paese sì che ci sono delle belle processioni. Al mio paese non è come qui. Ci sono grandi campi tutti di bergamotti e nient'altro che bergamotti. E tutto il lavoro è raccogliere bergamotti da mattino a sera. E noi eravamo quattordici fratelli e sorelle, e tutti raccoglievamo bergamotti, e cinque sono morti bambini, e a mia madre venne il tetano, e noi siamo stati in treno una settimana per venire da zio Carmelo e lì si stava in otto a dormire in un garage. Di', perché porti i capelli così lunghi?
Si erano fermati a un'aiuola di calle.
- Perché così. Anche tu li hai lunghi.
- Io sono una femmina. Se li porti lunghi sei come una femmina.
- Io non sono come una femmina. Non è dai capelli che si vede se uno è maschio o femmina.
- Come non è dai capelli?
- Non è dai capelli.
- Perché non è dai capelli?
- Vuoi che ti regali una bella cosa?
- Sì.
Libereso si mise a girare tra le calle. Erano tutte sbocciate, le bianche trombe al cielo. Libereso guardava dentro ogni calla, ci frugava dentro con due dita e si nascondeva qualcosa nella mano stretta a pugno. Maria-nunziata non era entrata nell'aiuola e lo guardava ridendo in silenzio. Cosa faceva Libereso? Ormai aveva passato in rivista tutte le calle. Venne tendendo avanti le mani una nell'altra.
- Apri le mani, - disse. Maria-nunziata tese le mani a conca ma aveva paura a metterle sotto le sue.
- Che hai lì dentro?
- Una bella cosa. Vedrai.
- Fammi vedere, prima.
Libereso schiuse le sue mani e la lasciò guardare dentro. Aveva le mani piene di cetonie: cetonie di tutti i colori. Le più belle erano le verdi, poi ce n'erano di rossicce e di nere, e una anche turchina. E ronzavano, scivolavano una sulla corazza dell'altra e ruotavano le zampine nere in aria. Maria-nunziata si nascose le mani sotto il grembiule.
- Tieni, - disse Libereso, - non ti piacciono?
- Sì, - disse Maria-nunziata, ma teneva sempre le mani sotto il grembiule.
- A stringerle in mano fanno il solletico: vuoi sentire?
Maria-nunziata tese avanti le mani, timidamente, e Libereso ci fece scendere quella cascatella d'insetti di tutti i colori.
- Coraggio. Non mordono.
- Mammamia! - Non aveva pensato che potessero morderla. Aprì le mani e le cetonie lasciate andare in aria aprirono le ali e i bei colori scomparvero e ci fu solo uno sciame di coleotteri neri che volavano e si posavano sulle calle.
- Peccato; io voglio farti un regalo e tu non vuoi.
- Devo andare a rigovernare. Se la signora non mi trova, poi grida.
- Non lo vuoi un regalo?
- Cosa mi regali?
- Vieni.
Continuava a condurla per mano tra le aiuole.
- Devo tornare presto in cucina, Libereso. Poi devo spennare una gallina.
- Puah!
- Perché: puah?
- Noi non mangiamo carne di animali morti.
- Sempre quaresima, fate?
- Come?
- Cosa mangiate?
- Tante cose, carciofi, lattuga, pomodori. Mio padre non vuole che si mangi la carne degli animali morti. E neanche caffè e zucchero.
- E lo zucchero della tessera?
- Lo vendiamo alla borsa nera.
Erano arrivati a una cascata di piante grasse, tutta stellata di fiori rossi.
- Bei fiori, - disse Maria-nunziata. - Ne prendi mai?
- Per fare?
- Per portarli alla Madonna. I fiori servono per portare alla Madonna.
- Mesembrianthemum.
- Cosa?
- Si chiama Mesembrianthemum, questa pianta, in latino. Tutte le piante si chiamano in latino.
- Anche la Messa è in latino.
- Non so.
Libereso stava sbirciando tra il serpeggiare dei rami sulla parete.
- Ecco là, - disse.
- Cos'è?
C'era un ramarro, fermo al sole, verde con disegnini neri.
- Ora lo piglio.
- No.
Ma lui s'avvicinava al ramarro a mani aperte, piano piano, poi uno scatto: acchiappato. Ora rideva contento con il suo riso bianco e marrone. - Guarda che mi scappa! - Dalle mani chiuse ora sgusciava la testina smarrita, ora la coda. Anche Maria-nunziata rideva, ma faceva dei salti all'indietro ogni volta che vedeva il ramarro, e si stringeva la sottana tra i ginocchi.
- Insomma, non vuoi proprio che ti regali nulla? - disse Libereso, un po' mortificato, e piano piano posò su un muretto il ramarro che saettò via: Maria-nunziata teneva gli occhi bassi.
- Vieni con me, - disse Libereso e la riprese per mano.
- A me piacerebbe avere un tubetto di rossetto, e dipingermi le labbra alla domenica per andare a ballare. E poi un velo nero per mettermi sulla testa, dopo, quando si va alla benedizione.
- Alla domenica, - disse Libereso, - vado al bosco con mio fratello e riempiamo due sacchi di pigne. Poi, alla sera, mio padre legge forte dei libri di Eliseo Reclus. Mio padre ha i capelli lunghi fin sulle spalle e la barba fino al petto. E porta i calzoni corti, estate e inverno. E io faccio dei disegni per la vetrinetta della FAI. E quelli col cilindro sono i finanzieri, quelli col cheppì i generali, e quelli col cappello tondo i preti. Poi ci do i colori all'acquarello.
C'era la vasca e tonde foglie di ninfea che galleggiavano.
- Zitta, - fece Libereso.
Sott'acqua si vide la rana che veniva su con scatti e abbandoni delle braccia verdi. A galla, saltò su una foglia di ninfea e ci si sedette in mezzo.
- Ecco, - fece Libereso, e calò una mano per acchiapparla, ma Maria-nunziata fece: - Uh! - e la rana saltò in acqua. Ora Libereso cercava ancora col naso a fior d'acqua.
- Laggiù.
Cacciò sotto una mano e la tirò fuori chiusa a pugno.
- Due in una volta, - disse. - Guarda. Sono due una sopra l'altra.
- Perché, - disse Maria-nunziata.
- Maschio e femmina appiccicati, - disse Libereso, - guarda come fanno.
E voleva mettere le rane in mano a Maria-nunziata. Maria-nunziata non sapeva se aveva paura perché erano rane o perché erano maschio e femmina appiccicati.
- Lasciali stare, - disse, - non bisogna toccare.
- Maschio e femmina, - ripeté Libereso. - Poi fanno i girini.
Una nuvola passava sopra il sole. Improvvisamente Maria-nunziata si disperò.
- É tardi. Certo la signora mi sta cercando.
Ma non se ne andava. Continuavano a girare per il giardino, e non c'era più sole. Fu la volta d'una biscia. Era dietro una siepe di bambù, una piccola biscia, un orbettino. Libereso se la fece arrotolare a un braccio e le carezzava la testina.
- Una volta ammaestravo le bisce, ne avevo una decina, anche una lunga lunga e gialla, di quelle d'acqua. Poi ha cambiato la pelle ed è scappata. Guarda questa che apre la bocca, guarda la lingua tagliata in due. Carezzala, non morde.
Ma Maria-nunziata aveva paura anche delle bisce. Allora andarono alla vaschetta di rocce. Prima le fece vedere gli zampilli, aprì tutti i rubinetti e lei era molto contenta. Poi le mostrò il pesce rosso. Era un vecchio pesce solitario, e già le squame cominciavano a imbianchire. Ecco: il pesce rosso piaceva a Maria-nunziata. Libereso cominciò a girare le mani in acqua per acchiapparlo, era una cosa difficile ma poi Maria-nunziata poteva metterlo in un vasetto e tenerlo anche in cucina. Lo prese, ma non lo tirò fuori dall'acqua per non farlo soffocare.
- Metti le mani giù, carezzalo, - disse Libereso, si sente che respira; ha le pinne come di carta e le scaglie che pungono, ma poco.
Ma Maria-nunziata non voleva carezzare neanche il pesce. In un'aiuola di petunie c'era del terriccio morbido e Libereso ci grattò con le dita e tirò fuori dei lombrichi lunghi lunghi e molli molli.
Maria-nunziata scappò con dei piccoli gridi.
- Poggia la mano qui, - disse Libereso indicando il tronco d'un vecchio pesco. Maria-nunziata non capiva ma ci mise la mano: poi gridò e corse ad immergerla nell'acqua della vasca. L'aveva tirata su piena di formiche. Il pesco era tutto un va e vieni di formiche «argentine» piccolissime.
- Guarda, - disse Libereso e appoggiò una mano al tronco. Si vedevano le formiche che gli salivano su per la mano ma lui non si toglieva.
- Perché? - disse Maria-nunziata. - Perché ti riempi di formiche?
La mano era già nera, già le formiche gli salivano su per il polso.
- Leva la mano, - gemeva Maria-nunziata. - Ti fai montare tutte le formiche addosso.
Le formiche gli salivano sul braccio nudo, erano già al gomito. Ormai tutto il braccio era coperto da un velo di puntini neri che si muovevano; già le formiche gli arrivavano all'ascella ma lui non si scostava.
- Togliti, Libereso, butta il braccio in acqua!
Libereso rideva, qualche formica dal collo gli passava già alla faccia.
- Libereso! Tutto quello che vuoi! Prenderò tutti i regali che mi dài!
Gli buttò le braccia al collo, prese a strofinargli via le formiche.
Allora Libereso staccò la mano dall'albero, ridendo bianco e marrone, e si spolverò il braccio con noncuranza. Ma si vedeva che era rimasto commosso.
- Ebbene, ti farò un grande regalo, ho deciso. Il più gran regalo che posso farti.
- Cosa?
- Un porcospino.
- Mammamia... La signora! La signora che chiama!
Maria-nunziata aveva finito di rigovernare i piatti quando sentì battere un sassolino ai vetri della finestra. Sotto c'era Libereso con una grossa cesta.
- Maria-nunziata, fammi salire. Voglio farti una sorpresa.
- Non puoi salire. Cosa porti lì dentro?
Ma in quel momento la signora suonò e Maria-nunziata scomparve.
Quando tornò in cucina Libereso non c'era. Né dentro, né sotto la finestra. Maria-nunziata s'avvicinò all'acquaio. Allora vide la sorpresa.
Su ogni piatto messo ad asciugare c'era un ranocchio che saltava, una biscia era arrotolata dentro una casseruola, c'era una zuppiera piena di ramarri, e lumache bavose lasciavano scie iridescenti sulla cristalleria. Nel catino pieno d'acqua nuotava il vecchio e solitario pesce rosso.
Maria-nunziata fece un passo indietro ma si vide tra i piedi un rospo, un grosso rospo. Anzi, doveva essere una femmina perché dietro le veniva tutta la nidiata, cinque rospettini in fila, che avanzavano a piccoli balzi sulle piastrelle bianche e nere.
Il primo bagno dell'anno i ragazzi di Piazza dei Dolori lo fecero una domenica d'aprile, col cielo azzurro nuovo nuovo e un sole allegro e giovane. Scesero correndo per i carrugi sventolando le brachette di maglia rattoppate, qualcuno ciabattando già in zoccoli per l'acciottolato, i più senza calze, per non dover faticare a rimettersele sui piedi bagnati. Corsero al molo saltando le reti che si dilungavano per terra e s'alzavano sui piedi nudi e callosi dei pescatori acculati a rammendarle. Tra gli scogli della massicciata si spogliarono, contenti di quell'odore agro di vecchie alghe marcite e di quel volare di gabbiani che cercava di riempire il cielo troppo grande. I vestiti e le scarpe li nascosero nei cavi degli scogli suscitando fughe di giovani granchi; e cominciarono a saltare scalzi e spogliati da uno scoglio all'altro aspettando che uno si decidesse a tuffarsi per primo.
L'acqua era calma ma non limpida, di un denso azzurro con riflessi verdi crudi. Gian Maria detto Mariassa salì in cima a uno scoglio alto e soffiò col pollice sotto il naso in quel suo gesto da pugile.
- Alé, - disse; giunse le mani avanti e si tuffò di testa. Uscì qualche metro più in là, sputando a zampillo e facendo il morto.
- Fredda? - gli chiesero.
- Caldissima, - gridò e si mise a dar bracciate furiose per non gelare.
- Banda! Con me! - disse Cicin che faceva conto d'essere il capo sebbene nessuno gli desse mai retta.
Si tuffarono tutti: Pier Lingera che fece la capriola, Bombolo che prese la panciata, Paulò, Carruba, e per ultimo Menin che dell'acqua aveva una paura maledetta e si tuffò di piedi tenendosi il naso tappato con le dita.
In acqua Pier Lingera che era il più forte fece bere tutti uno per volta, poi tutti si misero d'accordo e insieme fecero bere Pier Lingera.
Allora Gian Maria detto Mariassa propose: - La nave! Andiamo sulla nave!
C'era ancora il bastimento attraverso al porto, affondato durante la guerra dai tedeschi per ostruirlo. Anzi ce n'erano due uno sopra l'altro, quello che si vedeva poggiava sopra uno tutto sommerso.
- Alé, - dissero gli altri.
- Si può montarci sopra? - chiese Menin. - É minato.
- Balle: minato! - disse Carruba. - Quelli dell'Arenella ci montano quando vogliono e ci giocano alla guerra.
Si misero a nuotare verso la nave.
- Banda! Con me! - disse Cicin che voleva fare il capo: ma gli altri andavano più forte di lui e lo lasciarono indietro, eccetto Menin che nuotava a rana ed era sempre l'ultimo.
Arrivarono sotto e il bastimento alzava le murate nere di vecchio catrame, nude e muffite, con le sovrastrutture smantellate contro il cielo azzurro nuovo. Una barba d'alghe putride saliva a ricoprirlo su dalla chiglia e la vecchia vernice si scrostava a grandi segmenti: i ragazzi gli girarono tutt'intorno, poi rimasero sotto la poppa a guardare il nome tutto cancellato: "Abukir, Egypt". C'era la catena dell'ancora, tesa obliqua che ogni tanto oscillava alle acquate della marea, scricchiolando negli enormi anelli rugginosi.
- Non saliamo, - disse Bombolo.
- Ma va', - fece Pier Lingera e già s'era attaccato alla catena, mani e piedi. S'arrampicò come una scimmia e gli altri lo seguirono.
Bombolo a metà scivolò e ribatté di pancia in mare; Menin non riusciva a salire e dovettero venire in due a tirarlo.
A bordo cominciarono a girare in silenzio, per quella nave smantellata, si misero a cercare la ruota del timone, la sirena, i boccaporti, le scialuppe, tutte quelle cose che ci dovevano essere su una nave. Ma questa era una nave squallida come una zattera, coperta solo di sterco bianchiccio di gabbiano. Ce n'erano cinque, di gabbiani, appoggiati a una murata; a sentire i passi scalzi della masnada s'alzarono a volo uno dopo l'altro con gran sbattere d'ali.
- Uhà! - fece il verso Paulò e tirò dietro all'ultimo un bullone raccattato.
- Banda: andiamo dalle macchine! - disse Cicin. Certo giocare in mezzo ai macchinari o nella stiva sarebbe stato più bello.
- Si potrà scendere alla nave che c'è sotto? - chiese Carruba. Questo sarebbe stato bellissimo: stare là sotto, tutti chiusi, con il mare intorno e sopra come in un sottomarino.
- Quella di sotto è minata! - disse Menin.
- Sei tu, minato! - gli dissero.
Presero giù da una scaletta. Fatti pochi gradini si fermarono: ai loro piedi cominciava l'acqua nera, e sciabordava nel chiuso. I ragazzi di Piazza dei Dolori guardavano fermi e in silenzio; in fondo a quell'acqua, un luccichio nero di aculei: colonie di ricci che divaricavano lenti le spine. E le pareti tutt'intorno erano incrostate di patelle dal guscio barbuto d'alghe verdi, abbarbicate al ferro delle pareti che sembrava roso. E c'era un brulicare di granchi ai margini dell'acqua, migliaia di granchi di tutte le forme e di tutte le età che ruotavano sulle zampe curve e raggiate, e digrignavano le chele, e sporgevano gli occhi senza sguardo. Il mare sciacquava sordo nel quadrato delle mura di ferro, lambendo quelle piatte pance di granchio. Forse tutta la stiva della nave era piena di granchi brancolanti e un giorno la nave si sarebbe mossa sulle zampe dei granchi e avrebbe camminato per il mare.
Risalirono sopracoperta, a prua. Allora videro la bambina. Non l'avevano vista prima, pure sembrava fosse sempre stata lì. Era una bambina sui sei anni, grassa, con i capelli lunghi e ricci. Era tutta abbronzata e aveva indosso solo le mutandine bianche. Non si capiva da che parte fosse arrivata. Non li guardò nemmeno. Era tutta attenta a una medusa capovolta sull'impiantito di legno, con i festoni mollicci dei tentacoli sparpagliati intorno. La bambina con uno stecco cercava di rimetterla con la calotta in alto.
I ragazzi di Piazza dei Dolori le si fermarono intorno, a bocca aperta. Mariassa si fece avanti per primo. Tirò su dal naso.
- Chi sei? - disse.
La bambina alzò gli occhi celesti nella faccia paffuta e scura; poi riprincipiò a far leva con lo stecco sotto la medusa.
- Dev'essere della banda dell'Arenella, - disse Carruba che era pratico.
I ragazzi dell'Arenella avevano delle bambine che venivano con loro a nuotare e a giocare al pallone, e anche a far la guerra con le canne.
- Tu, - disse Mariassa, - sei nostra prigioniera.
- Banda! - fece Cicin. - Prendetela viva!
La bambina continuava a manovrare la medusa.
- Allarmi! - gridò Paulò che s'era voltato indietro per caso. - La banda dell'Arenella!
Mentre loro stavano attenti alla bambina, i ragazzi dell'Arenella che passavano in acqua le giornate erano arrivati nuotando sott'acqua, erano saliti in silenzio per la catena dell'ancora, erano apparsi scavalcando quatti le murate. Erano ragazzi bassi e tarchiati, soffici come gatti, coi capelli rasi, la pelle scura. Le loro brache non erano nere e lunghe e cascanti come quelle dei ragazzi dei Dolori, ma fatte solo di una striscia di tela bianca.
Cominciò la lotta; i ragazzi di Piazza dei Dolori erano magri e tutti nervi, tranne Bombolo che era un pancione, ma avevano una rabbia fanatica nel picchiarsi, agguerrita dalle lunghe zuffe nei piccoli carrugi della città vecchia contro le bande di San Siro e dei Giardinetti. Quelli dell'Arenella ebbero il sopravvento in principio per via della sorpresa, ma poi quelli dei Dolori si abbarbicarono alle scalette e di lì non ci fu verso di spostarli, perché non volevano a nessun costo lasciarsi trasportare alle murate, dove era facile farsi sbattere a bagno. Alla fine Pier Lingera che era più forte dei compagni e anche più vecchio, e veniva con loro solo perché era ripetente, riuscì a far arretrare uno dell'Arenella fino ai bordi e a spingerlo giù in mare.
Allora quelli dei Dolori passarono all'offensiva: quelli dell'Arenella, che si sentivano più nel loro in acqua e, gente pratica, non avevano puntigli d'onore per la testa, uno dopo l'altro sfuggirono ai nemici e si tuffarono.
- Venite a prenderci in acqua, se avete coraggio, - gridarono.
- Banda! Con me! - urlò Cicin e già stava per tuffarsi.
- Sei scemo? - lo trattiene Mariassa. - In acqua l'hanno vinta come vogliono! - E prese a gridare insolenze ai fuggiaschi.
Quelli dell'Arenella cominciarono a tirare acqua da sotto; e la tiravano tanto forte che non c'era posto sulla nave dove non arrivassero le loro acquate. Alla fine si stancarono e presero il largo a testa bassa e braccia arcuate, rialzandosi ogni tanto per respirare con piccoli schizzi.
Quelli di Piazza dei Dolori erano rimasti padroni del campo. Andarono a prua: la bambina era sempre lì. Era riuscita a voltare la medusa e ora cercava di sollevarla sullo stecco.
- Ci hanno lasciato un ostaggio! - fece Mariassa.
- Banda! Un ostaggio! - s'eccitò Cicin.
- Vigliacchi! - gridò Carruba dietro ai fuggiaschi. - Lasciare le donne in mano ai nemici!
Avevano un senso dell'onore molto spiccato, a Piazza dei Dolori.
- Vieni con noi, - disse Mariassa e fece per metterle una mano su una spalla.
La bambina gli fece cenno di star fermo: stava per riuscire a sollevare la medusa. Mariassa si chinò a guardare. Allora la bambina tirò su lo stecco, con la medusa in bilico sopra, lo tirò su, lo tirò su, sbatté la medusa in faccia a Mariassa.
- Porca! - gridò Mariassa sputando e premendosi la faccia.
La bambina guardava tutti e rideva. Poi si voltò, andò proprio in cima alla prua, alzò le braccia congiungendo la punta delle dita, si tuffò ad angelo, e nuotò via senza voltarsi. I ragazzi di Piazza dei Dolori non si erano mossi.
- Di', - chiese Mariassa, palpandosi una guancia. - É vero che le meduse fanno bruciare tutta la pelle?
- Aspetta e lo saprai, - fece Pier Lingera. - Però è meglio che ti tuffi subito.
- Alé, - disse Mariassa, avviandosi con gli altri.
Poi si fermò: - D'ora in avanti dobbiamo avere una donna anche noi nella banda! Menin! Farai venire tua sorella!
- Mia sorella è scema, - disse Menin.
- Non importa, - disse Mariassa, - alé, - e diede uno spintone a Menin buttandolo a mare, perché tanto a tuffarsi non era capace. Poi si tuffarono tutti.
Giovannino e Serenella camminavano per la strada ferrata. Giù c'era un mare tutto squame azzurro cupo azzurro chiaro; su, un cielo appena venato di nuvole bianche. I binari erano lucenti e caldi che scottavano. Sulla strada ferrata si camminava bene e si potevano fare tanti giochi: stare in equilibrio lui su un binario e lei sull'altro e andare avanti tenendosi per mano, oppure saltare da una traversina all'altra senza posare mai il piede sulle pietre. Giovannino e Serenella erano stati a caccia di granchi e adesso avevano deciso di esplorare la strada ferrata fin dentro la galleria. Giocare con Serenella era bello. perché non faceva come tutte le altre bambine che hanno sempre paura e si mettono a piangere a ogni dispetto: quando Giovannino diceva: - Andiamo là, - Serenella lo seguiva sempre senza discutere.
Deng! Sussultarono e guardarono in alto. Era il disco di uno scambio ch'era scattato in cima a un palo. Sembrava una cicogna di ferro che avesse chiuso tutt'a un tratto il becco. Rimasero un po' a naso in su a guardare: che peccato non aver visto! Ormai non lo faceva più.
- Sta per venire un treno, - disse Giovannino.
Serenella non si mosse dal binario. - Da dove? chiese.
Giovannino si guardò intorno, con aria d'intendersene. Indicò il buco nero della galleria che appariva ora limpido ora sfocato, attraverso il tremito del vapore invisibile che si levava dalle pietre della strada.
- Di lì, - disse. Sembrava già di sentirne lo sbuffo incupito dalla galleria e vederselo tutt'a un tratto addosso, scalpitante fumo e fuoco, con le ruote che mangiavano i binari senza pietà.
- Dove andiamo, Giovannino?
C'erano grandi agavi grige, verso mare, con raggere di aculei impenetrabili. Verso monte correva una siepe di ipomea, stracarica di foglie e senza fiori. Il treno non si sentiva ancora: forse correva a locomotiva spenta senza rumore e sarebbe balzato su di loro tutt'a un tratto. Ma già Giovannino aveva trovato un pertugio nella siepe. - Di là.
La siepe sotto il rampicante era una vecchia rete metallica cadente.
In un punto, s'accartocciava su da terra come un angolo di pagina. Giovannino era già sparito per metà e sgusciava dentro.
- Dammi una mano, Giovannino!
Si ritrovarono in un angolo di giardino, tutt'e due carponi in un'aiola, coi capelli pieni di foglie secche e di terriccio. Tutto era zitto intorno; non muoveva una foglia.
- Andiamo, - disse Giovannino e Serenella disse: - Sì.
C'erano grandi e antichi eucalipti color carne, e vialetti di ghiaia. Giovannino e Serenella camminavano in punta di piedi pei vialetti, attenti al fruscio della ghiaia sotto i passi. E se adesso arrivassero i padroni?
Tutto era così bello: volte strette e altissime di foglie ricurve d'eucalipto e ritagli di cielo; restava solo quell'ansia dentro, del giardino che non era loro e da cui forse dovevano esser cacciati tra un momento. Ma nessun rumore si sentiva. Da un cespo di corbezzolo, a una svolta, s'alzò un volo di passeri, con gridi. Poi ritornò silenzio. Era forse un giardino abbandonato?
Ma l'ombra dei grandi alberi a un certo punto finiva e si trovarono sotto il cielo aperto, di fronte ad aiole tutte ben ravviate di petunie e convolvoli, e viali e balaustrate e spalliere di bosso. E sull'alto del giardino, una grande villa coi vetri lampeggianti e tende gialle e arancio.
E tutto era deserto. I due bambini venivano su guardinghi calpestando ghiaia: forse le vetrate stavano per spalancarsi tutt'a un tratto e signori e signore severissimi per apparire sui terrazzi e grossi cani per essere sguinzagliati per i viali. Trovarono vicino a una cunetta una carriola. Giovannino la prese per le staffe e la spinse innanzi: aveva un cigolo, a ogni giro di ruota, come un fischio. Serenella ci si sedette sopra e avanzavano zitti, Giovannino spingendo la carriola con lei sopra, fiancheggiando le aiole e i giochi d'acqua.
- Quello, - diceva Serenella a bassa voce di tanto in tanto, indicando un fiore. Giovannino poggiava e andava a strapparlo e glielo dava. Ne aveva già dei belli in un mazzetto. Ma scavalcando le siepi per scappare, forse li avrebbe dovuti buttar via!
Così arrivarono a uno spiazzo e finiva la ghiaia e c'era un fondo di cemento e mattonelle. E in mezzo a questo spiazzo s'apriva un grande rettangolo vuoto: una piscina. Ne raggiunsero i margini: era a piastrelle azzurre, ricolma d'acqua chiara fino all'orlo.
- Ci tuffiamo? - chiese Giovannino a Serenella. Certo doveva essere assai pericoloso se lui chiedeva a lei e non diceva soltanto: - Giù! - Ma l'acqua era così limpida e azzurra e Serenella non aveva mai paura. Scese dalla carriola e vi depose il mazzolino. Erano già in costume da bagno: erano stati a cacciar granchi fino allora. Giovannino si tuffò: non dal trampolino perché il tonfo avrebbe fatto troppo rumore, ma dall'orlo. Andò giù giù a occhi aperti e non vedeva che azzurro, e le mani come pesci rosa; non come sotto l'acqua del mare, piena d'ombre informi verdi-nere. Un'ombra rosa sopra di sé: Serenella! Si presero per mano e riaffiorarono all'altro capo, un po' con apprensione. No, non c'era proprio nessuno ad osservarli. Non era bello come s'immaginavano: rimaneva sempre quel fondo d'amarezza e d'ansia, che tutto questo non spettava loro e potevano esserne di momento in momento, via, scacciati.
Uscirono dall'acqua e proprio lì vicino alla piscina trovarono un tavolino col ping-pong. Giovannino diede subito un colpo di racchetta alla palla: Serenella fu svelta dall'altra parte a rimandargliela. Giocavano così, dando bòtte leggere perché da dentro alla villa non sentissero. A un tratto un tiro rimbalzò alto e Giovannino per pararlo fece volare la palla via lontano; batté sopra un gong sospeso tra i sostegni d'una pergola, che vibrò cupo e a lungo. I due bambini si rannicchiarono dietro un'aiola di ranuncoli. Subito arrivarono due servitori in giacca bianca, reggendo grandi vassoi, posarono i vassoi su un tavolo rotondo sotto un ombrellone a righe gialle e arancio e se ne andarono.
Giovannino e Serenella s'avvicinarono al tavolo. C'era tè, latte e pan-di-Spagna. Non restava che sedersi e servirsi. Riempirono due tazze e tagliarono due fette. Ma non riuscivano a stare ben seduti, si tenevano sull'orlo delle sedie, muovendo le ginocchia. E non riuscivano a sentire il sapore dei dolci e del tè e latte. Ogni cosa in quel giardino era così: bella e impossibile a gustarsi, con quel disagio dentro e quella paura, che fosse solo per una distrazione del destino, e che presto sarebbero chiamati a darne conto.
Quatti quatti, si avvicinarono alla villa. Di tra le stecche d'una persiana a griglia videro, dentro, una bella stanza ombrosa con collezioni di farfalle alle pareti. E in questa stanza c'era un pallido ragazzo. Doveva essere il padrone della villa e del giardino, lui fortunato. Era seduto su una sedia a sdraio e sfogliava un grosso libro con figure. Aveva mani sottili e bianche e un pigiama accollato benché fosse estate.
Ora, ai due bambini, spiandolo tra le stecche, si spegneva a poco a poco il batticuore. Infatti quel ragazzo ricco sembrava sedesse e sfogliasse quelle pagine e si guardasse intorno con più ansia e disagio di loro. E s'alzasse in punta di piedi come se temesse che qualcuno, di momento in momento, potesse venire a scacciarlo, come se sentisse che quel libro, quella sedia a sdraio, quelle farfalle incorniciate ai muri e il giardino coi giochi e le merende e le piscine e i viali, erano concessi a lui solo per un enorme sbaglio, e lui fosse impossibilitato a goderne, ma solo provasse su di sé l'amarezza di quello sbaglio, come una sua colpa.
Il ragazzo pallido girava per la sua ombrosa stanza con passi furtivi, accarezzava i margini delle vetrine costellate di farfalle con le bianche dita, e si fermava in ascolto. A Giovannino e Serenella il batticuore spento riprendeva ora più fitto. Era la paura di un incantesimo che gravasse su quella villa e quel giardino, su tutte quelle cose belle e comode, come un'antica ingiustizia commessa.
Il sole s'oscurò di nuvole. Zitti zitti Giovannino e Serenella se ne andarono. Rifecero la strada pei vialetti, di passo svelto, ma senza mai correre. E traversarono carponi quella siepe. Tra le agavi trovarono un sentiero che portava alla spiaggia, breve e sassosa, con cumuli d'alghe che seguivano la riva del mare. Allora inventarono un gioco bellissimo: battaglia con le alghe. Se ne tirarono manciate in faccia uno con l'altra fino a sera. C'era di buono che Serenella non piangeva mai.
Non gela, da noi, di solito: soltanto alla mattina i cespi d'insalata si svegliano intirizziti, un po' lividi, e la terra fa una crosta grigia, quasi lunare, che risponde sorda alla zappa. Al piede degli alberi, a dicembre, la terra comincia a pigmentarsi di foglioline gialle che a poco a poco la coprono come una trapunta leggera. L'inverno è più trasparenza d'aria che freddo; e in quell'aria sui rami scheletriti s'accendono centinaia di lampadine rosse: i cachi.
Quell'anno il piccolo frutteto sembrava un seguito di venditori di palloncini, col loro carico sospeso in aria: nove su quel ramo biforcuto, sei su quell'altro storto, là in cima sembrava che ne mancassero, ma forse era il vuoto delle foglie cadute, quelli verso mezzogiorno erano più rossi, sarebbero maturati prima Così Pipin il Maiorco ogni mattina passava in rivista i suoi otto alberi, controllando se mancassero dei frutti, pesando con gli occhi il carico dei rami, convertendo mentalmente il carico in denaro, immaginandosi il denaro appeso ai rami nudi al posto dei frutti: bisunti, sventolanti fogli da cento e da mille, e non purtroppo dischetti d'argento e d'oro che avrebbero luccicato sui rami.
Migliori della carta, le monete, ad averle, adatte anche a venir sotterrate a piè d'un muro in una piccola giarra, invece d'ammuffire e andare in bocca ai topi. Ma, argento o carta, il giro finiva sempre lì, al denaro, poteva ancora girare, trasformarsi in fosfato, in cianamide, diventare succo della terra, forza che sale su per le radici, dolce di pomodori, amaro di carciofi: poi, inevitabilmente, tornare lì, al denaro.
- Allegria, Maiorco, vedrai, finita la guerra, i soldi italiani a quanto andranno! - Chi parlava così era Saltarel, il veneto che stava alle case del Paraggio, passando per la mulattiera, a lui che zappettava le fasce di sopra. Pipin smetteva di zappettare e drizzava verso di lui la barbetta grigiastra come un colombo: - Dici sul serio, Venessia? - L'altro si metteva a sghignazzare e a parlar veneto, spiegando per che uso sarebbero serviti i soldi; il Maiorco restava accoccolato a terra, deluso, facendo gesti smarriti di protesta. Si poteva capire la fillossera che intisica le viti, la mosca che rattrappisce le olive, la lumaca che trafora la lattuga, ma i soldi, i soldi del governo che bestia poteva roderli per non farli valere più niente. Già c'erano, a insidiare i raccolti, tarli che mangiano le radici, cocciniglie e lumache sulle foglie, cetonie nei fiori, bruchi nei frutti; non ci mancava altro che questa bestia misteriosa che poteva rovinare i raccolti più ricchi, salvati con mille attenzioni, quand'erano già stati venduti nel denaro! I "venessia" erano gente grama e vagabonda, emigrati da quelle parti negli anni della crisi, gente che prima o poi sarebbe tutta finita in città a far gli spazzini, come i «napoletani», cioè gli abruzzesi, loro compari: per questo parlavano così.
Troppe erano già le bestie che s'inframmettevano tra Pipin il Maiorco e i frutti della sua terra: e la più insidiosa era una bestia contro la quale non valevano insetticidi e veleni, una bestia notturna dalle mani d'uomo e dal passo di lupo: i ladri. Le campagne formicolavano di ladri: gente vagabonda senza terra e senza lavoro. Là, dai cachi, c'era certo passato qualcuno nella notte, un estraneo, calpestando le file dell'aglio: Pipin scrutava gli alberi ramo per ramo, inquieto. Ecco, sul quinto albero, un ramo intero, carico, per strappare un frutto, un ramo carico di frutti ancora acerbi, per strappare un frutto ancora acerbo, là, spezzato, che pendeva a terra. - Tron di Dio! - urlò il Maiorco alzando i pugni verso le case del Paraggio alte sulla collina, una fila di case a un piano color muffa, come i villaggi di sughero dei presepi, che sembrava stessero per diroccare giù per la valle, solo che lui avesse urlato un po' più forte.
Il Maiorco passò al Paraggio col ramo spezzato in mano come un bastone, con tutti i cachi appes 929e43j i, battendolo forte per terra perché lo sentissero. Si fece alla porta la moglie di Saltarel, con la faccia rossa e senza denti: - Vi siete fatto già l'albero di Natale, Pipin? Guardate che ci vuole un pino, non un caco.
Al Maiorco la punta dei baffi vibrava come ai gatti.
- Se piglio chi viene nel mio a rubarmi i cachi, - disse, - gli sparo! Stanotte carico lo schioppo a pallini e a sale!
Uscì il più vecchio dei «venessia»: Cocianci.
- Giacché ci sei mettici anche l'olio, Maiorco, disse, - così te lo cucini in insalata.
E tutti i veneti, sulle porte delle catapecchie, presero a sghignazzare dietro al Maiorco che s'allontanava imprecando.
Fossero stati abbastanza coloriti da poterli cogliere e farli maturare in casa; ma no, bisognava lasciarli ancora sulle piante, alla mercé di quella gente che aveva il vizio del rubare nelle ossa come la fame, che strappava i rami per poi magari spiaccicarli in terra appena morsi, sentendoli aspri.
Bisognava fare la guardia ai cachi la notte, col fucile: Pipin ci sarebbe stato dal tramonto a mezzanotte, sua moglie gli avrebbe dato il cambio da mezzanotte all'alba.
Pipin e la moglie stavano in un casolare tappezzato di fuliggine, addobbato di trecce d'aglio, con gabbie di conigli intorno invece che vasi da fiori. Bastianina la Maiorca lavorava duro come il marito, rivoltava la terra col tridente dopo che lui l'aveva rotta col magaglio, tutt'e due con la faccia e le braccia color marrone come la terra rivoltata: lei scarmigliata, con un vestito che sembrava un sacco, i piedi negli scarponi; lui scalzo, il panciotto sdrucito sul torso nudo lanuginoso come un cactus, il pizzo e i baffi che sembravano un colombetto grigio posato su quella faccia rattrappita dalle rughe.
Le fasce dei cachi erano oltre la mulattiera, in un posto umido e ombroso sopra un ruscello. Il Maiorco ci arrivò già al buio col fucilaccio ad avancarica, che quarant'anni prima gli aveva fatto centrare una volpe. Nel buio gli alberi sembravano enormi uccelli appollaiati su una gamba sola. A distinguere i rami carichi di frutti sotto il tiro del suo fucile, Pipin provò un senso di dolce sicurezza come da bambino a un giocattolo sotto il guanciale.
Lo scorrere del ruscello smerigliava il silenzio; le distanze, nel buio, erano solo l'abbaiare di cani lontani. Ad abituare l'orecchio si potevano distinguere rumori di risa e canti dalle case dei veneti, al Paraggio; ad abituare l'occhio si poteva scorgere lassù il chiarore dei fuochi accesi della veglia. I veneti cantavano e ballavano, la notte: la grassa nipote di Cocianci si metteva a ballare a sottane al vento mentre tutti gli uomini battevano il tempo con le mani. Poi il vecchio Cocianci l'abbracciava, stando seduto, alle cosce: tante cose schifose avvenivano la notte, dai veneti: Saltarel s'ubriacava e frustava la moglie ogni notte dicendo che era una cavalla e la moglie non voleva mai andare dai carabinieri a mostrare i lividi. A una cert'ora, appena smorzavano i canti, i veneti uscivano strisciando verso le fasce del Maiorco: ecco che eran tutti sul muro sopra di lui, che gli saltavano addosso; la grassa di Cocianci cominciava a ballargli davanti a cosce nude, mentre il vecchio gli rubava i cachi. Alt, guai a cominciare un sogno da svegli: subito si casca addormentati. Stare a occhi e orecchi tesi, invece: il vento che s'alzava tra le canne del ruscello poteva essere un ladro che s'avvicinava. No: lassù i canti e le risa continuavano, tutto era deserto e fermo.
Pipin si sentiva terribilmente solo, a volte, su quei pezzi di terra sua, in mezzo a bestie, bestie sopra, sotto, intorno a lui che volevano mangiargli la campagna con lui dentro: sotto terra era pieno di lombrichi, sulla terra di topi, in cielo non c'erano che passeri; poi agenti delle tasse, speculatori sui concimi, ladri. Di fronte alla terra provava un vago senso d'impotenza, come di non riuscire a possederla mai del tutto, come quando si sogna di possedere una donna e non ci si riesce. Una grande macina nera, la terra, che disfa e trasforma tutto, con succhi misteriosi che salgono dalle zolle su per le radici, fino a gonfiare i cachi di zucchero e tannino in cima ai rami; una macina di zolle che continua giù giù all'infinito, sempre sua, fino al centro del mondo dove comincia l'altra piramide di terra dell'altro Pipin Maiorco degli antipodi. Pipin Maiorco avrebbe voluto immergersi nella terra con tutto il corpo, respirarla, portarci tutto il suo denaro in una giarra, e la sua casa, tutta la sua roba, i conigli, la moglie; così si sarebbe sentito sicuro. Vivere sottoterra, avrebbe voluto, nella terra calda e nera di quando lui arrivava profondo col magaglio. Ma questi erano pensieri da addormentati, lui dormiva.
La notte senza luna sembrava fermata in mezzo al tempo. Non arrivava mai la mezzanotte? Forse sua moglie non s'era svegliata e l'avrebbe lasciato là fino al mattino. Pipin si scosse, andò sotto ogni albero a guardare i frutti come se mentr'era mezz'addormentato avessero potuto rubarglieli di sotto al naso. Ma forse, mentre passava con lo sguardo dal primo al secondo, al terzo albero di cachi, una scimmia mano a mano saltava da un albero all'altro e metteva i frutti in un sacco, non vista. Erano cento scimmie nascoste tra i rami di tutti gli alberi, scimmie schifose, senza peli, con la faccia sghignazzante di Saltarel, che gli facevano le beffe.
Ecco un lume che s'avvicinava per i campi: era vero o era uno scherzo delle scimmie? Bisognava svegliarsi o sparargli? - Pipin! Pipin! - La voce di sua moglie, piano. - Bastiana! - Era il cambio, lei che arrivava con la lanterna; Pipin le passò il fucile e andò a dormire.
La Maiorca portava il fucile come un soldato camminando avanti e indietro per la fascia. Aveva occhi gialli, la notte, come un gufo: anche se fosse venuto il diavolo a farle paura lei avrebbe capito che si trattava d'un cespuglio. A un tratto vide una pietra che si muoveva balzelloni sul sentiero. La toccò col piede: era molle come carne. Un rospo, era: si stettero un po' a guardare, la donna e il rospo, poi quello continuò da una parte e lei da un'altra.
L'indomani Bastianina disse che il secondo turno era più duro e che quella notte le spettava il primo. Pipin accettò; a svegliarlo a mezzanotte venne lei e lo buttò dal letto. Andando, mentre chiudeva dietro a sé il cancelletto che dava alla fascia dei cachi, Pipin sentì un passo per la mulattiera; chi girava per le campagne, a quell'ora? Era Saltarel.
- Maiorco, fai la posta al gufo, a quest'ora con lo schioppo?
- Al gufo, sì, - rispose il Maiorco, - al gufo che mi becca i cachi.
«Così lo sanno, - pensò, - e non verranno stanotte».
- Ma tu donde vieni, a quest'ora, Venessia?
- Da comprare olio. Domani andiamo col Cocianci in Piemonte e portiamo giù riso.
S'erano messi a far la borsa nera, i veneti.
- Buoni affari, Venessia.
- In bocca al gufo, Maiorco.
A tender l'orecchio dalla fascia dei cachi tutto era silenzio. Anche alle case dei veneti, non una luce, né una voce. Saltarel non frustava sua moglie, quella notte; ma forse in quel momento il vecchio Cocianci era a letto con la nipote grassa. Pipin pensò al suo letto ancora caldo, con Bastiana che già russava. Non sarebbero venuti, quella notte, sapevano che si faceva la guardia, poi al mattino dovevano partire presto per il Piemonte. Ecco: Pipin sarebbe tornato a dormire, facendo piano per non svegliare la moglie, poi appena prima dell'alba sarebbe venuto a dare un'occhiata.
Andò a casa, si cacciò tra le lenzuola, piano piano, accanto alla moglie che avrebbe russato anche se ci si fosse coricato un cavallo. Ma non riusciva a prender sonno; cosa sarebbe successo se non si fosse svegliato all'alba e la moglie l'avesse trovato a letto? E se fossero venuti degli altri ladri? A un tratto gli venne il dubbio d'aver lasciato aperto il cancelletto: Saltarel l'aveva visto mentre lo chiudeva, i veneti giravano tutta la notte come gatti, se lo trovavano aperto avrebbero capito che se n'era andato. Pipin non riusciva a chiuder occhio: era un tormento stare in letto così, senza neanche potersi rigirare per paura di svegliare la moglie, mentre i ladri camminavano per la sua campagna. Perché allora non s'alzava, non andava a vedere? Già il cielo cominciava a schiarire, al primo canto di gallo si sarebbe alzato. Ma ecco, per la mulattiera, rumore di passi che scendevano: chi mai, a quell'ora? Cocianci e Saltarel di certo, che partivano per il Piemonte. Passi quasi di corsa, pesanti: dovevano essere carichi, carichi di recipienti d'olio, carichi di ceste di cachi rubati allor allora, che andavano a vendere in Piemonte! Pipin si buttò fuori dal letto, prese il fucile, uscì.
Il cancelletto: chiuso; respirò. Avvicinandosi alla fascia però non riusciva a scorgere il rosso dei frutti; erano gli altri alberi che l'impedivano, le canne, gli olivi. Ora, girato questo muro, ecco che avrebbe visto, che si sarebbe rassicurato. Girò il muro. C'era una sensazione di vuoto, intorno. La barba e i baffi, colombetto grigio, gli frullarono come stessero per prendergli il volo dalla bocca. Nell'aria livida dell'alba, gli alberi alzavano al cielo una ragnatela di rami nudi. Neanche un frutto era rimasto appeso. - Tron di Dio! - urlò l'uomo a pugni alzati nella fascia.
A casa la Maiorca stava alzandosi.
- Pipin, hai fatto buona guardia?
Pipin si sedette su uno sgabello col fucile ancora a tracolla, a capo chino.
- Che hai, Pipin, che non rispondi?
Pipin stava zitto, non alzava il capo.
- Quanto pensi che vadano quest'anno i cachi, sul mercato?
«Bisogna farla tacere», pensava Pipin.
- Quanto credi che faremo?
Pipin s'alzò. Prese un legno di quelli per stringere le corde del basto
- Io dico che ne riempiremo trenta ceste, - continuava la donna.
Pipin vide il palo della porta, lasciò il legno del basto e prese il palo.
- Una annata così non l'abbiamo mai avuta, vero Pipin?
Allora Pipin il Maiorco cominciò a picchiarla.
Pochi buoi, dalle nostre parti. Non ci son prati da pascolare, né campi grandi da essere arati: ci son solo sterpi da brucare e brevi strisce di una terra che non si rompe se non si zappa. Poi stonerebbero, i buoi e le mucche, larghi e placidi come sono, in queste valli strette e dirupate; qui ci vogliono bestie magre, tutte tendini, che camminino su per i sassi: muli e capre.
Il bue degli Scarassa era l'unico della vallata, e non stonava, era più forte e docile di un mulo, un piccolo bue tozzo, tarchiato, da carico; Morettobello, si chiamava. I due Scarassa, padre e figlio, si guadagnavano la vita col bue, facendo viaggi per i vari proprietari della vallata, portando i sacchi di frumento al mulino, o le foglie di palma agli spedizionieri, o i sacchi di concime dal consorzio.
Quel giorno Morettobello dondolava sotto il carico bilanciato alle due parti del basto: legna d'ulivo spaccata da vendere a un cliente in città. Dall'anello infilzato nelle narici nere e molli la corda lenta da toccar terra finiva nelle mani ciondolanti di Nanin, figlio di Battistin Scarassa, allampanato e macilento come il padre. Erano una strana coppia: il bue con le gambe corte, la pancia bassa e larga, come un rospo, faceva passi prudenti, sotto il carico; lo Scarassa, con la faccia lunga e ispida di peli rossi, i polsi scoperti dalle maniche troppo corte, buttava avanti i passi che sembrava avesse due ginocchi in ogni gamba, sotto i pantaloni che quando tirava vento s'agitavano come vele, come se non ci fosse dentro nessuno.
C'era la primavera, quel mattino; cioè c'era nell'aria quel senso improvviso di scoperta che si prova tutti gli anni, un mattino, quel ricordarsi una cosa come dimenticata da mesi. Morettobello, di solito così tranquillo, era inquieto. Già Nanin, al mattino, cercandolo nella stalla non l'aveva trovato; era in mezzo al campo che girava intorno gli occhi sperduti. Ora, andando, Morettobello si fermava ogni tanto, alzava le narici infilzate dall'anello, annusava l'aria con un breve muggito. Nanin dava uno strappo alla corda e una voce gutturale di quel linguaggio che s'usa tra gli uomini e i buoi.
Morettobello sembrava ogni tanto preso da un pensiero: aveva fatto un sogno, quella notte, perciò era uscito dalla stalla e quel mattino si trovava sperduto nel mondo. Aveva sognato cose dimenticate, come d'un'altra vita: grandi pianure erbose e vacche, vacche, vacche a perdita d'occhio che avanzavano muggendo. E aveva visto anche se stesso, là in mezzo, a correre nella torma delle vacche come cercando. Ma c'era qualcosa che lo tratteneva, una tenaglia rossa conficcata nelle sue carni, che gl'impediva di traversare quella torma. Al mattino, andando, Morettobello sentiva la ferita rossa della tenaglia ancora viva su di sé, come una disperazione ineffabile nell'aria.
Per le strade non si vedevano che bambini vestiti di bianco con al braccio la fascia frangiata d'oro, e bambine vestite da sposa: era il giorno della cresima. Al vederli qualcosa si oscurò in fondo all'animo di Nanin, come un'antica, furiosa paura. Era forse perché suo figlio e sua figlia non avrebbero mai avuto quegli abiti bianchi per la cresima? Certo, dovevano costare molto. Allora gli prese una rabbia, una smania, di far fare la cresima ai suoi figlioli: vedeva già il maschietto con l'abito bianco alla marinara e la fascia al braccio con la frangia d'oro, la femmina col velo e lo strascico nella chiesa tutta ombre e luccichio.
Il bue sbuffò: ricordava il sogno, vedeva la mandria di vacche galoppanti, come in una zona fuori della sua memoria, e lui che proseguiva in mezzo a loro sempre più a fatica. A un tratto in mezzo alla torma delle vacche, su una piccola altura, rosso come il dolore della ferita, era apparso il grande toro, dalle corna come falci che toccavano il cielo, che si gettava contro di lui muggendo.
I bambini della cresima, sul piazzale della chiesa, presero a correre intorno al bue. - Un bue! Un bue! - gridavano. Era una vista insolita un bue, da quelle parti. I più coraggiosi si azzardavano fino a toccargli la pancia, i più esperti gli guardavano sotto la coda: - É castrato! Guardatelo! É castrato! - Nanin si mise a urlare, a dar manate in aria per mandarli via. Allora i bambini vedendolo così allampanato, macilento e rattoppato, cominciarono a fargli il verso e a canzonarlo col suo soprannome: - Scarassa! Scarassa! - che vuol dire palo da vigna.
Nanin sentiva quella antica paura farglisi più viva, più angosciosa. Vedeva altri ragazzi vestiti da cresima che lo canzonavano, che canzonavano non lui ma suo padre, macilento, allampanato e rattoppato come lui, il giorno che l'aveva accompagnato a cresimarsi. E risentì viva come allora quella vergogna che aveva provato per suo padre, al vedere i ragazzi che gli saltavano intorno e gli buttavano addosso i petali di rosa calpestati dalla processione, chiamandolo: «Scarassa». Quella vergogna l'aveva accompagnato per tutta la vita, l'aveva riempito di paura a ogni sguardo, a ogni riso. Ed era tutto colpa di suo padre; cosa aveva ereditato da suo padre più che miseria, stupidità, goffaggine della persona allampanata? Egli odiava suo padre, ora lo comprendeva, per quella vergogna fattagli provare da ragazzo, per tutta la vergogna, la miseria della sua vita. E gli venne paura in quel momento che i suoi figli si sarebbero vergognati di lui come lui del padre, che un giorno l'avrebbero guardato con l'odio che era in quel momento nei suoi occhi. Decise: «Mi comprerò anch'io un vestito nuovo, per il giorno della loro cresima, un vestito a quadretti, di flanella. E un berretto di tela bianca. E una cravatta di colore. E anche mia moglie dovrà comprarsi un vestito nuovo, di stoffa, grande che le stia anche quando è incinta. E andremo tutti insieme ben vestiti nella piazza della chiesa. E compreremo il gelato al carretto del gelataio». Ma gli restava una smania che non sapeva come esaurire, dopo aver comprato il gelato, aver girato per la fiera vestito a festa, una smania di fare, di spendere, di mostrarsi, di riscattarsi da quella infantile vergogna paterna che l'aveva accompagnato nella vita.
Arrivato a casa, portò il bue nella stalla e gli tolse il basto. Poi andò a mangiare; la moglie e i bambini e il vecchio Battistin erano già a tavola che trangugiavano una minestra di fave. Il vecchio Scarassa, Battistin, pescava le fave con le dita e le succhiava buttando via la pellicola. Nanin non stava attento ai loro discorsi.
- Bisogna che i bambini facciano la cresima, - disse. La moglie alzò verso di lui la faccia smunta e spettinata.
- E i soldi per vestirli? - chiese.
- Dovranno avere dei bei vestiti, - continuò Nanin senza guardarla. -
Il maschio alla marinara, bianco, con la frangia d'oro al braccio, la femmina da sposa, con lo strascico e il velo.
Il vecchio e la moglie lo guardavano a bocca aperta.
- E i soldi? - ripeterono
- E io mi comprerò un vestito di flanella a quadretti, - continuò Nanin, - e tu un vestito di stoffa, grande che ti stia anche quando sei incinta.
Alla moglie venne una idea: - Ah! Hai trovato da vendere la terra del Gozzo.
La terra del Gozzo era un campo ereditato, tutto pietre e cespugli, che li faceva pagar tasse senza render niente. A Nanin seccava che credessero questo: stava dicendo delle cose assurde, ma c'insisteva, con rabbia.
- No, non ho trovato nessuno. Ma noi dobbiamo avere tutto questo, - s'intestò, senza levare gli occhi dal piatto. Invece gli altri erano già pieni di speranze: se aveva trovato da vendere la terra del Gozzo, tutte le cose che aveva detto erano possibili.
- Coi soldi della terra, - disse il vecchio Battistin, - mi posso far fare l'operazione dell'ernia.
Nanin sentiva d'odiarlo.
- Ci creperai, con la tua ernia! - gridò.
Gli altri stavano attenti se impazziva.
Intanto, nella stalla, il bue Morettobello s'era slegato, aveva abbattuto la porta, era uscito nel campo. A un tratto entrò nella stanza, si fermò, e lanciò un muggito, lungo, lamentoso, disperato. Nanin s'alzò imprecando e lo ricacciò nella stalla a bastonate.
Rientrò: tutti tacevano, anche i bimbi. Poi il maschio gli chiese: - Papà, quando me lo compri il vestito alla marinara?
Nanin alzò gli occhi su di lui, gli occhi uguali a quelli di suo padre Battistin.
- Mai! - urlò.
Sbatté la porta e andò a dormire.
Al mattino presto si vede la Corsica: sembra una nave carica di montagne sospesa laggiù sull'orizzonte. Se si fosse in un altro paese ne sarebbero nate delle leggende; da noi no: la Corsica è un paese povero, più povero del nostro, nessuno ci è mai andato e nessuno ci ha mai pensato. Quando di mattina si vede la Corsica è segno che l'aria è chiara e ferma e non accenna a piovere.
In una di queste mattine, sull'alba, mio padre ed io salivamo per i pietreti di Colla Bella, col cane alla catena. Mio padre aveva attorcigliato petto e schiena di sciarpe, mantelline, cacciatore, gilecchi, bisacce, borracce, cartuccere, in mezzo a cui nasceva una bianca barba caprina; alle gambe aveva un vecchio paio di schinieri di cuoio tutti graffiati. Io avevo un giubbetto liso e striminzito che mi lasciava scoperti i polsi e le reni, e calzoni lisi e striminziti anch'essi e camminavo a passi lunghi come mio padre, ma con le mani seppellite nelle tasche e il lungo collo appollaiato tra le spalle. Tutt'e due avevamo vecchi fucili da caccia, di buona fattura, ma maltenuti e zigrinati dalla ruggine. Il cane era da lepre, orecchie abbandonate che scopavano terra, pelo corto e spinoso sui femori che logoravano la pelle; si trascinava dietro una catenaccia che sarebbe andata bene per un orso.
- Tu ti fermerai qui col cane, - disse mio padre. - Di qui batti due sentieri. Io andrò all'altro passo. Quando arrivo fischio e tu slegherai il cane. Tieni aperti gli occhi che è un momento a passare la lepre.
Mio padre continuò per il pietreto e io m'acculai in terra col cane che uggiolava perché voleva seguirlo. Colla Bella è un'altura dalle pallide rive tutte terreni gerbidi, erbe dure a brucare e muri franati di antiche terrazze. Più sotto comincia la nera nuvolaglia degli uliveti, più in su i boschi fulvi e spelacchiati dagli incendi come schiene di vecchi cani. Le cose impigrivano nel grigio dell'alba come in un socchiudere di palpebre ancora assonnate. Al mare non si distinguevano confini, traversato fino in fondo da lame di foschia.
Si udì il fischio di mio padre. Il cane, sganciato dalla catena, partì a grandi zig-zag per il pietreto, azzannando l'aria di latrati. Poi si zittì, cominciò a nasare il terreno e corse via con nasate diligenti, a coda dritta con sotto una bianca macchia romboidale che sembrava illuminata.
Io tenevo lo schioppo puntato appoggiato alle ginocchia e lo sguardo puntato appoggiato al crocicchio dei sentieri, ché è un momento a passare la lepre. L'alba andava scoprendo i colori, a uno a uno. Prima il rosso delle bacche, dei tagli zonati sugli alberi di pino. Poi il verde, i cento, i mille verdi dei prati, dei cespugli, del bosco, poco prima tutti eguali: adesso invece ogni momento c'era un nuovo verde che nasceva e si distingueva dagli altri. Poi l'azzurro: quello urlante del mare che assordò tutto e fece restare pallido e timoroso il cielo. La Corsica sparì bevuta dalla luce, ma tra mare e cielo il confine non si quagliò: rimase quella zona ambigua e smarrita che fa paura guardare perché non esiste.
A un tratto case, tetti, vie nacquero a piè delle colline, in riva al mare. Ogni mattina la città nasceva così dal regno delle ombre, tutt'a un tratto, fulva di tegole, baluginante di vetri, calcinosa d'intonachi. La luce ogni mattino la descriveva nei particolari più minuti, raccontava ogni suo andito, enumerava tutte le case. Poi veniva su per le colline, scoprendo sempre nuovi dettagli: nuove fasce, nuove case. Arrivava in Colla Bella, gialla e gerbida e deserta, e scopriva una casa anche lassù, sperduta, la più alta casa prima del bosco, a un tiro di fucile dal mio fucile, la casa di Baciccin il Beato.
La casa di Baciccin il Beato nell'ombra sembrava un mucchio di pietre; intorno aveva una fascia d'una terra incrostata e grigia come quella della luna, da cui s'alzavano piante striminzite come ci coltivassero stecchi. C'erano dei fili tesi, sembrava per stendere i panni, invece era la vigna con piante tisiche e scheletrite. Solo uno smilzo fico sembrava avesse la forza di sorreggere le foglie e si contorceva sotto il peso sull'orlo della fascia.
Uscì Baciccin: era magro che per vederlo bisognava si mettesse di profilo, se no si vedevano solo i baffi, che aveva grigi e spiegati nell'aria. Portava un passamontagna di lana in testa e un abito di fustagno. Vide me appostato e s'avvicinò.
- Lepre, lepre, - disse.
- Lepre, sempre lepre, - risposi.
- Sparato la settimana scorsa a una grossa così su quella riva. Come di qui a lì. Sbagliata.
- Scarogna.
- Scarogna, scarogna. Già io per la lepre non ci sono portato. Preferisco mettermi sotto un pino e aspettare i tordi. In una mattina cinque o sei botte si sparano.
- Così vi fate la pietanza, Baciccin Beato.
- Già. Io poi li sbaglio tutti, però.
- Succede. Le cartucce, sono.
- Cartucce, cartucce.
- Quelle che vendono sono imbrogli. Caricatevele da voi.
- Già. Io me le carico da me, però. Forse le carico male.
- Eh, bisogna saperci fare.
- E già, e già.
Intanto s'era piantato a braccia conserte in mezzo al crocicchio e restava lì. La lepre non sarebbe mai passata se lui restava lì in mezzo. «Adesso gli dico che si levi», pensavo, ma non glielo dicevo e restavo appostato lì lo stesso.
- E non piove, e non piove, - diceva Baciccin.
- La Corsica stamattina, avete visto?
- La Corsica. E tutto secca. La Corsica.
- Annata cattiva, Baciccin Beato.
- Annata cattiva. Piantate le fave. Nate?
- Nate?
- Nate? No.
- Semenza cattiva, vi hanno venduto, Baciccin.
- Semenza cattiva, annata cattiva. Otto piante di carciofi.
- Perbacco.
- Dite quanto m'han reso.
- Dite.
- Tutti morti.
- Perbacco.
Uscì di casa Costanzina, la figlia di Baciccin il Beato. Poteva avere sedici anni, la faccia a forma di oliva, gli occhi, la bocca, le narici a forma di oliva e le treccine giù per le spalle. Anche i seni a oliva doveva avere, tutta d'uno stile, raccolta come una statuetta, selvatica come una capra, le calze di lana ai ginocchi.
- Costanzina, - chiamai.
- Oh!
Ma non s'avvicinava, aveva paura di spaventare le lepri.
- Non abbaia ancora, non l'ha levata, - disse il Beato.
Tendemmo l'orecchio.
- Non abbaia, si può restare ancora, - e se ne andò.
Costanzina mi si sedette vicino. Baciccin il Beato s'era messo a girare per la sua fascia desolata, a potare le viti striminzite; ogni tanto smetteva e tornava a discorrere.
- Cos'è successo di nuovo in Colla Bella, Tancina? - chiesi. La ragazza cominciò a raccontare diligentemente.
- Ieri notte ho visto i leprotti lassù saltare sotto la luna. Ghi! Ghi! facevano. Ieri è nato un fungo dietro la rovere. Velenoso, rosso coi punti bianchi. L'ho ucciso con una pietra. Una biscia, grande e gialla, a mezzogiorno è scesa per il sentiero. Abita in quel cespuglio. Non tirarle pietre, è buona.
- Ti piace abitare in Colla Bella, Tancina?
- Alla sera no: sale la nebbia alle quattro e la città scompare. Poi, a notte, si sente urlare il gufo.
- Paura, il gufo?
- No. Paura le bombe, gli aeroplani.
S'avvicinò Baciccin.
- E la guerra, come va la guerra?
- Del bello che è finita la guerra, Baciccin.
- Ben Quel che c'è al posto della guerra, allora. Io poi, che sia finita non ci credo. Tante volte che l'han detto, tante volte che ricominciava in un altro modo. Dico male?
- No, dite bene.
- Ti piace più Colla Bella o la città, Tancina? - chiesi.
- In città c'è il tiro a segno, - rispose, - i tram, la gente che spinge, il cinema, il gelato, la spiaggia con gli ombrelloni.
- Questa qui, - disse Baciccin, - non ci ha tanta passione per andare in città, ma all'altra piaceva tanto che non è più tornata.
- Dov'è adesso?
- Ma.
- Ma. Piovesse almeno.
- Davvero. Piovesse. La Corsica, stamattina. Dico male?
- Bene, dite.
Lontano cominciò uno scatenarsi di latrati.
- Il cane ha levato la lepre, - dissi.
Il Beato venne a fermarsi sul passo, a braccia conserte.
- Batte. Batte bene, - disse. - Io avevo una cagna che si chiamava Cililla. Capace di star dietro a una lepre per tre giorni. Una volta l'andò a scovare in cima al bosco e me la portò a due metri sotto il fucile. Due botte, le tirai. Sbagliata.
- Tutte non possono andar bene.
- Non possono. Beh, continuò a battere la lepre per due ore...
Si sentirono due spari, ma poi il latrare ricominciò sempre più vicino.
-... Dopo due ore, - riattaccò Baciccin, - mi riportò la lepre come prima. La sbagliai ancora, porcomondo.
A un tratto un leprotto apparve saettante sul sentiero, arrivò fin quasi sulle gambe a Baciccin, poi scartò nei cespugli e sparì. Io nemmeno avevo fatto in tempo a puntare.
- Perbacco! - gridai.
- Che c'è? - chiese il Beato.
- Niente, - dissi.
Neanche Costanzina aveva visto, tornata in casa.
- Beh, - riprese il Beato, - quella cagna non continuò a battere la lepre e a riportarmela tante volte finché non la presi? Che cagna!
- Dov'è adesso?
- M'è scappata.
- Beh, tutte non possono andar bene.
Tornò mio padre col cane trafelato. Sacramentava.
- Per un pelo. Di qui a lì. Una bestia così. L'avete vista?
- Nulla, - disse il Beato.
Io misi lo schioppo a tracolla e prendemmo a scendere.
L'occhio del padrone, - gli disse suo padre, indicandosi un occhio, un vecchio occhio senza ciglia tra le palpebre grinzose, tondo come un occhio d'uccello, - l'occhio del padrone ingrassa il cavallo.
- Sì, - disse il figlio e restava seduto sull'orlo del tavolo di legno grezzo, all'ombra del grande fico.
- Allora, - disse il padre, sempre tenendo il dito sotto l'occhio, - vai alle fasce del grano e stai a vedere mentre mietono.
Il figlio aveva le mani seppellite nelle tasche, un filo di vento gli agitava la schiena della camicia a maniche corte.
- Vado, - disse, e stava fermo. Le galline beccavano qualche avanzo di fico spiaccicato in terra.
A vedere il figlio abbandonato alla sua indolenza come una canna al vento, il vecchio sentiva raddoppiarsi di momento in momento la sua furia: trascinava sacchi fuori dal magazzino, mescolava concimi, faceva cascare ordini e imprecazioni addosso agli uomini chini, minacciava il cane incatenato che guaiva sotto una nuvola di mosche. Il figlio del padrone non si scostava né disseppelliva le mani dalle tasche, restava con lo sguardo impigliato al suolo e le labbra atteggiate a fischio, come disapprovando tanto sciupio di forze.
- L'occhio del padrone, - disse il vecchio.
- Vado, - rispose il figlio e, senza fretta, andò.
Camminava per il sentiero della vigna, a mani in tasca, senz'alzare troppo i tacchi. Suo padre lo stette a guardare per un po', piantato a gambe larghe sotto il fico, i grandi pugni uno nell'altro dietro la schiena; fu diverse volte per gridargli dietro qualcosa, ma stette zitto e riprese a mescolare pugni di concime.
Il figlio andando rivedeva i colori della vallata, riascoltava i ronzii dei calabroni nei frutteti. Ogni volta che tornava al suo paese, dopo mesi passati a illanguidirsi in città lontane, riscopriva l'aria e l'alto silenzio della sua terra come un richiamo dimenticato d'infanzia e insieme con rimorso. Ogni volta venendo alla sua terra restava come nell'attesa d'un miracolo: tornerò e questa volta tutto avrà un significato, il verde che digrada a strisce per la vallata del mio podere, i gesti sempre uguali degli uomini al lavoro, la crescita d'ogni pianta, d'ogni ramo; la rabbia di questa terra prenderà anche me come mio padre, fino a non potermi più staccare di qui.
Il grano era in certe fasce su una ripa sassosa dove cresceva a stento, un rettangolo giallo in mezzo al grigio delle terre gerbide, e due cipressi neri uno su e uno giù che sembrava ci facessero la guardia. Nel grano c'erano gli uomini e un muoversi di falci; il giallo a poco a poco spariva come cancellato e sotto rispuntava il grigio. Il figlio del padrone saliva con un filo d'erba tra i denti per le scorciatoie sulla ripa nuda; dalle fasce del grano gli uomini l'avevano certo di già visto che saliva e avevano commentato il suo arrivo. Sapeva quello che gli uomini pensavano di lui: il vecchio è matto ma suo figlio è scemo.
- Bona, - disse U Pé a lui che arrivava.
- Bona, - disse il figlio del padrone.
- Bona, - dissero gli altri.
E il figlio del padrone rispose: - Bona.
Ecco: tutto quel che c'era da dire tra loro era stato detto. Il figlio del padrone si sedette su una riva di fascia, a mani in tasca.
- Bona, - disse ancora una voce dalla fascia più sopra: era Franceschina che spigolava. Lui disse ancora una volta: - Bona.
Gli uomini mietevano in silenzio. U PÉ era un vecchio dalla pelle gialla che gli ricadeva grinzosa sulle ossa; U Ché era di mezz'età, peloso e atticciato; Nanin era giovane, un rossiccio allampanato: aveva la maglietta sudata addosso e uno spicchio di schiena nuda appariva e spariva a ogni colpo di falce. La vecchia Girumina spigolava accoccolata in terra come una grande gallina nera. Franceschina era sulla fascia più alta, e cantava una canzone della radio. Ogni volta che si chinava le si scoprivano le gambe fin dietro i ginocchi.
Il figlio del padrone provava vergogna d'essere lì a fare la guardia, dritto come un cipresso, ozioso in mezzo a quelli che lavoravano. «Adesso, - pensava, - dico che mi diano un momento una falce, e provo un po'». Ma restava zitto e fermo guardando il terreno irto dei gambi gialli e duri delle spighe tagliate. Tanto, non sarebbe stato capace a muovere la falce, e avrebbe fatto brutta figura. Spigolare: quello avrebbe potuto farlo, un lavoro da donne. Si chinò, raccolse due spighe, le buttò nel grembiule nero della vecchia Girumina.
- Faccia attenzione a non pestare dove non ho raccolto ancora, - disse la vecchia.
Il figlio del padrone si rimise a sedere sulla riva, masticando un pezzo di paglia.
- Più dell'anno scorso, quest'anno? - chiese.
- Meno, - disse U Ché, - tutti gli anni meno.
- É stato, - disse U Pé, - la gelata in febbraio. Si ricorda che gelata in febbraio?
- Sì, - disse il figlio del padrone. Ma non ricordava.
- É stata, - disse la vecchia Girumina, - quella grandinata in marzo. Si ricorda in marzo?
- Grandinava, - disse il figlio del padrone, sempre mentendo.
- Per me, - disse Nanin, - è stata quella siccità in aprile. Ricorda che siccità?
- Tutto aprile, - disse il figlio del padrone. Non ricordava niente.
Ora gli uomini avevano cominciato una discussione di pioggia e di gelo e di siccità: il figlio del padrone era fuori di tutto questo, staccato dalle vicende della terra. L'occhio del padrone. Era solo un occhio lui. Ma a che serve un occhio, solo un occhio, staccato da tutto? Non vede nemmeno. Certo se suo padre si fosse trovato lì, avrebbe seppellito gli uomini di bestemmie, avrebbe trovato il lavoro mal fatto, lento, il raccolto rovinato. Se ne sentiva quasi il bisogno, dei gridi di suo padre, per quelle fasce, come quando si vede uno sparare e si sente il bisogno dello scoppio nei timpani. Lui non avrebbe mai gridato agli uomini, e gli uomini lo sapevano, perciò continuavano a lavorare pigri. Però certo preferivano suo padre a lui, suo padre che li faceva faticare, suo padre che faceva piantare e cogliere grano su quelle ripe da capre, era uno dei loro, suo padre. Lui no, lui era un estraneo che mangiava sul loro lavoro, sapeva che lo disprezzavano, forse l'odiavano.
Ora gli uomini avevano ripreso un discorso cominciato prima che arrivasse, su una donna della vallata.
- Così dicevano, - fece la vecchia Girumina, - con il parroco.
- Sì, sì, - disse U Pé. - Il parroco le aveva detto: se vieni ti do due lire.
- Due lire? - chiese Nanin.
- Due lire, - disse U Pé.
- Allora, - disse U Ché.
- Quanto faranno adesso due lire d'allora? - chiese Nanin.
- Delle belle, - disse U Ché.
- Orcocane, - disse Nanin.
Tutti ridevano per la storia di quella donna; anche il figlio del padrone sorrise, ma non capiva bene il senso di quelle storie, amori di donne ossute e baffute e nerovestite.
Anche Franceschina sarebbe diventata così. Ora spigolava, sulla fascia più alta, cantando una canzone della radio, e ogni volta che si chinava la sottana le saliva più su, scoprendo la pelle bianca dietro i ginocchi.
- Franceschina, - le gridò Nanin, - ci andresti con un prete per due lire?
Franceschina era dritta sulla fascia, col mazzo di spighe raccolte al petto.
- Duemila? - gridò.
- Orcocane, duemila, dice, - fece Nanin agli altri, perplesso.
- Io non vado né coi preti né coi borghesi, - gridò Franceschina.
- Coi militari, sì? - gridò U Ché.
- Nemmeno coi militari, - rispose lei e ripigliò a raccogliere spighe.
- Belle gambe ha, Franceschina, - disse Nanin, guardandogliele.
Anche gli altri le guardarono e furono d'accordo.
- Belle dritte, - dissero. Il figlio del padrone ci guardò come se non ci avesse già guardato prima, e fece un cenno d'assenso. Pure, sapeva che non erano belle gambe, erano dure di muscoli e pelose.
- Quando ci vai militare, Nanin? - disse Girumina.
- Orcocane, si tratta che vogliano passar la visita ai riformati, - fece Nanin. - Se la guerra non finisce chiameranno anche a me, con l'insufficienza toracica.
- É vero che è entrata in guerra l'America? - chiese U Ché al figlio del padrone.
- L'America, - disse il figlio del padrone. Forse ora avrebbe potuto dir qualcosa. - L'America e il Giappone, - disse, poi tacque. Cosa si poteva dire,
- Chi è più forte: l'America o il Giappone?
- Tutt'e due sono forti, - disse il figlio del padrone.
- E l'Inghilterra è forte?
- Eh, è forte anche lei.
- E la Russia?
- Anche la Russia è forte.
- La Germania?
- La Germania pure.
- E noialtri?
- Sarà una lunga guerra, - disse il figlio del padrone. - Una lunga guerra.
- Al tempo dell'altra guerra, - disse U Pé, - nel bosco c'era una caverna dove stavano dieci disertori -. E indicò su, verso i pini.
- Se continua ancora un po', - disse Nanin, - io dico che finiremo anche noi nelle caverne.
- Ma, - disse U Ché, - chissà come andrà a finire.
- Tutte le guerre, - disse U Pé, - finiscono così: e chi n'ebbe n'ebbe.
- E chi n'ebbe n'ebbe, - dissero gli altri.
Il figlio del padrone prese a salire per le fasce mordendo il gambo di paglia, fin da Franceschina. Le guardava la pelle bianca sul dietro dei ginocchi, quando si chinava a raccogliere le spighe. Forse con lei sarebbe stato più facile; avrebbe fatto conto di farle la corte.
- Ci vai mai in città, Franceschina? - chiese. Era un modo stupido d'attaccar discorso.
- Alle volte ci scendo la domenica pomeriggio. Se c'è la fiera si va alla fiera, se no al cinema.
Aveva smesso di lavorare. Non era questo che lui voleva: se suo padre l'avesse visto! invece di far la guardia, faceva parlare le donne sul lavoro.
- Ti piace andare in città?
- Sì, mi piace. Ma in fondo quando uno torna su la sera cosa glie n'è venuto. Il lunedì si ricomincia e chi n'ebbe n'ebbe.
- Eh, - fece lui mordendo la paglia. Adesso bisognava lasciarla stare, se no non ricominciava più a lavorare. Si voltò e scese.
Nelle fasce di sotto gli uomini avevano quasi finito e Nanin legava i carichi nei teli-tenda per portare giù a spalle. Il mare altissimo a petto delle colline cominciava a tingersi di viola dalla parte del tramonto. Il figlio del padrone guardava la sua terra tutta pietre e stoppie dure e capiva che le sarebbe sempre rimasto disperatamente straniero.
All'alba io e mio fratello dormiamo con le facce affondate nei guanciali, e già si sentono i passi chiodati di nostro padre che gira per le stanze. Nostro padre quando s'alza fa molto rumore, forse apposta, e fa in modo di far le scale con le scarpe chiodate su e giù venti volte, tutte inutili. Forse è tutta la sua vita così, uno spreco di forze, un gran lavoro inutile, e forse lo fa per protestare contro noi due, tanto gli facciamo rabbia.
Mia madre non fa rumore ma è già in piedi anche lei in quella grande cucina, ad attizzare, a sbucciare con quelle mani che diventano sempre più tagliuzzate e nere, e a nettare vetri e mobili, a cincischiare nei panni. É una protesta contro di noi anche questa, di accudire sempre zitta e tirare avanti la casa senza serve.
- Vendetevela, la casa e mangiamoci i soldi, - dico io, stringendomi nelle spalle quando mi angosciano che non si può più andare avanti, ma mia madre continua a sfaticare zitta, mattina e sera che non si sa quando dorme, e intanto le crepe s'aprono più lunghe nei soffitti e file di formiche costeggiano i muri, e le erbe e i rovi salgono dal giardino incolto Forse tra poco della nostra casa non resterà che una rovina coperta di rampicanti. Ma mia madre la mattina non viene a dire di alzarci perché sa che tanto è inutile e quell'accudire zitta zitta con la casa che le cade addosso è il suo modo di perseguitarci.
Mio padre invece alle sei già spalanca la nostra porta in cacciatora e gambali e grida: - Io vi bastono! Pelandroni! In questa casa tutti si lavora tranne voi! Pietro, alzati se non vuoi che t'impicchi! Fa' alzare quel pendaglio di forca di tuo fratello Andrea!
Noi l'avevamo già sentito avvicinarsi nel sonno e stiamo con le facce sepolte nei guanciali e nemmeno ci voltiamo. Protestiamo con grugniti ogni tanto, se tarda a smettere. Ma presto se ne va: sa che tutto è inutile, che è tutta una commedia la sua, una cerimonia rituale per non dichiararsi vinto.
Noi riannaspiamo nel sonno: mio fratello, il più delle volte, non s'è nemmeno svegliato, tanto ci ha fatto l'abitudine e se n'infischia. Egoista e insensibile, è, mio fratello: alle volte mi fa rabbia. Io faccio come lui, ma almeno capisco che non andrebbe fatto così e il primo ad esserne scontento sono io. Pure continuo, ma con rabbia.
- Cane, - dico a mio fratello Andrea, - cane, ammazzi tuo padre e tua madre -. Lui non risponde: sa che sono un ipocrita e un buffone, che più fannullone di me non c'è nessuno.
Di lì a dieci minuti, venti, mio padre è di nuovo lì dalla porta che s'angoscia. Adesso usa un altro sistema: delle proposte quasi con indifferenza, bonarie: una commedia che fa pietà. Dice: - Allora chi è che viene con me a San Cosimo? C'è da legare le viti.
San Cosimo è la nostra campagna. Tutto ci secca e non c'è braccia né soldi per mandarla avanti.
- C'è da scavare le patate. Vieni tu Andrea? Eh, vieni tu? Dico a te, Andrea. C'è da girare l'acqua nei fagioli. Vieni, allora?
Andrea leva la bocca dal cuscino, dice: - No, - e dorme.
- Perché? - mio padre fa ancora la commedia, - era deciso Pietro? Vieni tu, Pietro?
Poi fa ancora una sfuriata e ancora si calma e parla delle cose che ci sono da fare a San Cosimo come se fosse inteso che venissimo. Cane, io penso di mio fratello, cane, potrebbe alzarsi e dargli una soddisfazione una volta, povero vecchio. Ma addosso non mi sento nessuna spinta ad alzarmi e mi sforzo di farmi riprendere dal sonno che se n'è già andato.
- Bene, fate presto che vi aspetto, - dice nostro padre e se ne va come se fossimo già d'accordo. Lo sentiamo camminare e sbraitare a basso, preparandosi i concimi, il solfato, le sementi da portare in su; ogni giorno parte e ritorna carico come un mulo.
Già pensiamo che sia partito ed eccolo che grida ancora dal fondo delle scale: - Pietro! Andrea! Cristo di Dio, non siete pronti?
É l'ultima sua gridata: poi sentiremo i suoi passi ferrati dietro la casa, sbattere il cancelletto, e lui allontanarsi scatarrando e gemendo per la stradina.
Ora si può ripigliare un sonno filato, ma io non riesco a riaddormentarmi e penso a mio padre che sale carico per la mulattiera scatarrando, e poi sul lavoro che s'infuria contro i manenti che gli rubano e lasciano tutto andare alla malora. E guarda le piante e i campi, e gli insetti che rodono e scavano dappertutto e il giallo delle foglie e il fitto dell'erbaccia, tutto il lavoro della sua vita che va in rovina come i muri delle fasce che diroccano a ogni pioggia, e sacramenta contro i suoi figli.
Cane, dico pensando a mio fratello, cane. Tendendo l'orecchio mi arriva da basso qualche acciottolare, qualche cadere in terra di manico di scopa. Mia madre è sola in quella enorme cucina e il giorno appena schiarisce i vetri delle finestre e lei sfatica per gente che le volta le spalle. Così penso, e dormo.
Non sono ancora le dieci che è nostra madre a gridare, dalle scale: - Pietro! Andrea! Sono già le dieci! - Ha una voce molto arrabbiata, come si fosse stizzita d'una cosa inaudita, ma è così tutte le mattine. - Sìii... - gridiamo. E restiamo a letto ancora una mezz'ora, ormai svegli, per abituarci all'idea di alzarci.
Poi io comincio a dire: - Dài, svegliati, Andrea, alé, alziamoci. Su, Andrea, comincia a alzarti -. Andrea grugnisce.
Alla fine siamo in piedi con molti sbuffi e stiramenti. Andrea gira in pigiama con movimenti da vecchio, la testa tutta arruffata e gli occhi mezzo ciechi ed è già lì che lecca la cartina e si mette a fumare. Fuma alla finestra, poi comincia a lavarsi ed a sbarbarsi.
Intanto ha incominciato a borbottare e a poco a poco dal borbottio ne esce fuori un canto. Mio fratello ha voce da baritono ma in compagnia è sempre il più triste e mai che canti. Invece da solo, mentre si rade o fa il bagno attacca uno di quei suoi motivi cadenzati a voce cupa. Canzoni non ne sa e ci dà sempre dentro in una poesia di Carducci imparata da bambino: - Sul castello di Verona - batte il sole a mezzogiorno...
Io son di là che mi vesto e faccio coro, senz'allegria, con una specie di violenza: - Mormorando per l'aprico - verde il grande Adige va...
Mio fratello continua a cantilenare senza saltare una strofa fino alla fine, lavandosi la testa e spazzolandosi le scarpe. - Nero come un corvo vecchio - e negli occhi aveva carboni...
Più canta e più io mi riempio di rabbia e m'inferocisco anch'io a cantare: - Mala sorte è questa mia - mala bestia mi toccò...
É l'unico momento che facciamo del chiasso. Poi stiamo zitti quasi per tutta la giornata.
Scendiamo giù e ci scaldiamo il latte, poi dentro ci inzuppiamo pane e mangiamo con grande rumore. Mia madre ci è intorno e parla lamentandosi ma senza insistenza di tutte le cose che ci sono da fare, delle commissioni che occorrerebbero. - Sì, sì, - rispondiamo e ce ne dimentichiamo subito.
Al mattino di solito non esco, resto a girare per i corridoi con le mani in tasca, o riordino la biblioteca. Da tempo non compro più libri: ci vorrebbero troppi soldi e poi ho lasciato perdere troppe cose che m'interessavano e se mi ci rimettessi vorrei leggere tutto e non ne ho voglia. Ma continuo a riordinare quei pochi libri che ho nello scaffale: italiani, francesi, inglesi, o per argomento: storia, filosofia, romanzi, oppure tutti quelli rilegati insieme, e le belle edizioni, e quelli malandati da una parte.
Mio fratello invece va al caffè Imperia a vedere giocare al biliardo. Non gioca perché non è capace: sta ore e ore a vedere i giocatori, a seguire la biglia negli effetti, nei rinterzi, fumando, senz'appassionarsi, senza scommettere perché non ha soldi. Alle volte gli dànno da segnare i punti, ma spesso si distrae e sbaglia. Fa qualche piccolo commercio, quanto gli basta per comprarsi da fumare; da sei mesi ha fatto domanda per un posto nell'azienda dell'acquedotto che gli darebbe da mantenersi, ma non si dà da fare per averlo, tanto il mangiare per ora non gli manca.
A pranzo mio fratello arriva tardi, e mangiamo zitti tutt'e due. I nostri genitori discutono sempre di spese e introiti e debiti, e di come fare a tirare avanti con due figli che non guadagnano, e nostro padre dice: - Vedete il vostro amico Costanzo, vedete il vostro amico Augusto -. Perché gli amici nostri non sono come noi: han fatto una società per la compravendita dei boschi da taglio e son sempre in giro che trafficano, e contrattano, anche con nostro padre, e guadagnano mucchi di soldi e presto avranno il camion. Sono degli imbroglioni e nostro padre lo sa: però gli piacerebbe vederci come loro, piuttosto che come siamo: - Il vostro amico Costanzo ha guadagnato tanto in quell'affare, - dice. - Vedete se potete mettervici anche voi -. Ma con noi i nostri amici vengono a spasso, ma affari non ce ne propongono: sanno che siamo fannulloni e buoni a nulla.
Al pomeriggio mio fratello torna a dormire: non si sa come faccia a dormire tanto, pure dorme. Io vado al cinema: ci vado tutti i giorni, anche se ridanno dei film che ho già visto, così non faccio fatica a tener dietro alla storia.
Dopo cena, sdraiato sul divano, leggo certi lunghi romanzi tradotti che mi imprestano: spesso nel leggere perdo il filo e non riesco mai a venirne a capo. Mio fratello s'alza appena mangiato ed esce: va a veder giocare al biliardo.
I miei vanno subito a dormire perché al mattino si alzano presto. - Va' in camera tua che qui sprechi luce, - mi dicono salendo. - Vado, - dico, e rimango.
Già sono a letto e dormo da un po', quando verso le due torna mio fratello. Accende la luce, gira per la stanza e fuma l'ultima. Racconta fatti della città, dà giudizi benevoli sulla gente. Quella è l'ora in cui è veramente sveglio e parla volentieri. Apre la finestra per fare uscire il fumo, guardiamo la collina con la strada illuminata e il cielo buio e limpido. Io mi alzo a sedere sul letto e chiacchieriamo a lungo di cose indifferenti, ad animo leggero, finché non ci torna sonno.
Fu uno sbaglio di nostro padre, dei suoi soliti. Aveva fatto venire quel ragazzo da un paesetto di montagna, perché ci guardasse le capre. E il giorno che arrivò lo volle invitare a tavola con noi.
Nostro padre non capisce le differenze che ci sono tra la gente, la differenza tra una sala da pranzo come la nostra, coi mobili incisi, i tappeti dai cupi disegni, le maioliche, e quelle loro case di pietra affumicate, con per pavimento terra battuta e i festoni di giornale neri di mosche alla cappa dei camini. Nostro padre si muove dappertutto con quella sua festosità senza cerimonie, di non voler che gli cambino il piatto alla pietanza, e quando gira a caccia tutti lo invitano, e alla sera vengono da lui a dirimere le liti. Noi no, noi figli. Mio fratello forse ancora, per quella sua aria di complicità taciturna, può accattivarsi qualche confidenza ruvida; ma io so quant'è difficile parlarsi tra esseri umani e a ogni momento sento le distanze tra le classi e le civiltà aprirsi sotto di me come voragini.
Entra; io leggo in un giornale. E mio padre a fargli dei gran discorsi, che bisogno c'era?, si sarebbe confuso sempre più. No, invece. Alzai gli occhi ed era in mezzo alla sala con le mani pesanti, a mento contro il petto, ma con lo sguardo davanti a sé, ostinato. Era un pastore della mia età, all'incirca, coi capelli compatti e legnosi, e i lineamenti arcuati: fronte, orbite, mandibole. Aveva una scura camicia da soldato abbottonata a forza sul pomo del collo e un abituccio sbilenco da cui sembrava traboccassero le grandi nodose mani e gli scarponi grossi e lenti sul pavimento lucido.
- Questo è mio figlio Quinto, - disse mio padre, - fa il liceo.
Io m'alzai e azzardai un'espressione sorridente e la mia mano tesa s'incontrò con la sua e subito le scostammo senza guardarci in viso. Mio padre aveva già preso a raccontare di me, cose che non importavano a nessuno, di quanto mi mancava a finire gli studi, di un ghiro da me ucciso una volta cacciando nei paesi di quel giovane; e io alzavo le spalle con degli: - Io? Ma no! - ogni volta che mi sembrava non dicesse giusto. Il pastore restava muto e fermo e non si capiva se sentisse: ogni tanto gettava un'occhiata rapida verso una parete, una tenda; come una bestia che cerca uno spiraglio nella gabbia.
Già mio padre aveva cambiato discorso e ora girava per la stanza e diceva di certe varietà d'ortaggi che coltivano in quelle vallate e faceva delle domande al ragazzo e lui a mento sul petto e bocca semichiusa continuava a rispondere che non sapeva. Nascosto dietro il giornale, io aspettavo servissero in tavola. Ma mio padre aveva fatto già sedere l'invitato e portato d'in cucina un cetriolo e glielo andava tagliando nel piatto da minestra in fette sottili, perché lo mangiasse, diceva lui, per antipasto.
Entrò mia madre, alta e vestita di nero, coi bordi di pizzo e la scriminatura impassibile tra i capelli bianchi e lisci. - Ah, ecco qui il nostro pastorello, disse. - Hai fatto buon viaggio? - Il ragazzo non s'alzò e non rispose, alzò lo sguardo su mia madre, uno sguardo pieno di diffidenza e d'incomprensione. Io stavo dalla sua con tutta l'anima: disapprovavo quel tono di superiorità affettuosa di mia madre, quel «tu» padronale che gli dava; avesse parlato in dialetto come nostro padre, ancora! ma parlava italiano, un italiano freddo come un muro di marmo di fronte al povero pastore.
Io volevo stornare il discorso da lui, proteggerlo. Perciò lessi una notizia sul giornale, una notizia che poteva interessare solo i miei genitori, d'un giacimento minerario scoperto in una località africana dove vivevano certi nostri conoscenti. Avevo scelto a bella posta una notizia che non potesse riguardare minimamente l'ospite, piena di nomi a lui ignoti; e questo non per fargli pesare di più il suo isolamento, ma come per scavargli un fosso intorno e dargli respiro, e distrarre da lui per un momento le assillanti attenzioni dei miei genitori. Forse il mio gesto fu mal interpretato anche da lui; e sortì un effetto opposto. Perché mio padre cominciò a rivangare una sua storia africana, e a confondere il ragazzo con un arruffio di strani nomi di siti, popolazioni e animali.
Già stavano per servire la minestra quando apparve mia nonna sulla poltrona a ruote spinta dalla mia povera sorella Cristina. Dovettero gridare forte negli orecchi della nonna di cosa si trattava. Anzi mia madre fece proprio le presentazioni: - Questo è Giovannino che ci guarderà le capre. Mia madre. Mia figlia Cristina.
Io arrossivo di vergogna per lui a sentirlo chiamare Giovannino; chissà come quel nome suonava diverso nel chiuso e rozzo dialetto della montagna: certo era la prima volta ch'egli si sentiva chiamato in quel modo.
Mia nonna assentì con la sua patriarcale pacatezza: - Bravo Giovannino, speriamo che non te ne lascerai scappare, di capre, neh! - Mia sorella Cristina, che vede in tutte le rare visite persone d'estremo riguardo, da mezzo nascosta che era dietro lo schienale della poltrona a ruote s'affacciò tutta spaurita mormorando - Lietissima - e diede la mano al giovane che la sfiorò con pesantezza.
Era seduto, il pastore, sul bordo della sua sedia, ma si teneva con le spalle indietro e le mani aperte sulla tovaglia, guardando mia nonna come affascinato. Quella vecchietta rattrappita nella grande poltrona, con i mezzi guanti che scoprivano le dita esangui vagamente accennanti in aria, e quel viso minutissimo sotto la valanga delle rughe, quegli occhiali che si puntavano contro di lui cercando di decifrare qualche forma nel confuso ammasso d'ombra e colori che le trasmettevano gli occhi, e quell'esprimersi in italiano come stesse leggendo in un libro, tutto doveva sembrargli nuovo, diverso dalle immagini di vecchiezza da lui incontrate.
La mia povera sorella Cristina che dal canto suo non era meno smarrita, come ogni volta che vedeva facce nuove, s'avanzò in mezzo alla sala, con le mani sempre giunte sotto lo scialletto che le modellava le spalle deformi, e alzando verso i vetri della finestra gli occhi chiari e sbigottiti, il capo striato da precoci ciocche grige, il viso fatto sgraziato dal tedio delle sue giornate di reclusa, disse: - C'era una barchetta in mare, io l'ho veduta. E due marinai che vogavano, vogavano. E poi è passata dietro il tetto d'una casa e nessuno l'ha più vista.
Ora io volevo che l'ospite si rendesse conto subito del triste caso della nostra sorella, sicché non dovesse più badarci e non ci si soffermasse a far congetture. Perciò saltai su, con un'animosità forzata e del tutto fuori luogo: - Ma come puoi aver visto dalle nostre finestre degli uomini su una barca? Stiamo troppo distanti.
Mia sorella continuava a guardare per quei vetri: non in mare ma in cielo. - Due uomini su una barca. E vogavano, vogavano. E c'era la bandiera, la bandiera tricolore.
Allora io m'accorsi che il pastore nell'ascoltare mia sorella non dimostrava quello spaesato disagio che pareva gli procurasse la presenza di tutti gli altri. Forse aveva finalmente trovato qualcosa che entrava nei suoi schemi, un punto di contatto tra il nostro ed il suo mondo. Ed io mi ricordai dei dementi che s'incontrano spesso tra i casolari di montagna e passano le ore seduti sulle soglie tra nuvole di mosche e con lamentosi vaneggiamenti rattristano le notti paesane. Forse questa sventura della nostra famiglia, che lui comprendeva perché ben nota alla sua gente, lo avvicinava a noi più che lo strambo cameratismo di mio padre, l'aria materna e protettiva delle donne, o il mio maldestro appartarmi.
Mio fratello arrivò in ritardo come al solito, quando s'avevano per mano già i cucchiai. Entra e a un'occhiata s'è già reso conto di tutto, e prima che mio padre gli abbia spiegato la storia e l'abbia presentato: - Mio figlio Marco che studia da notaio, - già è seduto che mangia, senza batter ciglio, senza guardar nessuno, coi freddi occhiali che sembran neri tanto sono impenetrabili, e la lugubre barbetta liscia e rigida. Si direbbe che abbia salutato tutti e si sia scusato del ritardo, e forse anche abbia fatto una specie di sorriso all'ospite, invece non ha schiuso le labbra né increspato d'una ruga la spietata fronte. Ora so che il pastore ha un alleato potentissimo al suo fianco, che lo proteggerà col suo mutismo di pietra, che gli aprirà una via di scampo in quell'atmosfera greve di disagio che solo lui, Marco, sa creare.
Il pastore mangiava curvo sul piatto della minestra, con sciacquio e rumore. In questo tutti e tre noi uomini eravamo dalla sua e lasciavamo alle donne l'ostentata etichetta: nostro padre per la sua naturale rumorosità espansiva, mio fratello per determinazione imperiosa, io per malagrazia. Ero contento di questa nuova alleanza, di questa ribellione di noi quattro contro le donne: perché faceva sì che il pastore non fosse più solo. Certo in quel momento le donne ci disapprovavano, e non lo dicevano per non umiliarci a vicenda, quelli di casa di fronte all'ospite, e viceversa. Ma se ne rendeva conto il pastore? No di certo.
Mia madre passò all'attacco, dolcissima: - E quanti anni hai, Giovannino?
Il ragazzo disse la cifra, che risuonò come un grido. La ripeté piano. - Come? - disse la nonna e la ripeté sbagliata. - No: è questa, - e tutti a gridargliela nelle orecchie. Solo mio fratello, zitto. - Un anno più di Quinto, - scoperse mia madre e si dovette rispiegarlo alla nonna. Soffrivo di questo paragonare me e lui, lui che doveva guardare le capre altrui per vivere, e puzzare di ariete, ed era forte da abbattere le querce, e io che vivevo sulle sedie a sdraio, accanto alla radio leggendo libretti d'opera, che presto sarei andato all'università, e non volevo mettermi la flanella sulla pelle perché mi faceva prudere la schiena. Le cose ch'erano mancate a me per esser lui, e quelle che eran mancate a lui per esser me, io le sentivo allora come un'ingiustizia, che faceva me e lui due esseri incompleti che si nascondevano, diffidenti e vergognosi, dietro quella zuppiera di minestra.
Fu allora che nostra nonna chiese: - E sei già andato soldato, dimmi? - Era una domanda fuori luogo; la sua classe non era stata chiamata ancora, aveva appena passato la prima visita.
- Soldato del papa, - disse nostro padre, una di quelle sue spiritosaggini che non facevano ridere nessuno.
- M'han fatto rivedibile, - disse il pastore.
- Oh, - disse nostra nonna, - riformato? - e la sua voce esprimeva disapprovazione e rimpianto. E anche se fosse, pensavo, perché te la pigli tanto?
- No. Rivedibile.
- E cos'è: rivedibile? - Si dovette spiegarglielo.
- Soldato del papa, ah, ah, soldato del papa, - si divertiva nostro padre.
- Ah, speriamo che tu non sia malato, - disse mia nonna.
- Malato il giorno della visita, - disse il pastore, e per fortuna mia nonna non sentì.
Mio fratello alzò il capo dal piatto, allora, e per il vetro dei suoi occhiali passò qualcosa come un'occhiata diretta verso l'ospite, un'occhiata d'intesa, e la barbetta gli si tese ai margini delle labbra forse in un accenno di sorriso, come dire: «Lascia perdere gli altri, io ti capisco e su queste cose la so lunga». Era con quei suoi improvvisi segnali di complicità che Marco s'accattivava le simpatie: d'ora in avanti il pastore si sarebbe rivolto sempre a lui, ogni volta che avrebbe risposto a una domanda, con dei «no?» al suo indirizzo. Pure io scoprivo che alle radici di quella pudica confidenza umana di mio fratello Marco, c'era il bisogno di riscuotere il consenso del prossimo di nostro padre insieme alla superiorità aristocratica di nostra madre. E pensavo che alleandosi con lui il pastore non sarebbe restato meno solo.
A questo punto mi sembrò potessi dire qualcosa che forse l'avrebbe interessato: e spiegai che io avevo avuto il congedo fino alla fine dei miei studi. Ma era la differenza tremenda tra noi due che avevo tirato in ballo; l'impossibilità di una comunanza anche in quelle cose che sembravano una fatalità per tutti, come fare il soldato.
Mia sorella fece una delle sue uscite: - E andrà in cavalleria lei, scusi?
Il che sarebbe forse passato inosservato se mia nonna non avesse accettato l'argomento: - Eh, la cavalleria al giorno d'oggi...
Il pastore mormorò qualcosa come: - Gli alpini...
Ci accorgemmo, io e mio fratello, d'aver in quel momento alleata anche nostra madre, che certo trovava sciocco quel soggetto di conversazione. Ma perché non interveniva, allora, a cambiar discorso? Per fortuna mio padre smise di ripetere: - Ah, soldato del papa... - e chiese se nei boschi nascessero i funghi.
Così continuammo per tutta la durata del pranzo in questa guerra, di noi tre ragazzi contro un mondo crudele e affabile, senza poterci riconoscere alleati, pieni di reciproche diffidenze anche tra noi. Mio fratello terminò con un gran gesto, dopo la frutta: uscì un pacchetto e offrì una sigaretta all'ospite. Se le accesero, senza chiedere permesso a nessuno, e questo fu il momento di solidarietà più piena che si creò in quel pranzo. Io ne ero escluso, perché i miei non mi permettevano di fumare finché ero al liceo. Mio fratello ormai era soddisfatto: s'alzò, tirò due boccate guardandoci dall'alto e zitto com'era venuto si girò e andò via.
Mio padre accese la pipa e la radio per le notizie. Il pastore se ne stava guardando l'apparecchio con le mani aperte sui ginocchi e gli occhi spalancati che s'arrossavano di lacrime. Certo a quegli occhi appariva ancora il paese alto sui campi, il giro delle montagne e il folto dei boschi di castagni. Mio padre non lasciava sentire, parlava male della Società delle Nazioni, ed io ne approfittai per uscire dalla sala da pranzo.
Il pensiero del ragazzo pastore ci seguì tutta la sera. Cenammo in silenzio alle luci attutite del lampadario e non potevamo liberarci dal pensare a lui adesso solo nel casolare della nostra campagna. Ora certo aveva finito la minestra nella gavetta messa a riscaldare, ed era steso sulla paglia quasi al buio, mentre giù si sentivano le capre muoversi e urtarsi e macinare erba coi denti. Il pastore usciva e c'era un po' di nebbia verso il mare e l'aria umida. Una fontanella ronfava discreta nel silenzio. Il pastore s'avvicinava lungo le vie coperte d'edera selvatica e beveva senza sete. Delle lucciole si vedevano apparire e sparire e sembravano un grande sciame compatto. Ma lui muoveva il braccio in aria senza toccarle.
Io sto via da casa mesi e mesi, talvolta anni. Torno ogni tanto e la mia casa è sempre in cima alla collina, rossiccia per un vecchio intonaco che la fa intravedere da lontano tra gli olivi fitti come fumo. É una casa antica, con archi di volte che sembrano ponti, con sui muri simboli massonici messi dai miei vecchi per far scappare i preti. In casa c'è mio fratello, che è sempre in giro per il mondo anche lui ma torna a casa più spesso di me e io tornando ce lo ritrovo sempre. Torna e subito si dà d'attorno finché non scova la sua cacciatora, il suo gilecco di fustagno, i suoi calzoni col fondo di cuoio, e non sceglie la pipa che tira meglio, e fuma.
- Oh, - mi fa quando arrivo, e magari sono anni che non ci si vede e lui non s'aspettava che arrivassi. - Alò, - dico io, e questo non perché ci sia dell'astio tra di noi, ché se ci si incontrasse in un'altra città ci si farebbe delle feste, magari ci si darebbe delle manate sulle spalle, - Guarda, guarda! - ci si direbbe, ma perché a casa nostra è diverso, a casa nostra si è sempre usato così.
Allora entriamo in casa tutt'e due, con le mani in tasca, zitti, un po' impacciati e tutt'a un tratto mio fratello comincia a parlare come se avessimo interrotto un discorso allora allora.
- Ieri notte, - dice, - il figlio della Giacinta voleva fare una brutta fine.
- Sparargli, dovevi, - dico io, anche se non so di cosa si tratta. Pure, avremmo voglia di chiederci l'un l'altro donde veniamo, che mestiere facciamo, se guadagnamo, se abbiamo preso moglie, se fatto figli, ma c'è tempo a chiedercelo poi, adesso sarebbe contrario alle usanze.
- Sai che la notte di venerdì è il turno nostro per l'acqua del Pozzo Lungo, - dice lui.
- Venerdì notte, è, - assicuro io, che non me lo ricordavo e forse non l'avevo mai saputo.
- Tu credi che noi ogni venerdì notte abbiamo l'acqua nel nostro? - dice. - Se la girano nel loro, se non si sta lì a far la guardia. Ieri notte passo di lì saran state le undici e vedo uno che corre con una zappa: il roglio era girato in quello di Giacinta.
- Sparargli, dovevi! - dico io e già sono pieno di rabbia: da mesi e mesi mi ero dimenticato che esistesse la questione dell'acqua del Pozzo Lungo, tra una settimana ripartirò e tornerò a dimenticarmene, pure adesso sono carico di rabbia per l'acqua che ci hanno rubato in quei mesi passati e che ci ruberanno in quei mesi venturi.
Intanto giro per le scale e le stanze, con mio fratello dietro che soffia nella pipa, per le scale e le stanze con appesi fucili antichi e nuovi e borracce per la polvere e corni da caccia e teste di camosci. Le scale e le stanze sanno di rinchiuso e di tarlato, con sui muri simboli massonici invece di crocifissi. Mio fratello racconta di tutto quello che rubano i manenti, dei raccolti che vanno a male, delle capre altrui che pascolano nei nostri prati, del nostro bosco dove va a far legna tutta la vallata. E io vado tirando fuori dagli stipi giubbe, gambali, gilecchi con tasche lunghe torno torno per metterci le cartucce e mi tolgo i vestiti gualciti della città e mi guardo negli specchi tutto bardato di cuoio e di fustagno.
Di lì a un po' andiamo giù per la mulattiera con le doppiette a tracolla, a vedere di sparare qualche colpo al volo o a fermo. Non abbiamo fatto cento passi che ci arriva una gragnuola di ghiaino nel collo, tirata forte, sembra con una fionda. Invece di voltarci subito, facciamo finta di niente e proseguiamo tenendo d'occhio il muro della vigna sopra la strada. Tra le foglie grige di solfato fa capolino la faccia di un ragazzetto, una faccia tonda e rossa con lentiggini che gli s'affollano sotto gli occhi, come una pesca mangiata dagli àfidi.
- Perdio, mettono su anche i bambini contro di noi! - dico, e comincio a sacramentargli contro.
Quello s'affaccia ancora, fa un versaccio con la lingua e scappa. Mio fratello prende per il cancello della vigna e si mette a rincorrerlo per i filari, calpestando i seminati, con me dietro, finché non lo mettiamo in mezzo. Mio fratello lo acciuffa per i capelli, io per le orecchie, capisco che gli faccio male, pure tiro, sento che più gli faccio male più m'arrabbio e gridiamo:
- Questo è per te e il resto sarà per tuo padre che ti ha mandato.
Il ragazzo piange, mi morde un dito e scappa; una donna nera si fa in fondo ai filari, gli nasconde la testa nelle pieghe del grembiule e comincia a gridare contro di noi agitando un pugno:
- Vigliacchi! Pigliarvela con un bambino! Sempre gli stessi prepotenti siete. Troverete chi vi dà il fatto vostro, non dubitate!
Ma noi già ce ne siamo andati per la nostra strada stringendoci nelle spalle perché alle donne non si risponde.
Andiamo, e incontriamo due, carichi di fascine che vengono avanti piegati a angolo retto dal peso.
- Ehi, voi due, - li facciamo fermare, - dove avete preso questa legna?
- Dove ci pare, - dicono e vorrebbero tirare avanti.
- Ché se l'avete presa nel nostro bosco ve la facciamo riportare e in più sugli alberi vi si appende voialtri.
Quelli hanno posato il carico sul muricciolo e ci guardano sudati di sotto il cappuccio di sacco che protegge loro testa e spalle.
- Noi non sappiamo di vostro o di non vostro. Noi non vi si conosce.
Difatti sembrano gente nuova, forse disoccupati che si son messi a far legna. Ragione di più per farci conoscere.
- I Bagnasco siamo. Mai sentito?
- Noi non sappiamo niente di nessuno. La legna l'abbiamo fatta in quello del Comune.
- In quello del Comune c'è proibito. Noi chiamiamo una guardia e vi facciamo metter dentro.
- Eh, va' che sappiamo chi siete, - salta fuori uno di loro. - Volete che non vi si conosca, sempre pronti a piantar grane alla povera gente! Ma la finirà una volta!
Io comincio: - La finirà cosa? - poi decidiamo di lasciar perdere e ci allontaniamo imprecando a vicenda.
Ora, mio fratello e io, quando siamo in qualche altro paese, discorriamo coi tranvieri, coi giornalai, passiamo la cicca a chi ce la chiede, chiediamo la cicca a chi ce la passa. Qui è diverso, qui siamo sempre stati così, giriamo con la doppietta e piantiamo dei baccani dappertutto.
All'osteria del passo c'è la sede dei comunisti: fuori c'è la tabella con dei ritagli di giornale e delle scritte appiccicate con puntine. Passando vediamo affissa una poesia che dice che i signori son sempre gli stessi e quelli che facevano i prepotenti prima sono i fratelli di quelli che lo fanno adesso. «I fratelli» è sottolineato perché è tutto un doppio senso contro di noi. Noi scriviamo sul foglio: «Vigliacchi e bugiardi», poi firmiamo: «Bagnasco Giacomo e Bagnasco Michele».
Eppure quando siamo via mangiamo minestra sulle tavolate fredde d'incerato dove mangiano gli altri uomini che lavorano lontano da casa, e scaviamo con l'unghia nella mollica del pane grigio e fangoso; e allora il vicino di tavola parla delle cose che ci sono sul giornale, e anche noi diciamo: - C'è ancora dei prepotenti al mondo! Ma un giorno andrà meglio. - Ora, qui, non si riuscirebbe; qui ci sono le terre che non producono, i manenti che rubano, i braccianti che dormono sul lavoro, la gente che quando passiamo ci sputa dietro perché non vogliamo lavorare la nostra terra e - dicono - siamo buoni solo a sfruttare gli altri.
Arriviamo a un posto dove dovrebbe esserci il passo dei colombacci e ci cerchiamo due posti per aspettare. Ma subito ci stanchiamo di star fermi e mio fratello mi insegna una casa dove stanno delle sorelle, e fischia a una che è la sua ganza. Quella scende: ha il petto largo e le gambe pelose.
- Di', vedi se viene anche tua sorella Adelina che c'è mio fratello Michele, - le dice lui.
La ragazza torna in casa e io mi informo da mio fratello: - É bella, è bella?
Mio fratello non si pronuncia: - É grassa. Ci sta.
Vengono fuori le due, e la mia è proprio grassa e grande e per un pomeriggio come quello può andar bene. Dapprima vorrebbero far delle storie e dicono che non possono farsi vedere in giro con noi perché se no si fanno nemici tutti quelli della vallata, ma noi diciamo loro di non far le stupide e le portiamo in quel campo, nei posti dove aspettavamo i colombacci. Mio fratello anzi ogni tanto trova modo di sparare un colpo; lui è abituato a portarsi la ragazza sulla caccia.
Dopo un po' che sono lì con l'Adelina, mi sento arrivare tra capo e collo un'altra sventagliata di ghiaino. Vedo il ragazzo delle lentiggini che scappa, ma non ho voglia di rincorrerlo e gli sacramento dietro.
Alla fine le ragazze dicono che devono andare alla benedizione.
- Andatevene e non state più a capitarci tra i piedi, - diciamo.
Poi mio fratello mi spiega che sono le due più vacche della vallata e hanno paura che gli altri giovanotti a vederle insieme a noi per dispetto non vadano più loro insieme. Io grido al vento: - Vacche! - ma in fondo mi dispiace che con noi vengano solo le due più vacche della vallata.
Sul sagrato di San Cosimo e Damiano c'è tutta la gente che aspetta la benedizione. Ci fanno largo e tutti ci guardano male, anche il prete, perché noi Bagnasco da tre generazioni non andiamo più a messa.
Andando avanti sentiamo qualcosa che ci cade vicino. - Il ragazzo! - gridiamo e stiamo già per scattare a rincorrerlo. Ma è una nespola marcita che s'è staccata da un ramo. Continuiamo a camminare, prendendo a calci le pietre.
É difficile vederla da lontano e anche uno che c'è già stato una volta non ricorda la strada per tornarci; un sentiero c'era e l'ho distrutto a vangate, coprendolo di rovi che attecchissero e cancellassero ogni traccia. Casa mia me la son scelta bene, perduta su questa riva di ginestre, bassa un piano che non è vista da valle, bianca per un intonaco calcinoso, ròsa dai buchi delle finestre come un osso.
Terra avrei potuto lavorarmene intorno e non l'ho fatto, mi basta un quadrato di semenzaio dove le lumache rodano lattuga e un giro di terrazza da rincalzare a colpi di bidente, per farne uscire patate germogliate e viola. Non ho bisogno di lavorare più di quanto mangio, perché non ho nulla da spartire con nessuno.
E non scaccio i roveti, quelli che stanno montando sul tetto della casa e quelli che già calano sul coltivato come una valanga lenta; mi piacerebbe seppellissero tutto, me compreso. Poi, ramarri han fatto il nido negli interstizi dei muri, sotto i mattoni del pavimento le formiche hanno scavato città porose e ora escono a file. Io guardo ogni giorno contento se m'accorgo d'una nuova crepa che s'apre; e penso alle città del genere umano quando soffocheranno inghiottite dalle piante selvatiche calate a valle.
Sopra la mia casa ci sono strisce di prato duro dove lascio girare le mie capre. Sull'alba, alle volte ci passano dei cani battendo uste di lepri; io li caccio con pietre. Odio i cani, quella loro servile fedeltà all'uomo, odio tutti gli animali domestici, il loro fingere di capire il genere umano per leccare gli avanzi dei suoi piatti bisunti. Solo le capre sopporto, perché non dànno confidenza e non ne prendono.
Non ho bisogno di cani incatenati che mi facciano la guardia. E nemmeno di siepi e chiavistelli, mostruose macchine umane. Nel mio campo sono alveari posati su un assito tutt'intorno, e un volo d'api come una siepe spinosa che solo io traverso. A notte le api dormono nelle cartilagini dei favi, ma a casa mia non s'avvicina nessun uomo; hanno paura di me e hanno ragione. Hanno ragione, dico, non perché certe storie che raccontano di me siano vere; menzogne, sono, degne di loro, ma ad aver paura di me fanno bene e è ciò che voglio.
Al mattino, girato il dorso del crinale, sotto, vedo la vallata che scende e il mare altissimo, tutt'intorno a me e al mondo. E ai piedi del mare vedo le case del genere umano pigiate, naufragate nella loro falsa fraternità, la città fulva e calcinosa, vedo, il baluginare dei suoi vetri e il fumo dei suoi fuochi. Un giorno roveti ed erbe ricopriranno le sue piazze, e salirà il mare a modellare in rocce le rovine delle loro case.
Solo le api, sono con me, ora: brulicano intorno alle mie mani senza pungermi quando tolgo il miele dalle arnie, e mi si posano addosso come una barba vivente, amiche api, dalla ragione antica e senza storia. Da anni vivo per questa ripa di ginestre, con capre ed api: facevo un segno sul muro ad ogni anno passato, prima: ora i roveti soffocano ogni cosa, questo loro assurdo tempo umano. Perché in fondo dovrei stare con gli uomini e lavorare per loro? Ho schifo delle loro mani sudate, dei loro riti selvaggi, balli e chiese, della saliva acida delle loro donne. Ma quelle storie, credetemi, non sono vere, sempre hanno raccontato storie di me, razza bugiarda.
Non do e non debbo nulla: se a notte piove, per le ripe al mattino striano grosse lumache che io cuocio e mangio; nel bosco i funghi molli e umidi bucano il terriccio. Il bosco mi dà tutto quello che mi manca: legna e pigne per ardere, e castagne; poi catturo bestie, coi lacci, lepri e tordi, non crediate che io ami le bestie selvatiche, che sia un adoratore idillico della natura, assurde ipocrisie degli uomini. Io so che al mondo bisogna mangiarsi uno con l'altro e che vale la legge del più forte: uccido le bestie che voglio mangiare, non altre, con trappole, non con armi, per non aver bisogno di cani o servitori che le scovino.
Alle volte incontro uomini nel bosco, se non faccio in tempo a scansarmi al loro lugubre rumore, asce che abbattono i tronchi uno per uno. Fingo di non vederli. I poveri alla domenica vengono a far legna nei boschi che si spelano come teste chiazzate d'alopecia: i tronchi trascinati con corde formano piste scoscese dove la pioggia roglia nei temporali provocando frane. Così tutto rovinasse sulle città del genere umano, potessi un giorno andando vedere emergere cime di fumaioli dalla terra, incontrare gomiti di strade interrotte in mezzo a dirupi, e nel fondo di foreste radure irte di binari.
Pure voi vorrete sapere se io non senta mai questa solitudine pesarmi, se io una sera, uno di quei tramonti lunghi, uno di quei primi tramonti lunghi di primavera non sia sceso, senz'un'idea precisa, verso le case del genere umano. Ci scesi, era un tramonto tiepido, verso quei loro muri che cintano gli orti, scavalcati dalle cime dei nespoli, ci scesi, e quel ridere di donne che sentii, quel chiamare un bambino lontano, ecco che io sono tornato, è stata l'ultima volta, quassù solo. Questo: a me come a voi prende ogni tanto paura di sbagliarmi. E allora, come voi, continuo.
Ora voi avete paura di me e avete ragione. Non per quel fatto, però.
Quel fatto, successo o non successo, fu di tanti anni fa, io ancora allora, ormai non conta.
Quella donna, io ero da poco venuto quassù, quella donna nera venuta a falciare, io ancora carico d'affetti umani, quella donna nera la vidi che falciava alta sulla ripa e mi salutò e io non la salutai e passai via. Poi, io ero carico d'affetti umani ancora e d'una vecchia ira, io mi avvicinai senza che lei sentisse, una vecchia ira avevo, non contro lei, non ricordo neppure più il suo viso.
Ora la storia come la raccontano gli altri è certo falsa perché era sul tardi e nessun essere umano era nella vallata e io la tenevo con la mano alla gola e nessuno ha sentito. Perché io dovrei raccontarvi la mia storia dal principio e allora voi capireste.
Ecco, non parliamo più di quella sera, io vivo qui dividendo le mie lattughe con le lumache che ne traforano le foglie e conosco tutti posti dove fanno i funghi e le specie buone da quelle velenose: non penso più alle donne, ai loro veleni, essere casti non è che un'abitudine.
L'ultima, quella donna nera della falce. Il cielo era carico di nuvole, ricordo, nuvole scure che correvano correvano. Ecco: sotto la corsa del cielo, per la ripa brucata dalle capre, le prime nozze umane, io so che negli incontri umani non ci può essere che spavento e vergogna uno dell'altro. Questo io le chiedevo: spavento e vergogna, nient'altro che spavento e vergogna negli occhi, solo per questo io con lei, credetemi.
Nessuno mi ha mai detto niente, mai: perché non possono dirmi niente, la vallata era deserta quella sera. Ma ogni notte, quando le colline sono perdute nel buio e io non riesco a seguire il ragionamento d'un vecchio libro al lume della lanterna, e la città del genere umano con le sue luci e le sue musiche è giù in fondo, io sento le voci di voi tutti che m'accusate.
Eppure nessuno era là a vedermi nella vallata, quella donna non tornò più a casa perciò dicono, ma non è vero che nelle strisce di prato sopra la mia casa ci sia il cadavere di quella donna seppellito.
E se quei cani che passano si fermano a annusare sempre in un punto e ululano e scavano la terra con le zampe, è perché c'è una vecchia tana di talpe, là sotto, ve lo giuro, una vecchia tana di talpe.
La sera che l'esse-esse arrestò la loro madre i ragazzi salirono a cenare a casa del comunista. Il comunista stava in un casolare a metà collina; ci si saliva per un sentiero tra gli olivi e i muri. La sera s'infittiva, grigia, quasi con fretta, come volesse cancellare tutto. I fratelli, andando, stavano attenti all'abbaiare dei cani nel fondovalle; poteva voler dire l'esse-esse che veniva a cercar loro, o la madre che tornava già libera, o il padre, o qualcunaltro che veniva a dire qualcosa, qualcosa che spiegasse. Ma i cani abbaiavano alla zuppa, i bambini nei casolari della vallata gridavano battendo i cucchiai sulle scodelle.
Il ritmo delle cose era cambiato, troppo lenti i sensi, troppo lesti i pensieri. Da un momento all'altro, cambiato. Scendevano dal bosco, il fratello maggiore e il comunista. Erano stati col fratello minore alla Rovere del Fariseo a portare dei medicinali per la banda del Giglio. Sotto la rovere c'erano ad aspettarli il Giglio e il Magro, con la pistola nascosta sotto il giubbetto. Il Giglio stava alle Rocche del Corvo, faceva i colpi per conto suo con pochi uomini, dipendeva ora da una banda ora dall'altra, ma sempre facendo i suoi comodi. Avevano parlato seduti sotto la rovere, del modo di guarirsi gli sfoghi alle gambe che vengono dormendo sulla paglia, e della necessità che i partigiani sbandati della zona si mettessero in regola con le formazioni, e smettessero di girare per i boschi come ladri. Poi s'erano fatti mostrare una tana buona e nascosta, dove potevano dormire cinque uomini. Tornando per il bosco avevano incontrato una ragazzotta che conduceva delle capre e il fratello minore ci s'era fermato insieme. Per tutto il bosco continuarono a sentirlo cantare assieme a lei, saltando per le rive dei pini con le capre.
Poi, alla Bicocca, tutti gli abitanti delle sette case fuori dalle porte. C'era anche Walter.
Disse, agitato: - Sapete niente d'in giù?
- Che c'è in giù?
- Del brutto. L'esse-esse ha arrestato tua madre. Tuo padre è sceso per vedere se la liberano.
Allora l'aria s'era fatta tesa e carica, come quando saliva la brigata nera e si sentiva rafficare tra gli olivi. Una folla di domande nei timpani, alla gola. Nella memoria apparivano e sparivano facce verdi di spie, come bolle che scoppiano. Il fratello che tornava tutto soddisfatto, cantando la canzone della pastorella, ad un tratto seppe la storia e smise.
Ora c'era questo fatto nuovo, e tutte le cose di prima erano cambiate, c'era dentro questo fatto nuovo mescolato in mezzo, la madre loro portata via dai tedeschi. E i fratelli erano come tornati bambini, ragazzi già grandi, con libri, con ragazze, con bombe, eppure tornati bambini, colpiti nella loro parte bambina, colpiti nella madre. Adesso si sarebbero presi per mano, avrebbero camminato smarriti, bambini senza mamma. Invece c'erano tante cose da fare: nascondere le bombe, le pistole, i caricatori, i fucili, i medicinali, gli stampati, nasconderli dentro il cavo degli olivi e dietro le pietre dei muri, ché i tedeschi non venissero a perquisire fin lassù, a cercar loro. E domandarsi di come e di quando e di perché, domandarsi a alta voce e nel pensiero, senza mai risolver niente.
Nella casa tra gli olivi dov'erano sfollati, la nonna novantenne semicieca era una grande domanda nera in attesa. C'era una lunga storia di guerre in lei, nella memoria spietatamente lucida: c'era Custoza, c'era Mentana, guerre con trombe, guerre con tamburi; ora bisognava spiegarle dell'esse-esse, della guerra che portava via le madri. Meglio abborracciare una storia di coprifuoco anticipato, di blocco messo dai tedeschi alla città, che aveva impedito alla figlia di tornare, fatto scendere suo genero a tenerle compagnia.
Ma la casa era un bosco di domande e i fratelli preferivano salire a cenare dal comunista. Quel giorno il comunista aveva macellato un vitello per la banda del Biondo e s'era cucinato le trippe: li aveva invitati a mangiare con lui. I fratelli salivano parlando di uccidere.
La casa del comunista era fatta di una sola bassa stanza; vista di fuori, alla notte, sembrava un mucchio di pietre. Poco discosto il vitello squartato era appeso a un olivo. Dentro c'era buio e non candele. I fratelli si sedettero alla tavola bassa, muti, su due ceppi di legno. La donna del comunista riempì loro i piatti di trippa condita e olive. I fratelli scucchiaiavano alla cieca nel cibo spesso. Vicino al soffitto ci fu un fruscìo, come un battere d'ali: nel buio di una nicchia i fratelli distinsero il falco del comunista, Langàn, preso sui monti in primavera, ricordo del grande accampamento di Langàn, favoloso nella memoria dei vecchi partigiani, della grande battaglia perduta nel luglio.
Il bambino, seduto sulle ginocchia della donna, prese a ridere al falco: era un bambino non loro, figlio d'un carabiniere scappato, che era stato affidato al comunista. Allora cominciarono a parlare, prima dell'opportunità di nascondere il vitello finché quelli del Biondo non fossero venuti a prenderselo, poi del perché, del percome, di chi aveva fatto la spia.
Il comunista era un uomo basso, con una grossa testa calva, che aveva girato il mondo e sapeva tutti i mestieri. Era uno che conosceva il male e il bene della vita, vedeva tutto andar male ma sapeva che un giorno andrebbe meglio, era un operaio che aveva letto dei libri, un comunista. Lavorava a giornata per le campagne, perché l'aria della città non era più buona per lui; e lavorava bene, s'intendeva di semine, d'ortaggi. Ma più gli piaceva starsene seduto sui muri a parlare delle cose che si perdono nel mondo, del caffè che si brucia nel Brasile, dello zucchero che si butta in mare a Cuba, delle scatole di carne che marciscono nei «docks» a Chicago. E ricordi suoi, di una vita impastata di miseria, d'emigrazioni, di carabinieri; ricordi di un uomo preso a botte dalla vita, di un uomo che si interessa a tutte le cose, al male e al bene del mondo, e ci ragiona sopra.
Andando per i campi, il fratello maggiore con in mano qualche libro, nascondendosi nei torrenti se mai salisse la brigata nera, il minore sempre a cercar colpi da pistola, caricatori da mitra, lo incontravano che se ne veniva per i sentieri con quel bambino di carabiniere per mano, spiegandogli i nomi delle piante: un ometto calvo con un vestito nero tutto stropicciato. E allora cominciavano a fare dei discorsi: a discutere col maggiore di Lenin e di Gorki, col minore di calibri di pistola, di armi automatiche.
Ora intorno ai fratelli c'era un silenzio gonfio di sangue e rabbia, e le parole ci affondavano dentro. La donna sola poteva dare un po' di calore in quel buio, e si provava a far coraggio; era una donna ancor giovane, un po' sfiorita, di quelle donne con una dolcezza che non si distingue se di madre o di amante, come non esista in loro quel confine; era una compagna di comunista, una che ha capito perché si soffre, e va in città con rivoltelle nella sporta.
Finito di mangiare i fratelli e il comunista presero la via del bosco, con delle coperte sulle spalle, per andare a dormire in quella tana mostrata dal Giglio. Andando per le vigne sentirono un passo nel buio e il minore gridò: - Alto là! Ferma o sparo! - mentre gli altri gli tiravano pugni nella schiena per farlo star zitto. Ma era Walter che veniva a raggiungerli per dormire anche lui nella tana.
Il fratello minore e Walter erano gli inseparabili, sempre in giro per le campagne armati di pistola a seguir piste di fascisti, a fare i prepotenti con gli sfollati, i valorosi con le ragazze. Il fratello maggiore era un tipo più trasognato, come ospite d'un altro pianeta, forse nemmeno capace a armare una pistola. Era capace di spiegare cos'è la democrazia, il comunismo, sapeva storie di rivoluzioni, poesie contro i tiranni; cose anche utili a sapersi, ma che c'era tempo a imparare dopo, finita la guerra. E il fratello e Walter dopo un po' che lo stavano a sentire ricominciavano a litigarsi per una fondina di pistola o per una ragazza.
Ma ora i due fratelli avevano una cosa in comune, qualcosa era cambiato in loro, l'interesse a quella vita che facevano, la posta in gioco, non più qualcosa fuori di loro, ma nel fondo di loro, nel sangue. La lotta, l'odio per i fascisti non erano più come prima, per il maggiore una cosa imparata sui libri, ritrovata come per caso nella vita, per il minore una bravata, un girare per le mulattiere carico di bombe a spaventare le ragazze, erano ormai la stessa cosa del sangue, una cosa profonda in loro come il senso della madre, una cosa decisa una volta per tutte, che li avrebbe accompagnati per la vita.
Era anche il freddo, quando scesero nella tana, che li fece accoccolare vicini, l'uno accanto all'altro. Avevano voglia di sonno, di un sonno pesante che li seppellisse, che cancellasse quel fantasticare che facevano, quell'immaginarsi gli alberghi dove i tedeschi tengono i prigionieri, con gli esse-esse che girano per i corridoi illuminati tutta la notte. Essi avrebbero portato da allora in poi quell'offesa nel fondo più bambino dell'anima, vendicandosi, continuando a vendicarsi anche quando madre e padre sarebbero tornati, offesi alle radici della vita, per tutta la vita. E la cosa che più faceva loro paura era il pensare a quando si sarebbero svegliati l'indomani, e tutt'a un tratto si sarebbero ricordati di cosa era successo.
L'indomani il fratello maggiore era seduto nei terreni gerbidi tra le campagne e il bosco, quando sul mare apparvero le navi e commciarono a bombardare la città. Cominciavano sempre a quell'ora: prima si vedeva lo sparo come una scintilla sulla nave, dopo si sentiva il colpo in partenza, poi l'arrivo. Stava aspettando il fratello che non tornava, andato in giù per notizie; quelle sapute fin allora non erano rassicuranti; la madre trattenuta dai tedeschi come ostaggio, il padre colto da un attacco del suo male, ricoverato all'ospedale.
La città si stendeva sotto di lui sul mare, la sua città ora a lui proibita, con odore di morte per lui nel giro dei suoi viali. E nel cuore della città sua madre prigioniera. E colpi di cannone, come pugni, dal mare striato azzurro teso, come dal vuoto, contro la sua città, contro sua madre.
Qualche polveriera doveva esser esplosa nella città: si sentiva un susseguirsi fitto di colpi che non venivano dal mare. Presto una nuvola si alzò sulle case, con punti neri che vorticavano in cima; gli scoppi riempivano le vallate. Se il fumo diradava, si distinguevano le case smantellate che andavano in rovina.
Allora il ragazzo pensò a se stesso, stracciato, braccato per i boschi, col padre all'ospedale, la madre prigioniera, con la sua città, la sua casa che gli rovinavano sotto gli occhi, con suo fratello che non tornava e forse era stato preso, eppure sentì di trovarsi quasi tranquillo, come nel giusto, nel normale, come se la vita fosse normale così come in quel momento era per lui.
Arrivò il fratello con un recipiente pieno di polenta e notizie migliori: il padre faceva il malato per non esser preso e voleva farsi piantonare all'ospedale perché lasciassero la madre; la madre era ostaggio e mandava a dire di stare attenti e non in pensiero per lei; in giù i mezzi d'assalto della decima-mas saltavano in aria e distruggevano mezzo paese.
Con lui era salito il Giglio che s'entusiasmava vedendo il bombardamento, da quell'animaccia che era, e batteva il pugno sulla palma, gridando: Alé! Alé! Dacci dentro! Butta giù tutto! Casa mia per la prima! Tutti i fascisti morti! Tutti gli altri salvi! Qualche ferito! Dacci dentro! Casa mia per la prima!
Il giorno dopo andarono col comunista all'accampamento del Biondo, a portare la carne di vitello. Gli uomini erano armati fino ai denti, scendevano in città tutte le notti, a piantare sparatorie.
Arrostirono un quarto di vitello allo spiedo e si misero a mangiarlo tutti insieme attorno al fuoco. Parlavano dei compagni uccisi e torturati, dei fascisti giustiziati e da giustiziare, dei tedeschi che si sarebbe potuto eliminare.
- Però, - disse il fratello maggiore, - è meglio che i tedeschi non li tocchiamo. Ché fra gli ostaggi c'è mia madre ed è meglio non scherzare -. Ma c'era qualcosa nelle parole da lui stesso dette che non lo persuadeva, come una rinuncia, come avesse abbandonata in quel momento sua madre a chi gliel'aveva presa. E si vergognò del silenzio che seguiva le sue parole.
Al ritorno, parlando col fratello disse: - Questa vita di ribelli di lusso non ho più testa a farla. O facciamo il partigiano o non lo facciamo. Uno di questi giorni sarà bene che pigliamo la via dei monti e saliamo con la brigata.
Il fratello disse che ci aveva già pensato.
Poi, tornando, si fermarono alle Rocche del Corvo, a fischiare al Giglio. E mentre lo aspettavano seduti sull'orlo del burrone, il comunista s'andava domandando di come s'erano formate le rocce, e i burroni, e le montagne, e di quanti anni aveva la terra. E tutti insieme discutevano degli strati delle rocce, delle ere della terra e di quando la guerra sarebbe finita.
A una cert'ora del mattino cominciavano ad arrivare le mogli dei prigionieri e si mettevano a far gesti, con il viso alzato verso le finestre. Dall'ultimo piano loro si sporgevano a domandare, a rispondere; e le mani delle donne, a basso, e le mani degli uomini, lassù, sembrava volessero raggiungersi attraverso quei metri d'aria vuota. Il grande albergo da poco degradato a caserma e a prigione non aveva oggetti che servissero all'animo per concretizzare quel senso di libertà perduta, come inferriate o muraglie. A nutrire la loro angoscia restava solo quella verticale lontananza dagli uni agli altri, breve ma pure disperata, da quelli con i piedi sulle aiole, ancora padroni di se stessi, fino a quegli altri condotti lassù come già a paesi senza via di ritorno.
Ogni tanto uno dei prigionieri che erano alla finestra si voltava verso il corridoio e chiamava un nome: - Ferrari! Ferrari! C'è tua moglie di sotto! Il chiamato si faceva largo alla finestra già affollata e cominciava a fare magri sorrisi, gesti che volevano essere rassegnati.
Diego non s'affacciava mai; la sua famiglia era lontana, dispersa dalla guerra. Egli era stanco di quell'ininterrotto ondeggiare di previsioni, di supposizioni, di notizie buone e cattive che l'andirivieni nel giardino dell'albergo spingeva fin lassù. S'infiltrava in lui con la stanchezza dei nervi un gusto di lasciarsi andare alla deriva, verso la rovina o verso una sempre sperata miracolosa salvezza, una voglia di estati trascorse steso sull'arena a fior d'acqua, voglia lasciata in lui dalle sue troppe estati d'acqua e arena che l'avevano portato fin là, pigro e sprovveduto, a quella sua prima estate utile, che ora finiva.
Ma il tempo era una ragnatela di nervi tesi, un "puzzle" che si può comporre in mille figure, tutte senza senso. Smarriti, gli uomini imprigionati a caso per le vie camminavano avanti e indietro sul linoleum delle stanze nude, dove solo ghignavano le labbra bianche dei lavabo e dei bidè, otturati d'acqua putrida.
Il giorno prima, condotto là dalle prigioni del forte, dove era stato un giorno e una notte con altri uomini ora forse uccisi, gli era sembrato di venir dissepolto, a ritrovarsi nell'albergo arioso, con intorno il calore di quegli uomini ignari e facili alle speranze. Aveva riso e scherzato, ritrovandoli; anche Michele, il compagno insieme al quale era stato preso, era tra i prigionieri dell'albergo. Si fecero festa al rincontrarsi sani e uniti, dopo che per un giorno e una notte, divisi, avevano temuto l'uno per l'altro. Diego s'era sentito commosso e insieme più forte a accarezzare il ruvido del cappotto di Michele, il liscio della sua grossa testa calva che gli arrivava al petto. Michele ridacchiava nervoso, con la sua bocca mal dentata e chiedeva: - Che dici, Diego, glielo faremo il bidone ai nazisti? - Diego disse: - Io dico che glielo faremo. Il bidone a tutto il Grande Reich, faremo. - Anche a Von Ribbentrop? Anche a Von Ribbentrop. Anche a Von Brautschisch. Anche al dottor Goebbels -. E s'erano accucciati a ridosso d'un freddo termosifone, a smaltire il nervosismo in risa e scherzi (ancora non sapevano che parecchi presi con loro erano già stati uccisi) e in Diego era la contentezza di chi esce dal carcere dopo anni.
Il carcere era una vecchia fortezza sul porto, dove allora era installata la contraerea tedesca. La cella dove eran stati rinchiusi era servita da prigione di rigore per i soldati tedeschi; sui muri erano frasi scritte in tedesco di soldati pederasti: "Mein lieber Kamarad Franz, mio caro camerata Franz, io sono qui rinchiuso e tu sei lontano da me". "Mein lieber Kamarad Hans, la vita era felice vicino a te".
Loro erano in una ventina, nella stretta cella, stesi in terra uno a fianco dell'altro. Un vecchio con la barba bianca, vestito da cacciatore, padre d'uno di loro, s'alzava ogni tanto nella notte scavalcando i loro corpi e andava a orinare in un angolo, con sforzo. La latta nell'angolo era bucata dalla ruggine; in breve l'orina del vecchio invase il pavimento della cella, sotto i loro corpi, come un fiume. Disumani urli di comando, come di uomini che vogliono cambiarsi in lupi, s'alzavano dagli echi della fortezza a ogni muta di sentinella.
L'inferriata dava sulla scogliera; il mare rogliava tutta la notte spinto negli scogli, come il sangue nelle arterie e i pensieri nelle volute dei crani. E ognuno aveva in testa l'angolo di strada che non avrebbe dovuto girare, per non finire là dentro: Diego, nell'angolo di strada che, scantonando con Michele per sfuggire alla retata, l'aveva messo faccia a faccia coi tedeschi bardati a guerra che fermavano i passanti in mezzo alla via, a tre metri da loro, come all'apritiscena d'un film.
Era una catena di sensazioni e d'immagini che continuava a sgranarsi nella sua mente come un rosario, per ripersuaderlo che non poteva succedere altrimenti, mentr'era rinchiuso nella cella con le scritte dei pederasti tedeschi sui muri e il vecchio che continuava a orinare nel buio, così come ora tra gli stucchi scrostati dell'albergo, in quell'ultimo piano come sospeso tra morte e vita, con uomini proni sui pavimenti quasi presi da vertigine.
Ogni giorno un certo numero di loro veniva smistato: alla vita o alla morte. Al mattino salivano il maresciallo e Pelle-di-biscia con un fascio di documenti in mano: quelli a cui restituivano i documenti erano liberi ed uscivano. Li si vedevano abbracciare le mogli e allontanarsi a braccetto, calpestando l'erba delle aiole, sotto la pioggia d'invidia dei loro sguardi.
Alla sera invece una camionetta grigio-piombo con soldati armati seduti intorno veniva a fermarsi davanti all'albergo; il maresciallo e Pelle-di-biscia salivano a chiamare altri nomi; qualcuno di loro andava via ogni sera in mezzo agli elmi di quei soldati. L'indomani le loro donne sarebbero venute a chiedere sotto le finestre, e girare da un Comando all'altro supplicando gli interpreti: nessuno sapeva dov'erano stati portati. Altre donne avrebbero parlato di spari sentiti a sera, verso i quartieri evacuati del porto.
Anche per Diego e Michele l'alternativa era questa: libertà o morte, o i loro documenti erano riconosciuti per buoni, e allora era il grande bidone a tutto il Reich, da raccontarsi nei casolari alla sera tra le risate dei compagni, oppure era la camionetta grigio-piombo che spariva tra le case sinistrate verso il molo, Pelle-di-biscia che aveva fatto la spia.
Pelle-di-biscia li aveva passati in rivista appena condotti là, in fila davanti all'albergo, per vedere se riconosceva qualche suo ex compagno. Camminava carezzandosi le mani che doveva aver sudate, Pelle-di-biscia, gracile ragazzo nella divisa di tela attillata, con un sorriso umido sulle labbra sbavate dall'arsura. Aveva dei baffi incerti di peluria biondiccia, pallido, col raffreddore che gli arrossava le narici e le palpebre. Gli occhi gli luccicavano di commozione a sentirsi lui, gracile ragazzo, arbitro della vita di quegli uomini che trattenevano il respiro a ogni sua parola, a ogni suo gesto.
Erano momenti di trionfo inebriante per lui, ma sempre popolato d'angoscia; ogni volta che appariva per i corridoi dell'albergo i rinchiusi gli si affollavano intorno per domandargli, per raccomandargli, lo chiamavano per nome: - Tullio, Tullio -. Lui guardava quegli uomini docili intorno a lui, ma vedeva l'odio emergere affilato dietro alla loro umiltà, a uno di loro aveva detto: - Oggi mi fate la corte, domani mi sparerete nella schiena.
Pelle-di-biscia ora salvava ora uccideva: era lunatico e ambiguo. Molti che l'avevano conosciuto prima, quand'era dei loro, s'eran creduti persi vedendosi interrogati in sua presenza: lui aveva finto di non conoscerli. Altri che lo speravano clemente per vecchi favori o amicizie l'avevan visto scoprire le gengive contro di loro, metterli in gioco come topi. Pelle-di-biscia ora sembrava perduto sulla via del sangue, ora in preda ai rimorsi.
Passandoli in rivista s'era fermato davanti a Michele e aveva detto: - Noi due ci siamo già visti in qualche posto -. Michele aveva ritratto il collo come se una goccia gli fosse scesa fredda per la schiena e aveva fatto una smorfia d'ignoranza con la faccia stranita.
Diego sedeva sul pavimento a piastrelle del corridoio, con le mani sui ginocchi. Michele era accanto a lui, affacciato alla finestra. Attendeva sua moglie, andata a parlare con Luciano, un interprete dell'esse-esse che lavorava per il comitato e che s'era impegnato a farli uscire. La moglie di Michele era assai più giovane di lui, sposa da ragazza. Aveva grandi occhi grigi nuvolosi, qualcosa di severo nel viso, incorniciato di capelli lisci e neri, qualcosa d'allegro nel corpo magro, nella corta veste lilla. Rincresceva, a vederla, che la vita fosse quella che è, dolorosa e oscena, e tutto non fosse risolto e tranquillo. A Diego sarebbe piaciuto con una donna come quella girovagare per paesi soleggiati e senza ingiustizie.
Disse: - Se la scampiamo, finito tutto, voglio tornare in questo albergo per una settimana, quando si riaprirà ai turisti -. Michele non rispondeva. Diego disse: - Mi sdraierò in terra proprio qui come sono ora, in mezzo a tutti quei signori dignitosi che mi crederanno matto. Michele restava affacciato, non si voltava. Poi si girò e disse in fretta come stesse per sfuggirgli di mente: - Diego, se vuoi del pane mia moglie ne ha portato. L'ha dato a un milite che ce lo dia -. Diego domandò: - É venuta tua moglie? Ha parlato?... Michele non lo guardava in faccia, teneva lo sguardo alto sul soffitto. - Di', Diego, per me non c'è più nulla da fare. Pelle-di- biscia m'ha venduto. L'ha detto Luciano a mia moglie. É là sotto che piange -. Così disse Michele; nelle sue parole c'era la semplicità delle cose a lungo temute, una volta che avvengono.
Michele aveva preso a camminare avanti e indietro per il corridoio, con le mani nelle tasche, gli occhi enormi nelle palpebre che gli pesavano aperte. Talvolta gli altri gli rivolgevano la parola e lui li guardava smarrito, come dovesse tornare da smisurate lontananze per riaccostarsi agli oggetti del loro discorso. Forse pensava al vuoto, come per abituarsi a non esistere.
Diego seguiva il passeggiare di Michele da distante, quasi con ansia che gli altri ignari disturbassero quella camminante agonia: un accenno dei loro discorsi di vivi sarebbe bastato a farlo a un tratto disperato per la vita perduta. Egli solo di tutti loro sapeva che quell'uomo per il corridoio camminava verso la morte, distante ormai solo mille, duemila passi. Quella era la sua veglia funebre: era un morto che passeggiava nella sua camera ardente, in quel corridoio dai rosoni di stucco scrostati ai soffitti e dalle impronte sbiadite delle specchiere sopra i camini di marmo.
Diego pensava a Michele, vegliandolo: un compagno anziano, Michele, un brav'uomo, pur con tutti i suoi difetti; non molto coraggioso, non molto in linea col partito. Spesso avevano litigato, per quella mania di Michele di sputar sentenze e di voler sempre ragione, con la sua prosopopea d'autodidatta.
Ora Michele camminava per il corridoio, con le mani nelle tasche del cappotto, la grossa testa calva incassata nelle spalle, i grossi occhi bovini perduti nel vuoto, come sbigottito dell'enormità di quanto stavano per togliergli. Era un povero uomo basso e calvo, in un vecchio cappotto, con la barba di tre giorni; ma a Diego parve di vedere in lui, in quei suoi occhi bovini, in quel suo camminare lento e assorto una forza minacciosa della natura, gli parve che Michele avrebbe continuato a camminare così anche dopo morto, che sarebbe entrato l'indomani nelle sale dove gli ufficiali tedeschi facevano i bagordi, dalla finestra, diventato grandissimo, ma sempre nel suo povero cappotto, con le mani nelle tasche, la testa calva con lo sguardo bovino perduto nel vuoto, e avrebbe camminato con quel suo lento passo sulle tovaglie macchiate di spumante, in silenzio, davanti agli alberi di Natale illuminati, alle croci di ferro luccicanti, al nudo delle mammelle e delle natiche imbandite, tra il terrore degli ufficiali tedeschi e i gridi delle donne. E così avrebbe continuato a camminare, anche finita la guerra, e i ricchi non avrebbero avuto pace nei loro palazzi, non gioia nelle loro famiglie, senza che quest'uomo basso e smisurato non fosse entrato dalle finestre a traversare le loro stanze; e sui tavoli attorno a cui si decide la pace e la guerra e in tutti i luoghi dove s'impedisce o si toglie o si mente, dove si predica il falso, dove si adorano iddii ingiusti, sempre sarebbe apparsa l'ombra dell'uomo ucciso la sera sul molo.
Qualcuno dei prigionieri parlò d'uomini impiccati dai tedeschi; Diego vide Michele appeso a un lampione del porto, gli occhi enormi, le mani strette ancora nelle tasche. E gli parve che a uccidere Michele fossero stati tutti gli uomini, tutti loro, una colpa senza limiti che doveva togliere ogni gioia alla vita, da espiarsi nei secoli dei secoli.
Sopra i cerchi nell'acqua dove Michele era scomparso galleggiava solo il suo cappotto vuoto, a braccia aperte come una croce. La campana della boa rossa in mezzo al porto suonava a morto per il compagno ucciso, mossa dalle onde. Sotto l'acqua la gomena che teneva ancorata la boa finiva in un nodo scorsoio, con la testa di Michele dentro. Ma la testa di Michele veniva a galla, verde d'alghe, gli occhi sbarrati; dava un urlo. Il vecchio padre vestito da cacciatore s'alzava nella notte e cominciava a orinare gemendo, enorme sopra tutti loro. I fiumi straripavano, tutti gli uomini cattivi e buoni venivano sommersi. Gli organi del vecchio, stanchi per aver generato tutti gli uomini, ora annegavano l'universo. Solo Pelle-di-biscia fuggiva per la terra in cerca di scampo, carezzandosi le mani sudate, umide dell'acqua putrida dei bidé dell'albergo. Ma ogni bara era occupata da un morto, ucciso da lui; la fiumana lo circondava da ogni parte, lo travolgeva in un gorgo.
La camionetta era in ritardo quella sera e tutti dicevano con sollievo che non sarebbe venuta. Michele aspettava affacciato nell'imbrunire. Arrivarono invece quattro torpedoni da turismo, guidati da soldati tedeschi. Ci fu dell'agitazione tra i rinchiusi, un domandarsi, un supporre. Subito salì il maresciallo con l'elenco e li chiamò uno per uno. Michele e Diego furono chiamati insieme agli altri, con i nomi falsi che avevano dato; anzi il nome di Michele il maresciallo lo pronunciò storpiato, come se non l'avesse mai inteso.
I prigionieri furono divisi in quattro squadre e fatti entrare a uno a uno nei torpedoni. Diego e Michele si ritrovarono vicini, ancora uniti a quella folla quasi gelosa dell'ingiustizia subìta. Tra le voci ansiose di quegli uomini girò un nome partito non si sapeva donde: - Marassi, Marassi. Ci portano a Marassi -. Ma quel nome quasi rassicurava Michele e Diego, voleva dire lasciare quell'angoscia di morte vicina, il Pelle-di-biscia ambiguo, i luoghi noti gremiti d'insidie.
Diego sentiva il ruvido cappotto di Michele sotto le sue dita, il sangue riguadagnare le loro arterie. Disse: - Te l'avevo detto che Luciano è un contaballe? Te l'avevo detto? - E Michele ripeteva: - Che contaballe, di'! - con un sorriso già più sciolto, come se apprezzasse uno scherzo.
E i due compagni compresero che qualunque fosse il loro destino da allora in poi, di sangue, d'urli, di sfinimento, pure avrebbero sentito il gusto sanguigno dell'essere vivi e del dividere il dolore come il pane. Un ruvido sapore di vita li avrebbe accompagnati da allora in poi, nei cunicoli urlanti di Marassi, nei baraccamenti desolati del Nord, fino al ritorno.
Il male cominciò a nascergli così: vedere il cavallo di frisia per la scala, carico di filo spinato, e pensare che contenesse un significato minaccioso e allusivo sul suo avvenire. Ma già prima, più d'una volta, la vista della sua branda era bastata a tormentarlo, di quella sua sgraziata, scheletrica branda, che pareva volesse annunciare qualcosa, qualcosa che lui non capiva, un messaggio di disperazione, d'impotenza. Quattro cinque sei brande, poi la sua, poi altre due tre quattro brande. Erano pensieri senza senso: se ne accorse.
Eppure, una due tre brande, forse gennaio febbraio marzo, giugno, luglio, cosa gli era successo in luglio? poi quella branda vuota, perché? agosto, settembre, ottobre, novembre. Qualcosa finiva a novembre: la guerra? la vita?
E bisognava poi tener conto che le prime cinque brande erano degli anziani, dei soldati che si erano presentati col bando, alcuni all'otto settembre non avevano nemmeno smesso di fare il militare, e ora montavano di guardia e giravano armati; nelle altre brande invece i renitenti, i rastrellati come lui, che spazzavano e trasportavano immondizie. Poi c'era il mistero di quella branda vuota e chiusa, agosto, aprile? dove stava certo nascosta qualcosa sperata o temuta, la pace, la morte, ma ancor più qualcosa di segreto e ostile, che non si poteva comprendere.
Oppure, a cominciare dal fondo, gli anni di guerra: quaranta, quarantuno due tre quattro, perché quarantaquattro vuoto?, e lui quarantacinque: che senso c'era in tutto questo?
Si sdraiò sulla branda chiusa, la schiena sui ferri delle sponde, i piedi sulla catena che la teneva legata. Adesso avrebbe pensato con calma, ragionando: non c'era motivo d'angosciarsi tanto, bastava attendere con pazienza che l'affare dei suoi si risolvesse, che suo padre fosse liberato, poi disertare, tornare in banda, per il momento cercare d'ottenere una convalescenza, un imboscamento, una maniera legale per «sganciarsi», stare con gli occhi aperti per non farsi mandare «di sopra» con la compagnia dei rastrellamenti, e al minimo accenno d'un trasferimento a Nord o a Sud essere pronto alla fuga, andasse come voleva.
Bastava questo: e poi il carretto per trasportare la spazzatura aveva un'aria sgangherata e amica, insegnava a prender le cose in ridere, anche se era penoso farle, ché poi tutto si sarebbe risolto. Alt, si tornava da capo: il male dei simboli, la via della pazzia.
Il male, a rifletterci, gli era cominciato in prigione, la notte dopo esser stato preso: il rumore del mare, fuori, come un ronzio d'aeroplani, la speranza e la paura d'un bombardamento che li avrebbe liberati o sepolti. Ma era il mare confuso, senza ritmo, senza sfogo; la vita, una cosa cieca e caotica. Da allora in poi le cose e gli uomini non furono più loro stessi ma simboli.
Le celle della prigione, gli uffici squallidi, i volti nervosi degli ufficiali tedeschi e fascisti, gli alberghi fastosi e devastati gremiti dalla folla spaurita degli ostaggi, la caserma infine con la sua angosciosa geometria di scale, corridoi e camerate deserte, i suoi abitatori ottusi e pallidi, tutte maglie di una rete di disperazione che stringeva il mondo.
Ora i vetri della grande finestra erano quadrati e dipinti di turchino, ma il terzo della seconda fila mancava, il penultimo aveva una grossa fenditura: e questo era doloroso, terribile. Impossibile resistere alla tentazione di seguire quella mosca che passava da un vetro all'altro e di chiedersi dove si sarebbe fermata. Era lo stesso calcolo che si riproponeva sempre. La fine della guerra e la morte. Ma sarebbe arrivata prima l'una o l'altra?
Gli uomini della caserma erano resi solidali da una comune viltà, menti torpide d'ignoranza, volti camusi, obbligati a trattare ogni cosa con termini volgari per avvilire se stessi. I loro discorsi vertevano sulla paga, sulla vita buona che si faceva nella «repubblica», migliore d'ogni altra vita possibile allora, e sul fatto che la vita della caserma e quella in particolar modo della compagnia-deposito era migliore che in ogni altro reparto. Ingigantivano questo loro amore alla paga e alla vita della compagnia quasi per convincersi che non potevano fare a meno di restare là dentro.
Il ragazzo rastrellato, a vivere in mezzo a loro, sentiva questo grosso fiato di viltà affoltirglisi intorno, congiungersi a una sua vena segreta, e il rampicante polveroso che cresceva a tappezzare le mura del cortile tappezzava lui pure, era un insinuarsi di solidarietà tra lui e loro, che l'inchiodava a quelle mura, a quelle brande.
Al piano di sopra stava la compagnia dei rastrellamenti, ovvero l'incoscienza. Avevano rancio migliore, migliore paga, licenze frequenti. Tornavano a tutte le ore facendo baccano per le scale; dal piano di sotto si sentivano spesso cantare e suonare dischi. Da ogni loro parola, da ogni loro gesto spirava l'incoscienza, un'incoscienza voluta, mantenuta a forza, costretta a regola di vita, per non pensare a quello che facevano. Spesso uscivano la mattina presto, inquadrati, qualcuno armato di mitra; tornavano la sera o l'indomani; non combattevano mai, né incontravano «ribelli»; ma saccheggiavano pollai e accalappiavano sempre qualche sparuto renitente, che veniva a ingrossare la compagnia del piano di sotto.
Nella compagnia-deposito, quelli del piano di sopra erano odiati anche dagli anziani; la loro superficialità era guardata con astio da chi passava le ore a calcolare e a discutere sui guadagni e sui pericoli; l'invidia fioriva i loro vantaggi di previsioni sinistre. Allora cominciavano nella camerata le discussioni su quelli della montagna e sugli inglesi, su chi sarebbe arrivato per primo, e che se arrivavano prima quelli della montagna, forse tutti loro soldati sarebbero stati uccisi, ma loro non facevano niente di male, e quindi non era giusto; invece gli inglesi, se fossero arrivati per primi, avrebbero trattato meglio loro soldati che i ribelli, e li avrebbero tenuti a fare i soldati con loro, e avrebbero messo i ribelli in galera.
Poi, finita la guerra, molti di essi sarebbero tornati chi in Sicilia, chi in Calabria, chi nelle Puglie, alle loro case lasciate per chi da venti, per chi da quindici mesi, distanti come al di là d'un buio tunnel lunghissimo in cui una talpa si muoveva lenta, scavando per ricongiungerli, la guerra. Sempre, a quel punto, cominciavano le congetture su quando la guerra sarebbe finita e tutti convenivano nel dire che sarebbe durata ancora molti anni; e il mulattiere dalla faccia gialla usciva a dire che non sarebbe finita mai, ma sarebbe venuta prima la fine del mondo, e almanaccava tutta una storia in cui Gesù Cristo e la colomba di Noè emergevano dal suo incomprensibile urlìo.
Gran parte degli anziani era formata da meridionali, incalliti dagli anni di esercito in una loro torpida astuzia, usi a lasciarsi sballottare d'Africa in Russia con una sorta di guardingo fatalismo. I settentrionali che erano in mezzo a loro avevano imparato a usare i loro modi di dire e li ripetevano con monotonia esasperante. Il ragazzo rastrellato aveva rabbia a sentirli interloquire nelle loro discussioni incomprensibili. «Se rimango ancora un poco con loro, - pensava, - capirò i loro ululati, prenderò anch'io l'abitudine di dire "minchia, signor tenente" e "sticchio" e "soreta"». Questo pensiero bastava a farlo rabbrividire, alzare dalla branda e vagare per i corridoi e i magazzini.
Ma gli elmi allineati, a pile, erano inutili e stupidi come il mulattiere dalla faccia gialla.
I discorsi preferiti dei soldati erano quelli sulla roba che avevano portato via l'«otto settembre , e su come avevano fatto a trafugarla, a salvarla dagli ufficiali e dai tedeschi, e sui soldi che s'erano fatti vendendola. Il mulattiere dalla faccia gialla, che all'otto settembre non aveva portato via neanche una coperta, stava zitto, con vergogna, mentre un ex cameriere sanremese raccontava di com'era scappato d'in Francia con dieci sterline d'oro nel sospensorio. Ma l'invidia si tramutava in odio verso gli ufficiali che avevano potuto far sparire la cassa dei reggimenti, senza starla a dividere coi soldati. Quando verrà il prossimo «otto settembre», - diceva ognuno, - staremo più all'occhio. - E facevano progetti e castelli in aria sulla roba che avrebbero potuto portar via il secondo «otto settembre», sui milioni che avrebbero potuto fare.
Così era la loro vita: un seguito d'anni grigi come una fila in marcia, con un «otto settembre» ogni tanto, un rompere le righe, un piglia-piglia, un fuggi-fuggi cogli zaini carichi di roba del Governo, per tornare poi in fila, ad attendere un altro "otto settembre" e ripetere il gioco. Il ragazzo rastrellato stava sdraiato sulla branda chiusa e scomoda e i discorsi dei soldati erano polverosi sopra di lui come le ragnatele del soffitto.
Il suo ricordo andava ad altri uomini, ad altri discorsi, discorsi di uomini seduti intorno a fuochi di uomini con suole legate col fil di ferro, con strappi ai calzoni cuciti col fil di ferro, con facce ispide di fil di ferro nelle barbe, uomini con arnesi di ferro nelle mani: uomini con sten, uomini con mitra, uomini con machine. Ogni tanto un nome di quegli uomini risuonava nei discorsi dei soldati, con accento di mistero, di leggenda, di paura: solo per lui quei nomi avevano un volto, una voce. Avrebbe voluto gridare sulle facce pavide dei soldati: «Sì, io conosco il Lungo! e Bill! e Mingo! e il Zanzara! Tutti li conosco! Quindici giorni fa sedevo vicino al fuoco con Mingo che voi vi sognate alla notte! Fumavo una sigaretta a mezzo con Strogoff, quello che scese fin qui in città a liberare i carcerati, mettendovi spavento per un mese! Mangiavo le frittelle insieme a Sceriffo che non ha più rigatura nella canna della pistola a furia di spararvi addosso! Alla battaglia di Baiardo portavo le munizioni a Bufera! Io sono uno dei loro!»
Questo avrebbe voluto gridare. Io sono uno dei loro. Ma allora, se era uno dei loro, cosa faceva lì in mezzo? E con slanci violenti la memoria si riproponeva freneticamente scene e sensazioni per risvegliare un qualcosa sopito in lui, forzarlo a uscire dal torpore.
La carrozzabile, in basso, con la fila dei tedeschi che sale guardinga, e il battito del cuore contro il calcio del mitragliatore, attendendo, e ogni cespuglio che fiorisce d'occhi in agguato. Poi un crepitare fitto che dà il via, un polverone dorato che s'alza sulla carrozzabile, sui tedeschi che s'abbattono, che si gettano fuori strada, comandi urlati dalle voci rauche dei capibanda che s'incrociano con quelli bestemmiati in tedesco, con le voci venete e lombarde dei bersaglieri, raffiche, ta-pum, bombe a mano, partigiani stracciati che dilagano sulla strada a far bottino verso gli autocarri grondanti di sangue.
Di sentinella la notte, entrare un momento nel casone, ad accendere la sigaretta nella brace semispenta, ad attizzare il fuoco per scaldarsi, mentre i compagni russano sulla paglia e si grattano nel sonno: poi, fuori, attendere una stella cadente per affidarle un pensiero, sempre lo stesso, mentre lontani, spietatamente fermi brontolano i cannoni del fronte.
A sera, quando nella caserma si accendevano le luci e solo i piantoni restavano nelle camerate fredde, il ragazzo rastrellato pensava alla nebbia fredda che sale ogni sera sui monti, ai prigionieri fascisti scalzi, con un riso di paura in mezzo ai denti, che vorrebbero rendersi utili, pulire le patate, andare per acqua, per legna: vengano con noi per legna, vengano nel bosco, nella nebbia, vadano avanti nella nebbia che attutirà lo sparo.
Altri uomini, altri discorsi sui monti, uomini che camminano, digiunano, sparano, ma non per obbligo o paga, o divertimento a quello che fanno, uomini diventati cattivi a furia d'essere buoni, uomini che adesso, a sera, cantano intorno al fuoco delle castagne canzoni imparate in galera,- seri come a inni di chiesa. E discorsi di anziani sulla guerra di Spagna, su scioperi con spari di soldati, discorsi di vita segreta e di galere, discorsi di uomini che soffrono la legge e vogliono rifarla, non come cani alla catena, non come lui adesso.
E la memoria, appena posti, ribeveva i ricordi, con paura quasi, come potessero essere visti dagli altri, dagli ufficiali, tradirlo, denunziare lui, «il ribelle». La caserma, enorme monumento dell'ingiustizia diventata legge, incombeva ancora su di lui con le sue scale di pietra, le sue porte scrostate, i suoi uffici squallidi, i suoi cavalli di frisia, a condannare quegli imprudenti slanci della memoria.
Gli altri rastrellati si facevano sempre più torpidi e più grigi anch'essi, pieni d'accettazione, d'indifferenza, e ognuno negli interrogatori aveva una scusa alla propria condizione di renitente, un margine di legalità cui aggrapparsi: un tesserino della "Todt" scaduto, l'aeronautica che non era stata chiamata, la convalescenza della pleurite. Lui solo restava come nudo nella sua grezza condizione d'eslege, e si sentiva intorno il tepore ovattato della legalità e uomini che ci si crogiolavano, già contenti.
La caserma lo incatenava nella geometria dei corridoi, delle scale, delle terrazze; anch'egli tra poco avrebbe pensato che finché il governo paga è meglio esser dalla parte del governo ed evitare fastidi alla famiglia, che nella «repubblica» si sta meglio che nel «regio» perché non c'è bisogno di star sull'attenti davanti agli ufficiali, si mangia a mensa e si possono vendere le coperte da casermaggio senza pagare l'addebito; anch'egli tra poco avrebbe riso alle battute oscene del tenente cogli occhiali, quando canzonava il mulattiere dalla faccia gialla.
I partigiani svaporavano nella sua memoria come un mito, un ricordo di antiche età dell'uomo; titani generatori di nuove leggi, distanti da lui quanto la sera dalle caserme apparivano lontane le montagne, di là dai vetri rotti delle grandi finestre. Il muro che separava la caserma dalla campagna degradante a terrazze era il confine di due categorie dell'anima. La palizzata che il colonnello faceva alzare per prevenire gli assalti dei ribelli era un muro di ferro che si alzava nella sua coscienza.
Poi vennero giorni folti d'ansia in cui serpeggiavano voci di trasferimento, di liste che qualcuno aveva visto in fureria, di rastrellati che verrebbero mandati a Monza o a Treviso o a Bolzano. Lui sentiva il cerchio stringerglisi intorno, avvicinarsi il giorno in cui il suo istinto di conservazione l'avrebbe forzato a uscire dal torpore, gli avrebbe dettato il momento più propizio alla fuga.
Attendeva passivamente, sentendosi ogni giorno di più come il mozzicone sul pavimento della camerata, spinto a colpi di scopa. E le cose della caserma gli si proponevano come margherite da sfogliare per carpire un segreto, come oroscopi ambigui sul suo avvenire, il cavallo di frisia per le scale era dentro di lui, gli oggetti e i volti si susseguivano ai suoi occhi come capitoli di una storia che non si sapeva dove e quando sarebbe finita.
Dopo vi furono le giornate tese in cui pareva che il trasferimento fosse imminente e si dicevano i nomi della prima lista, e il suo non c'era. Perché c'era un'altra lista, di quelli che sarebbero partiti dopo una quindicina di giorni, e lui era tra questi. Così il risveglio dall'angoscia si rimandava, c'era ancora tempo di sperare alla Grande Avanzata che avrebbe liberato tutti dall'oggi al domani, al Grande Bombardamento che avrebbe ucciso tutti gli abitanti della caserma, lui escluso, alla gamba che si sarebbe rotto per caso e l'avrebbe tenuto all'ospedale fino alla fine della guerra, a suo padre che forse sarebbe stato liberato e avrebbe potuto mettersi al sicuro dalle rappresaglie con tutti i suoi...
Il mattino della partenza del primo scaglione, tre o quattro mancavano all'appello, ragazzi quieti, rassegnati, che non ci si sarebbe aspettato scappassero. I rimasti, sorvegliati da qualche anziano armato che li avrebbe accompagnati di scorta, sedevano a capo chino nella camerata aspettando il camion, un velo di pianto in fondo agli occhi e alle voci. Egli girava in mezzo a loro; sguernite dei teli le brande erano presagi ansiosi ed inquieti.
Fu allora che entrò il tenente con gli occhiali, grassa faccia camusa, gli faceva cenno di avvicinarsi, certo voleva mandarlo a spazzare le scale. Disse: - Su, presto, prepara la tua roba, parti anche tu, è venuto l'ordine dal comando.
Un velo di sangue agli occhi, poi tutto fu spaventosamente lucido, come in un mondo di specchi: il tenente, le parole che aveva dette, le inutili proteste di lui, i compagni rassegnati, la camera squallida, il suo arraffare la roba con mani tremanti e metterla nello zaino, la sua storia, la sua debolezza, la tristezza del suo destino, ogni cosa era quella che era; solo quella, spietatamente quella.
Il male dei simboli lo riprese nel viaggio in camion, ma senza sollievo. Il camion era il mondo e la vita, con uomini diversi, spietati l'uno dell'altro, borghesi che parlavano delle cose che avrebbero fatte finita la guerra, avrebbero comprato la macchina e non più viaggiato in camion, il tenente con gli occhiali che rideva dicendo: - Se adesso scoppiasse la pace! - con un tono di timore nel suo accento ignorante di terrone.
Il grasso ragazzotto di Oneglia che a ogni fermata si guardava intorno fiutando il modo di scappare era una parte di lui, del suo animo ancora cautamente desto, il soldato veneto anziano che gli stava sempre dietro col moschetto imbracciato (Cecchetti si chiamava quella carogna) era pure una parte di lui, la sua viltà dominante. Gli altri compagni di sventura, carichi di rassegnazione desolata, erano il peso della sua impotenza. E in mezzo a tutti, stupido e beato anche nel nome, la bestia umana grassa ed incosciente, l'occhialuto tenente Coronati che scherzava in terrone con gli autisti.
Poi il guasto al camion suonò come un avvertimento. L'ultimo simbolo fu l'alberghetto dove si fermarono a far colazione, con linde stampe inglesi alle pareti, una atmosfera cloroformizzata da sala operatoria, un limbo dove le anime attendono il giudizio.
Quando furono condotti a piedi al paese vicino e, poiché il camion tardava a venir riparato, si sparpagliarono un poco a comprar da mangiare nelle botteghe, l'incubo cessò a un tratto: la strada che portava nei campi fu una strada che portava nei campi, il veneto voltato indietro ad aspettare gli altri fu il veneto voltato indietro, il ragazzo grasso di Oneglia cui lui chiese: «Scappiamo»? e che rispose «Alé,» fu il ragazzo grasso di Oneglia, la terra che correva sotto i loro passi fu la terra che correva sotto i loro passi, l'angolo di muro che li separava dalla vista degli altri fu un angolo di muro, la corsa per la collina fu una bella, radiosa, ansiosa corsa per la collina.
La prima frase che disse all'altro, camminando ormai soltanto in fretta per un viottolo che portava a monte, fu: - Adesso posso dirtelo, io sono un partigiano. - Anch'io, - rispose l'altro. - Di che banda sei? Che nome hai? - Si dissero i nomi di battaglia, le bande in cui erano stati, i compagni conosciuti, le azioni cui avevano preso parte.
Egli andava adesso assieme all'altro per la collina, col cappotto militare sbottonato; contento, contento anche se potevano riprenderlo e fucilarlo da un momento all'altro: e la caserma grigia non esisteva più per lui, sommersa nel fondo della coscienza. Le erbe e il sole e loro che camminavano coi cappotti sbottonati in mezzo alle erbe e al sole, erano un simbolo nuovo, arioso ed enorme, erano quello che spesso, senza capire, gli uomini dicono libertà.
Alle nove e un quarto arrivò su Colla Bracca assieme alla luna, ai venti era già al bivio dei due alberi, per la mezza sarebbe stato alla fontana. In vista di San Faustino prima delle dieci, dieci e mezzo a Perallo, Creppo a mezzanotte, per l'una poteva essere da Vendetta in Castagna: dieci ore di strada a passo normale, sei ore a dir tanto per lui, Binda, la staffetta del primo battaglione, la più veloce staffetta della brigata.
Andava forte, Binda, a corpo morto giù per le scorciatoie, senza sbagliarsi mai alle svolte tutte uguali, riconoscendo nel buio i sassi, i cespugli, prendendo di petto le salite, di petto fermo che non cambiava il ritmo del respiro, la lena delle gambe spinte come da stantuffi. - Forza Binda! - gli dicevano i compagni appena lo vedevano da lontano arrampicarsi verso il loro accampamento. Cercavano di leggergli in volto se le notizie, gli ordini che portava erano buoni o cattivi; ma la faccia di Binda era chiusa come un pugno, una stretta faccia montanara dal labbro peloso, su un corpo basso e ossuto più da un ragazzo che da giovanotto, con muscoli come sassi.
Era un duro e solitario compito il suo, esser svegliato a tutte le ore, mandato fino da Serpe, da Pelle, dover marciare la notte nel buio delle vallate, con la compagnia di quell'arma francese appesa alle spalle, leggera come un fuciletto di legno, arrivare a un distaccamento e dover ripartire per un altro o tornare con la risposta, svegliare il cuoco e frugare nelle marmitte fredde, poi ripartire con una gavettata di castagne ancora in gola. Ma era anche il suo compito naturale, di lui che non si perdeva nei boschi, che conosceva tutti i sentieri, percorsi fin da bambino conducendo le capre, andando per legna o per fieno, di lui che non s'azzoppava e non si spellava i piedi su e giù per quei sassi come tanti partigiani saliti dalla città e dalla marina.
Un castagno dal tronco cavo, un lichene celeste su una pietra, lo spiazzo nudo d'una carbonaia, quinte di uno scenario spaesato e uniforme, s'animavano in lui radicate ai ricordi più remoti: una capra scappata, una faina stanata, la sottana alzata a una ragazza. E a questi s'aggiungevano i ricordi nuovi, della guerra fatta nei suoi posti, continuazione della sua storia: gioco, lavoro, caccia diventati guerra: odore di spari al ponte di Loreto, salvataggi giù per i cespugli del pendio, prati minati gravidi di morte.
La guerra si rigirava allo stretto in quelle valli, come un cane che vuol mordersi la coda; i partigiani gomito a gomito coi bersaglieri e i militi; se gli uni salivano a monte gli altri scendevano a valle, poi gli uni a valle gli altri a monte, sempre con grandi giri sulle creste per non finire gli uni sotto gli altri, e farsi sparare addosso, sempre con qualcuno che rimaneva morto, a monte o a valle. Il paese di Binda era giù per le campagne, San Faustino, tre gruppi di case uno qua uno là nella vallata, la finestra di Regina col lenzuolo steso nei giorni di rastrellamento. Il paese di Binda era una pausa breve tra lo scendere e il salire, una sorsata di latte, la maglia pulita preparata da sua madre; poi lesto a scappare per non vederli arrivare da ogni parte tutt'a un tratto, ché a San Faustino partigiani ne erano morti abbastanza.
L'inverno era un gioco di rincorrersi e nascondersi; i bersaglieri a Baiardo, i militi ai Molini, i tedeschi a Briga: in mezzo i partigiani stretti in due gomiti di valle, che scansavano i rastrellamenti spostandosi dall'uno all'altro nella notte, attraverso posti contesi. Proprio in quella notte una colonna tedesca era in marcia da Briga, forse già al Carmo, i militi si preparavano a salire dai Molini di rinforzo; i distaccamenti dormivano sepolti nella paglia dei casoni, attorno alle braci semispente; Binda marciava nel buio dei boschi con la loro salvezza affidata alle sue gambe, in quell'ordine: «Sgombrare subito la valle, per l'alba tutto il battaglione con le pesanti in cresta al Pellegrino».
L'ansia era un leggero battere d'ali di pipistrello nei polmoni di Binda, una voglia d'afferrare con la mano il costone lontano due chilometri, nel buio senza prospettiva, d'issarsi fin lassù, soffiare l'ordine come un alito di vento nell'erba e sentirlo scorrere via come attraverso i baffi su per le narici, fino a Vendetta, a Serpe, a Guerriglia. Poi scavarsi un vano tra le foglie di castagno, e affondarci, lui e Regina, prima togliere i ricci che avrebbero punto Regina, ma più si scava nelle foglie più ricci si trovano, impossibile far posto a Regina là in mezzo, a Regina dalla pelle liscia e sottile.
Le foglie secche e i ricci frusciavano sotto i piedi di Binda, quasi con uno sciacquio; i ghiri dai tondi occhi lucenti correvano a rintanarsi in cima agli alberi. - Forza, Binda! - gli aveva detto Fegato, il comandante, dandogli la consegna. Il sonno s'alzava dal cuore della notte a vellutargli l'interno delle palpebre; Binda avrebbe voluto perdere il sentiero, smarrirsi in un mare di foglie secche, nuotare fino ad esserne sommerso. - Forza, Binda!
Binda camminava ora sulla costiera alta di Tumena, ancora ghiacciata, su una stretta pista marcata di passi. Tumena era la vallata più ampia di quelle regioni, dalle rive distanti e altissime; la riva opposta sfumava nel buio, quella su cui marciava si perdeva nel pendio brullo, tra i cespugli da cui, a giorno, s'alzavano frullanti stormi di pernici. Parve a Binda di vedere una luce lontana, in Tumena bassa, che camminava più avanti di lui. Faceva ogni tanto uno zig-zag come prendesse una curva, spariva, riappariva di lì a poco in una direzione inaspettata. Chi era mai a quell'ora? A volte pareva a Binda che il lume fosse molto più distante, sull'altra riva, a volte fermo, a volte rimasto dietro a lui. Tanti lumi diversi, potevano essere, in marcia per tutti i sentieri di Tumena bassa, fors'anche dietro e avanti a lui, in Tumena alta, che s'accendevano e si spegnevano. I tedeschi!
Una bestia correva sulle orme di Binda, svegliata dal fondo di regioni bambine, lo inseguiva, presto lo avrebbe raggiunto: la paura. Quei lumi erano di tedeschi che perlustravano Tumena, cespuglio per cespuglio, a battaglioni. Una cosa impossibile: Binda lo sapeva, pure sentiva che sarebbe stato piacevole crederci, abbandonarsi alla lusinga di quella bestia bambina che lo inseguiva dappresso. In gola a Binda il tempo batteva sul suo tam-tam inghiottito. Era ormai tardi per arrivare prima dei tedeschi, per salvare i compagni. Già Binda vedeva il casone di Vendetta, in Castagna, bruciato, i corpi dei compagni sanguinanti, le teste di alcuni appese ai rami dei larici per i lunghi capelli. - Forza Binda!
Si stupì del luogo dove si trovava, gli sembrava di aver percorsa poca strada in molto tempo: forse aveva rallentato senz'avvedersene, forse s'era fermato. Non cambiò andatura, però: sapeva bene che il suo passo era sempre uguale e sicuro, che non bisognava fidarsi di quella bestia che veniva a fargli visita nelle missioni notturne, a bagnargli le tempie con le sue dita invisibili, intinte di saliva. Era un ragazzo a posto, Binda, coi nervi saldi e il sangue freddo in ogni evenienza; serbava intatta tutta la sua risolutezza d'agire, pur portando quella bestia ormai su di sé, come una scimmia aggrappata al collo.
Il prato di Colla Bracca nella luna sembrava molle. «Le mine!» pensò Binda. Non c'erano mine lassù, Binda lo sapeva: le mine erano distanti, sull'altro versante di Ceppo. Ma Binda ora pensava che le mine si muovessero sottoterra, camminassero da una parte all'altra delle montagne, inseguissero i suoi passi, come enormi ragni sotterranei. La terra sopra le mine produce strani funghi, guai a calpestarli: tutto scoppierebbe all'istante, ma i secondi diventerebbero lunghi come secoli, e il mondo sembrerebbe fermarsi come incantato.
Binda scendeva per il bosco, adesso. Il sonno e il buio mettevano maschere tetre ai tronchi ed ai cespugli. C'erano tedeschi tutt'intorno, era vero. Certo l'avevano visto mentre passava il prato di Colla Bracca sotto la luna, lo stavano inseguendo, lo attendevano al varco. Un gufo gridò poco distante: era il fischio convenuto dei tedeschi che serravano intorno a lui, ecco che un altro fischio gli rispondeva, era circondato! Una bestia si mosse in fondo a un cespo d'eriche: forse una lepre, forse una volpe, forse un tedesco coricato tra gli arbusti che lo prendeva di mira. C'era un tedesco per ogni cespuglio, un tedesco appollaiato in cima a ogni albero, coi ghiri. Le pietraie pullulavano d'elmi, fucili s'alzavano tra i rami, le radici degli alberi finivano in piedi umani. Binda marciava lungo una doppia siepe di tedeschi in agguato, che lo guardavano con occhi luccicanti come foglie: più camminava più s'approfondiva in mezzo a loro. Al terzo, al quarto, al sesto urlo di gufo tutti i tedeschi sarebbero balzati in piedi attorno a lui, le armi puntate, il petto traversato da nastri di mitraglia.
Uno in mezzo a loro, detto Gund, con un terribile sorriso bianco sotto l'elmo, avrebbe proteso le mani enormi sopra di lui, per afferrarlo. Binda temeva di voltarsi per non vederselo a un tratto alto sulle sue spalle, a mitra spianato, a mani aperte nell'aria. O forse gli sarebbe venuto incontro sul sentiero, indicandolo con un dito, o l'avrebbe sentito a un rotolar di pietre che si metteva al suo fianco, a camminare assieme a lui in silenzio.
A un tratto gli sembrò d'aver sbagliato strada: eppure riconosceva il sentiero, le pietre, gli alberi, il muschio. Ma erano pietre, alberi, muschio d'un altro luogo, distante, di mille altri luoghi diversi e distanti. Dopo quel gradino di sassi doveva esserci un dirupo, non un roveto; superato quel costone un cespo di ginestra, non d'agrifoglio; il rigagnolo doveva essere asciutto, non con acqua e rane. Erano rane d'un'altra vallata, rane vicine ai tedeschi, al giro della strada, era un inganno preparato dai tedeschi appostati, che l'avrebbe messo ad un tratto nelle loro mani, di fronte al grande tedesco che è in fondo a tutti noi, chiamato Gund, carico d'elmi, bandoliere, bocche d'armi puntate, che apre sopra a tutti noi le mani enormi e non riesce ad afferrarci mai.
Per cacciare Gund bisogna pensare a Regina, a scavarci una nicchia con Regina, nella neve, ma la neve è dura e ghiacciata, non si può farci sdraiare Regina, vestita d'una sottana sottile come pelle; neanche sotto i pini si può, lo strato degli aghi non ha fine, il terriccio raggiunto è un formicaio, e Gund è già sopra di noi, abbassa la mano sulla nostra testa, sulla nostra gola, sul nostro petto, l'abbassa ancora: urliamo. Bisogna pensare a Regina, la ragazza che è in tutti noi e per cui tutti noi vorremmo scavare una nicchia in fondo al bosco.
Ma l'inseguimento era alla fine, tra Binda e Gund: l'accampamento di Vendetta distava ormai solo quindici, venti minuti. Binda correva, col pensiero: ma i suoi passi continuavano a posarsi regolari, per non sfiatarsi. Raggiunti i compagni la paura sarebbe scomparsa, cancellata fin dal fondo della memoria, data per impossibile. C'era da pensare a svegliare Vendetta e Sciabola, il commissario, spiegar loro l'ordine di Fegato, poi ripartire per Gerbonte, da Serpe.
Ma si sarebbe raggiunto mai, il casone? Non era legato a un filo che lo trascinava lontano da lui, man mano che s'avvicinava? E arrivando non avrebbe sentito ausch-ausch i tedeschi tutt'intorno al fuoco che mangiavano le castagne rimaste? Binda già s'immaginava d'arrivare al casone mezz'incendiato e deserto. Entrava: vuoto. Ma in un angolo, grandissimo, seduto alla turca, con l'elmo che toccava il tetto, c'era Gund, gli occhi tondi e lucenti come quelli dei ghiri, il sorriso bianco di denti tra le labbra tumide. Gund gli faceva cenno: «Siediti». E Binda si sarebbe seduto.
Ecco, a cento metri da lui una luce: erano loro! Chi loro? Ebbe voglia di tornare indietro, di fuggire, come tutto il pericolo fosse laggiù nel casolare di pian Castagna. Ma continuava a camminare spedito, la faccia dura e chiusa come un pugno. Ora il fuoco sembrava avvicinarsi troppo in fretta: muoveva incontro a lui? Ora allontanarsi: fuggiva? Ma era fermo, era il fuoco dell'accampamento non ancora spento, Binda lo sapeva.
- Chi va là! - Non trasalì. - Binda, - disse. - Sentinella. Sono Civetta. Novità, Binda? - Dorme, Vendetta? - Ora era già nel casone col fiato dei compagni addormentati intorno. Compagni, naturalmente, e chi mai avrebbe potuto esserci, d'altri?
- Tedeschi giù da Briga, fascisti su dai Molini. Sgombrare. Per l'alba tutti in cresta al Pellegrino con le pesanti -. Vendetta appena sveglio annaspava un poco con le palpebre. - Sacramento, - disse. Poi s'alzò, batté le mani: - Sveglia voialtri, c'è da andare a picchiarsi.
Binda ora scucchiaiava in un gavettino di castagne bollite, sputacchiando le pellicole rimaste appiccicate. Gli uomini si dividevano i turni per portare le munizioni, il treppiede della pesante. S'incamminò. - Vado da Serpe, in Gerbonte, - disse. - Forza, Binda, - gli fecero i compagni.
Lui già svoltava dietro lo sperone di roccia, aveva perso di vista il casone, si lasciava alle spalle il dirupo nero di cespugli. Gund s'alzò dai cespugli, si rimise in marcia dietro di lui, coi suoi passi di gigante.
Nel '44 il fronte si fermò lì come nel '40, solo che questa volta la guerra non finiva, e non c'era verso che si spostasse. La gente non voleva fare come nel '40, di caricare quattro stracci e le galline su un carretto, e partire col mulo davanti e la capra dietro. Nel '40 quand'erano tornati avevano trovato tutti i cassetti rovesciati in terra e fèci umane nelle casseruole: perché si sa che gli italiani da soldati quando possono fare dei danni non guardano né amici né nemici. Così rimasero, con le cannonate francesi che arrivavano giorno e notte a piantarsi nelle case e quelle tedesche che fischiavano sopra la testa.
- Si decideranno bene ad avanzare, un giorno o l'altro, - dicevano, e dovevano continuare a ripeterselo da settembre ad aprile. - Si faranno un po' sotto, 'sti cristi di alleati.
La Val Bévera era piena di gente, contadini e anche sfollati da Ventimiglia, e s'era senza mangiare; scorte di viveri non ce n'era e la farina bisognava andarla a prendere in città. Per andare in città c'era la strada battuta dalle cannonate notte e giorno.
Ormai si viveva più nei buchi che nelle case e un giorno gli uomini del paese si riunirono in una tana grande per decidere.
- Qui, - disse quello del comitato, - bisogna fare a turno chi deve scendere a Ventimiglia a pigliare il pane.
- Bravo, - disse un altro, - così uno a uno restiamo fatti a pezzi sulla strada.
- O se no uno a uno ci pigliano i tedeschi e alé in Germania, - disse un terzo.
E un altro interloquì: - Le bestie. Chi ci mette la bestia? Chi ce l'ha ancora non la rischia. É facile che se uno va non torni né lui né la bestia né il pane.
Le bestie erano già state requisite e chi l'aveva salvata la teneva nascosta.
- Insomma, - disse quello del comitato. - Qui se non si ha pane come facciamo a vivere? C'è uno che si sente di andare a Ventimiglia con un mulo? Io in giù son ricercato, se no andrei.
Si guardò intorno: gli uomini erano seduti in terra nella tana, con gli occhi senz'espressione, e scavavano con le dita dentro il tufo.
Allora il vecchio Bisma che stava in fondo e guardava a bocca aperta senza capire niente, s'alzò e uscì dalla tana. Gli altri credettero che volesse andare a orinare perché era vecchio e ogni tanto ne aveva bisogno.
- Attenzione, Bisma, - gli gridarono dietro, - piscia al coperto.
Ma lui non si voltò.
- Per lui è come non bombardassero, - disse uno. - É sordo e non se ne accorge.
Bisma aveva più di ottant'anni e una schiena che sembrava piegata sempre sotto un carico di fascine: tutte le fascine camallate in vita sua dal bosco alla stalla. Lo chiamavano Bisma per via dei baffi che si diceva avessero somigliato a quelli di Bismarck, ai suoi tempi; adesso erano un paio di baffi bianchi, bisunti e spioventi, e sembrava stessero per cascare in terra da un momento all'altro, come tutte le parti del suo corpo. Ma niente cascava, invece, e Bisma strascicava avanti dondolando la testa e con lo sguardo senz'espressione e un po' diffidente dei sordi.
Ricomparve all'apertura della tana.
- Iiih! - fece.
Gli altri allora videro che si portava dietro il mulo, e che ci aveva messo il basto. Il mulo di Bisma sembrava più vecchio del padrone, col collo piatto come una tavola chinato fino a terra, e una cautela nel muoversi come se le ossa sporgenti stessero per rompergli la pelle e sbucargli fuori dalle piaghe nere di mosche.
- Dove porti il mulo, Bisma? - gli chiesero.
Lui dondolava la testa, a bocca aperta. Non sentiva.
- I sacchi, - disse. - Datemeli.
- Ehi, - fecero. - Dove pretendete di arrivare, tra te e quel brocco?
- Quanti chili? - chiedeva lui. - Eh? Quanti chili?
Gli diedero i sacchi, gli spiegarono con le dita il numero dei chili, e partì. A ogni fischio di granata gli uomini dalla soglia della tana guardavano la strada e quella sbilenca figura che s'allontanava: il mulo e l'uomo a cavalcioni del basto che sembrava sempre pericolassero e stessero per cadere tutt'e due. Le cannonate picchiavano davanti, sulla strada, alzando un polverone spesso, rovinavano il cammino davanti ai cauti passi del mulo, oppure dietro le sue spalle: e Bisma nemmeno si voltava. Gli uomini tenevano il fiato a ogni colpo di partenza, a ogni sibilo. - Questo lo piglia, - dicevano. A un colpo sparì del tutto, avvolto nella polvere. Gli uomini stettero zitti. Ora, diradata la polvere avrebbero visto la strada nuda, e nemmeno i suoi resti. Invece riapparvero come fantasmi, l'uomo e il mulo, e continuarono a camminare, lemme lemme. Poi ci fu l'ultima svolta e non si poteva più seguirli. - Non ce la farà, - dissero gli uomini, e voltarono le spalle.
Ma Bisma continuava a cavalcare sulla mulattiera acciottolata. Il vecchio mulo metteva avanti gli incerti zoccoli sul cammino accidentato dalle selci e dalle frane recenti; la pelle gli si tendeva per il bruciore delle piaghe sotto il basto. Gli scoppi non lo imbizzarrivano: aveva tanto penato in vita sua che nulla poteva fargli più impressione. Marciava a muso chino, e il suo sguardo, limitato dai paraocchi neri, faceva osservazioni bellissime: lumache dal guscio rotto dagli spari che perdevano una bava iridata sulle pietre, formicai sventrati con fughe bianche e nere di formiche e uova, erbe strappate che alzavano strane radici barbute come d'alberi.
E l'uomo a cavallo del basto cercava di tenersi ritto sulle natiche magre, mentre tutte le sue povere ossa sussultavano alle asperità della strada. Ma lui era cresciuto assieme ai suoi muli e le sue idee erano poche e rassegnate come le loro: il pane della sua vita s'era sempre trovato al di là d'un cammino molto faticoso, il pane per sé e anche il pane per gli altri, oggi il pane per tutta Bévera. Il mondo, questo mondo silenzioso che lo circondava, ora sembrava tentasse di parlare anche a lui, con confusi rimbombi che giungevano fino ai suoi timpani addormentati, con strani sconvolgimenti della terra. Bisma andando vedeva ripe franare, nuvole alzarsi dai campi, e voli di sassi, lampi rossi apparire e sparire sulle colline; il mondo voleva cambiare la sua vecchia faccia e mostrare il rovescio delle cose, delle piante, della terra. E il silenzio, il terribile silenzio della sua vecchiaia, s'andava increspando di quei rimbombi lontani.
La strada davanti ai piedi del mulo sprizzò enormi scintille, le narici e la gola si riempirono di terra, una grandinata di pietrisco investì uomo e mulo di sbieco, mentre i rami di un grande olivo ruotarono per aria sopra la sua testa: pure, se non cadeva il mulo lui non sarebbe caduto. E il mulo resistette, gli zoccoli radicati nella terra crepata, i ginocchi lì lì per schiantarsi. Poi mosse piano, ancora nel polverone, e andò avanti.
La sera, su a Bévera qualcuno gridò: - Guardate! É Bisma che torna! Ce l'ha fatta!
Allora gli uomini e le donne e i bambini uscirono dalle case e dalle tane e videro all'ultima svolta il mulo che veniva avanti ancora più sbilenco sotto i sacchi, e Bisma dietro, a piedi, appeso alla coda che non si capiva se si facesse tirare o se spingesse.
Gran festa fece la gente della vallata a Bisma che tornava con il pane. Fecero la distribuzione nella grande tana, e gli abitanti passavano a uno a uno e quello del comitato dava un pane a testa. Vicino c'era Bisma che biascicava il suo sotto i pochi denti e guardava le facce di tutti.
Così Bisma andò a Ventimiglia anche l'indomani. Non c'era nessun'altra bestia che non potesse far gola ai tedeschi. E ogni giorno continuò a andar giù e a portare il pane, e ogni giorno la scampava, passava attraverso le bombe incolume: dicevano avesse fatto un patto con il diavolo.
Poi i tedeschi abbandonarono la riva destra del Bévera, fecero saltare due ponti e un pezzo di strada, misero le mine. Tempo quarantott'ore gli abitanti dovevano sgombrare il paese e la zona. Il paese lo sgombrarono ma la zona no: si rintanarono nei buchi. Ma erano isolati, presi in mezzo tra due fronti e senza via di approvvigionamento. Era la fame.
Quando si seppe che il paese era evacuato, salirono i brigata-nera. Cantavano. Uno aveva un pentolino di colore e un pennello. Scrisse sui muri: Non Passeranno, Noi Terremo Duro, L'Asse Non Cede. Intanto giravano per le stradette, mitra in spalla, e davano occhiate alle case. Cominciarono a assaggiare qualche porta a spallate. In quella apparve Bisma sul mulo. Apparve in cima a una strada in discesa, e avanzava tra le due file di case.
- Ehi, dove andate? - chiesero i brigata-nera.
Quello pareva che nemmeno li vedesse, il mulo continuava a mettere avanti passi sbilenchi.
- Ehi, diciamo a voi! - Quel vecchio macilento ed impassibile, arrampicato su quello scheletro di mulo, sembrava uno spirito uscito dalle pietre di quel paese disabitato e mezzo diroccato.
- É un sordo, - dissero.
Il vecchio s'era messo a guardarli, uno per uno. I brigata-nera scantonarono in un vicolo. Arrivarono in una piazzetta; si sentiva solo il correre dell'acqua alla fontana, e lontano il cannone.
- In quella casa mi sa che ci sia roba, - disse un brigata-nera, indicandola. Era un ragazzino con una macchia rossa sotto l'occhio. L'eco tra le case della piazza vuota gli ripeté le parole a una a una. Il ragazzino ebbe un gesto nervoso. Quello col pennello scrisse su un muro diroccato: Onore E Combattimento. Una finestra lasciata aperta sbatteva e faceva più rumore del cannone.
- Aspetta a me, - disse quello con la macchia rossa a due che spingevano una porta. Poggiò la bocca del mitra contro la serratura e sparò a raffica. La serratura tutta bruciacchiata cedette. Allora ricomparve Bisma, dalla direzione opposta a quella in cui l'avevano lasciato. Sembrava passeggiare su e giù per il paese, in cima a quel rudere di mulo.
- Aspettiamo che sia passato, - disse un brigata-nera, e si misero davanti alla porta con aria indifferente.
Roma O Morte, scrisse quello col pennello.
Il mulo traversava la piazza piano; ogni passo sembrava fosse l'ultimo. L'uomo addosso pareva si stesse per addormentare.
- Andatevene, - gridò il ragazzino con la macchia. - Il paese è evacuato.
Bisma non si voltò; sembrava intento a pilotare il mulo attraverso quella piazza vuota.
- Se v'incontriamo ancora, - insisté quello, - spariamo.
Vinceremo, scrisse quello col pennello.
Di Bisma si vedeva solo la schiena decrepita, sopra quelle gambe nere di mulo quasi ferme.
- Andiamo là, - decisero i brigata-nera, e pigliarono giù da un archivolto.
- Alé. Non perdiamo tempo. Cominciamo da questa casa.
Aprirono e quello con la macchia entrò per primo. La casa era vuota e piena d'echi. Girarono per le stanze e dopo uscirono.
- Ho voglia proprio di dar fuoco al paese, guarda un po', - disse il macchiato.
Noi Tireremo Diritto, scrisse l'altro.
Bisma riapparve in fondo alla stradicciola. Avanzava verso di loro.
- Non farlo, - dissero i brigata-nera al macchiato che mirava.
Duce, scrisse quell'altro.
Ma il macchiato aveva schiacciato a raffica. Furono falciati insieme, uomo e mulo, ma rimasero ancora in piedi. Come se il mulo fosse caduto sulle quattro zampe, e fosse tutto d'un pezzo, con quelle sue gambe nere e sbilenche. I brigata-nera erano lì che guardavano; il macchiato aveva abbandonato il mitra per la cinghia e batteva i denti. Poi s'inchinarono insieme, uomo e mulo; sembrava stessero per fare un altro passo, invece diroccarono giù uno sopra l'altro.
Quelli del paese vennero a notte a portarli via. Bisma lo seppellirono; il mulo lo mangiarono cotto. Era carne dura ma loro avevano fame.
Il bosco era rado, quasi distrutto dagli incendi, grigio nei tronchi bruciati, rossiccio negli aghi secchi dei pini. L'uomo armato e l'uomo senz'armi se ne venivano a zig-zag tra gli alberi, scendendo.
- Al comando, - diceva quello armato. - Al comando, andiamo. Mezz'ora di cammino a dir tanto.
- E poi?
- Poi cosa?
- Dico se poi mi lasciano andare, - fece l'uomo disarmato; a ogni risposta si metteva in ascolto, sillaba per sillaba, come cercasse una nota falsa.
- Certo che vi lasciano andare, - disse l'armato. - Io do il documento del battaglione, loro segnano sul registro e allora potete tornare a casa.
Il disarmato scuoteva il capo, faceva il pessimista.
- Eh, son cose lunghe, capisco... - diceva, forse solo per sentirsi ripetere:
- Vi lasceranno subito, vi dico.
- Facevo conto, - aggiunse, - facevo conto d'essere a casa per stasera. Pazienza.
- Io dico che ci arriverete, - rispose l'armato. - Il tempo che loro facciano il verbale, poi vi lasciano. Bisogna bene che cancellino il vostro nome dal registro delle spie.
- Avete il registro delle spie?
- Sicuro che l'abbiamo. Tutti quelli che fanno la spia, noi lo sappiamo. E uno per uno li prendiamo.
- E c'è il mio nome segnato sopra?
- Già. C'era anche il vostro nome. Ora bisogna bene che lo cancellino, se no rischiate d'esser preso di nuovo.
- Allora bisogna proprio che vada io là, che spieghi a loro tutta la storia.
- Ecco che stiamo andando. Bisogna bene che vedano, che controllino.
- Ma ormai, - disse l'uomo senz'armi, - ormai lo sapete che sono dei vostri, che non ho mai fatto la spia.
- Appunto. Ormai lo sappiamo. Ormai siete tranquillo.
Il disarmato annuiva e si guardava intorno. Erano in una grande radura, con pini e larici magri, uccisi dagli incendi, ingombra di rami caduti. Avevano abbandonato, ritrovato e riperso il sentiero, andavano come a caso per i pini radi, traversando il bosco. Il disarmato non riconosceva i luoghi, la sera saliva con lame sottili di nebbia, in basso il bosco s'infoltiva dentro il buio.
L'allontanarsi dal sentiero lo faceva inquieto; provò - visto che l'altro sembrava camminasse a caso - provò a piegare verso destra, dove forse il sentiero proseguiva: l'altro piegò anche lui a destra, come a caso. Se lui si rimetteva a seguirlo, riprendeva a sinistra o a destra, secondo com'era più agevole il cammino.
Si decise a domandare: - Ma dov'è il comando?
- Ci andiamo, - rispose l'armato. - Ora lo vedrete.
- Ma in che luogo, in che regione, pressappoco?
- Come si fa a dire? - rispose. - Il comando non si dice che è in un luogo, in una regione. Il comando è dov'è il comando. Voi capite.
Capiva; era un uomo che capiva le cose, il disarmato. Pure chiese: - Ma non c'è una strada, per andarci?
L'altro rispose: - Una strada. Voi capite. Una strada va sempre in qualche luogo. Al comando non si va per le strade. Voi capite.
Il disarmato capiva, era un uomo che capiva le cose, un uomo astuto.
Chiese: - Voi ci andate spesso al comando?
- Spesso, - disse l'armato. - Spesso, ci vado.
Aveva una faccia triste, senza sguardo. Conosceva poco i luoghi: sembrava, ogni tanto, che si fosse smarrito, e pure continuava a camminare come non gli importasse.
- É perché siete di turno per la corvé, quest'oggi, che v'hanno mandato a accompagnarmi? - chiese il disarmato, studiandolo.
- É un lavoro che spetta a me, l'accompagnarvi, - rispose. - Accompagno io la gente al comando.
- La staffetta, siete?
- Ecco, - disse l'armato, - la staffetta.
«Una strana staffetta, - pensava il disarmato, - che non conosce i luoghi. Ma, - pensava, - oggi non vuole passare per le strade perché io non capisca dov'è il comando, perché non si fidano di me». Brutto segno, che non si fidassero ancora di lui; il disarmato s'ostinava a pensare questo. Ma c'era, in questo brutto segno, una sicurezza, che davvero lo stessero conducendo al comando e volessero lasciarlo libero, e al di fuori di questo brutto segno un segno più brutto ancora, c'era il bosco che si faceva più fitto e da cui non s'accennava a uscire, c'era il silenzio, la tristezza di quell'uomo armato.
- Il segretario l'avete pure accompagnato al comando? E i fratelli del mulino? E la maestra? - Fece questa domanda d'un fiato, senza rifletterci, perché era la domanda decisiva, che significava tutto: il segretario comunale, i fratelli, la maestra, erano tutta gente portata via, mai più tornata, di cui mai più nulla s'era saputo.
- Il segretario era un fascista, - disse l'armato, - i fratelli erano nella milizia, la maestra era nelle ausiliarie.
- Dicevo così per sapere, visto che non sono tornati più indietro.
- Dico, - insisté l'armato. - Loro erano quello che erano. Voi siete quello che siete. Non c'è da far confronti.
- Certo, - fece l'altro, - non c'è da far confronti. Solo chiedevo cosa ne è stato, così, per curiosità.
Si sentiva sicuro di sé, il disarmato, enormemente sicuro di sé. Era l'uomo più astuto del paese, era difficile fargliela. Gli altri, segretario e maestra, non erano più tornati: lui sarebbe tornato. «Io grande kamarad, - avrebbe detto al maresciallo. Partisan niente kaputt me. Io kaputt tutti partisan». Forse il maresciallo si sarebbe messo a ridere.
Ma il bosco bruciato era interminabile e i pensieri dell'uomo erano fasciati di sconosciuto e di oscuro, come zone di radura in mezzo a un bosco.
- Io non so bene del segretario, di tutti quegli altri. Faccio la staffetta io.
- Ma al comando lo sapranno, - insisteva il disarmato.
- Ecco. Lo domanderete al comando. Là lo sanno.
Si faceva sera. Bisognava camminare guardingo, in mezzo alla brughiera, badando come metteva i passi, per non scivolare su sassi nascosti sotto i cespugli fitti. E badare come si mettevano i pensieri, uno dietro l'altro, nel fitto dell'inquietudine, per non trovarsi a un tratto sepolto di paura.
Certo, se lo avessero creduto una spia non l'avrebbero lasciato così nel bosco, solo con quell'uomo che sembrava non gli badasse nemmeno; avrebbe potuto scappargli tutte le volte che avesse voluto. Se lui tentava di fuggire, cosa avrebbe fatto, l'altro?
Il disarmato cominciò, scendendo in mezzo agli alberi, a prendere un po' di distanza, a piegare a destra quando quello piegava a sinistra. Ma l'armato continuava a camminare quasi senza badargli, e scendevano così per il bosco rado, distanti ormai l'uno dall'altro. Talora anche si perdevano di vista, nascosti da tronchi, da cespi di arbusti, ma a tratti il disarmato tornava a vedere l'altro sopra di lui che sembrava non gli badasse e pure gli teneva sempre dietro, a distanza.
«Se mi lasciano libero un momento, è la volta che non mi pigliano più», aveva pensato fin allora il disarmato. Ma ora si sorprese a pensare: «Se faccio tanto da riuscire a scappargli, è la volta...» E già vedeva nella sua mente i tedeschi, tedeschi a colonne, tedeschi su camion e autoblinde, visione di morte per gli altri, di sicurezza per lui, uomo astuto, uomo a cui nessuno poteva farla.
Erano usciti dalle radure e dalle brughiere, erano entrati nel bosco fitto e verde, risparmiato dagli incendi: il suolo era coperto d'aghi secchi di pino. L'uomo armato era rimasto indietro, forse aveva preso un altro cammino. Il disarmato allora, cauto, con la lingua tra i denti, affrettò il passo, si spinse più nel folto, cacciandosi giù per i dirupi, tra i pini. Stava scappando: se ne accorse. Allora ebbe paura; ma comprese che ormai s'era allontanato troppo, che l'altro s'era certo accorto del suo voler scappare e certo lo stava inseguendo: non c'era che continuare a correre, guai se ricascava a tiro dell'altro, adesso che aveva tentato di fuggire.
Si voltò a un calpestio sopra di sé: a pochi metri c'era l'uomo armato che se ne veniva col suo passo calmo, indifferente. Aveva l'arma in mano. Disse - Di qua ci dev'essere una scorciatoia, - e gli fece cenno di precederlo.
Allora tutto tornò come prima: un mondo ambiguo, tutto in male o tutto in bene: il bosco che invece di finire, s'infittiva, quell'uomo che quasi lo lasciava scappare senza dir niente.
Chiese: - Ma non finisce mai, questo bosco?
- Appena girata la collina ci siamo, - disse l'altro. - Coraggio, che stanotte siete a casa.
- Così, senz'altro mi lasceranno andare a casa? Dico, non vorranno tenermi lì come ostaggio, per esempio?
- Non siamo mica tedeschi, noi, da prendere degli ostaggi. Tutt'al più potranno prendervi gli scarponi, per ostaggio, ché siamo tutti mezzo scalzi.
L'uomo prese a brontolare come se gli scarponi fossero la cosa per cui temesse più che tutto, ma in fondo ci si rallegrava: ogni particolare della sua sorte, in bene o in male, serviva a ridargli un po' di sicurezza.
- Sentite, - disse l'armato, - visto che ci tenete tanto, facciamo così: mettetevi i miei, di scarponi, fin tanto che siamo al comando, ché i miei sono tutti rotti e non ve li pigliano. Io mi metto i vostri e quando vi accompagno indietro ve li rendo.
Ora anche un bambino avrebbe capito che era tutta una storia. L'uomo armato voleva i suoi scarponi, ebbene, il disarmato gli avrebbe dato tutto quel che voleva, era un uomo che capiva, lui, era contento di cavarsela così a buon mercato. «Io grande kamarad, - avrebbe detto al maresciallo. - Io dato loro scarpe e loro lasciato me andare». Il maresciallo forse gli avrebbe fatto avere un paio di stivaletti come i soldati tedeschi.
- Allora voi non tenete nessuno: ostaggio, prigioniero? Nemmeno il segretario comunale e gli altri?
- Il segretario aveva fatto prendere tre nostri compagni; i fratelli facevano i rastrellamenti con la milizia; la maestra andava a letto con quelli della Decima.
L'uomo disarmato si fermò. Disse: - Non credete mica che sia una spia anch'io. Non mi avete portato mica qui per ammazzarmi, - e scoprì un po' i denti, come per sorridere.
- Se vi credessimo una spia, - disse l'armato, non starei tanto a far così -. Tolse la sicurezza all'arma. - E così -. La puntò alla spalla, fece l'atto di sparargli addosso.
«Ecco - pensava la spia, - non spara».
Ma l'altro non abbassava l'arma, schiacciava il grilletto, invece.
«A salve, a salve spara», fece in tempo a pensare la spia. E quando sentì i colpi sferrati addosso a lui come pugni di fuoco che non si fermavano più, riuscì ancora a pensare: «Crede d'avermi ucciso, invece vivo».
Cascò con la faccia al suolo e l'ultima cosa che vide fu un paio di piedi calzati coi suoi scarponi che lo scavalcavano.
Così rimase, cadavere nel fondo del bosco, con la bocca piena d'aghi di pino. Due ore dopo era già nero di formiche.
La corrente era una rete di increspature leggere e trasparenti, con in mezzo l'acqua che andava. Ogni tanto c'era come un battere d'ali d'argento a fior d'acqua: il lampeggiare del dorso di una trota che riaffondava subito a zig-zag.
- C'è pieno di trote, - disse uno degli uomini.
- Se buttiamo dentro una bomba vengono tutte a galla a pancia all'aria, - disse l'altro; si levò una bomba dalla cintura e cominciò a svitare il fondello.
Allora s'avanzò il ragazzo che li stava a guardare, un ragazzotto montanaro, con la faccia a mela. - Mi dài, - disse e prese il fucile a uno di quegli uomini. - Cosa vuole questo? - disse l'uomo e voleva togliergli il fucile. Ma il ragazzo puntava l'arma sull'acqua come cercando un bersaglio. "Se spari in acqua spaventi i pesci e nient'altro", voleva dire l'uomo ma non finì neanche. Era affiorata una trota, con un guizzo, e il ragazzo le aveva sparato una botta addosso, come l'aspettasse proprio lì. Ora la trota galleggiava con la pancia bianca. - Cribbio, - dissero gli uomini.
Il ragazzo ricaricò l'arma e la girò intorno. L'aria era tersa e tesa: si distinguevano gli aghi sui pini dell'altra riva e la rete d'acqua della corrente. Una increspatura saettò alla superficie: un'altra trota. Sparò: ora galleggiava morta. Gli uomini guardavano un po' la trota un po' lui. - Questo spara bene, - dissero.
Il ragazzo muoveva ancora la bocca del fucile in aria. Era strano, a pensarci, essere circondati così d'aria, separati da metri d'aria dalle altre cose. Se puntava il fucile invece, l'aria era una linea diritta ed invisibile, tesa dalla bocca del fucile alla cosa, al falchetto che si muoveva nel cielo con le ali che sembravano ferme. A schiacciare il grilletto l'aria restava come prima trasparente e vuota, ma lassù all'altro capo della linea il falchetto chiudeva le ali e cadeva come una pietra. Dall'otturatore aperto usciva un buon odore di polvere.
Si fece dare altre cartucce. Erano in tanti ormai a guardarlo, dietro di lui in riva al fiumicello. Le pigne in cima agli alberi dell'altra riva perché si vedevano e non si potevano toccare? Perché quella distanza vuota tra lui e le cose? Perché le pigne che erano una cosa con lui, nei suoi occhi, erano invece là, distanti? Però se puntava il fucile la distanza vuota si capiva che era un trucco; lui toccava il grilletto e nello stesso momento la pigna cascava, troncata al picciolo. Era un senso di vuoto come una carezza: quel vuoto della canna del fucile che continuava attraverso l'aria e si riempiva con lo sparo, fin laggiù alla pigna, allo scoiattolo, alla pietra bianca al fiore di papavero. - Questo non ne sbaglia una, - dicevano gli uomini e nessuno aveva il coraggio di ridere.
- Tu vieni con noi, - disse il capo.
- E voi mi date il fucile, - rispose il ragazzo.
- Ben. Si sa.
Andò con loro.
Partì con un tascapane pieno di mele e due forme di cacio. Il paese era una macchia d'ardesia, paglia e sterco vaccino in fondo alla valle. Andare via era bello perché a ogni svolta si vedevano cose nuove, alberi con pigne, uccelli che volavano dai rami, licheni sulle pietre, tutte cose nel raggio delle distanze finte, delle distanze che lo sparo riempiva inghiottendo l'aria in mezzo.
Non si poteva sparare però, glielo dissero: erano posti da passarci in silenzio e le cartucce servivano per la guerra. Ma a un certo punto un leprotto spaventato dai passi traversò il sentiero in mezzo al loro urlare e armeggiare. Stava già per scomparire nei cespugli quando lo fermò una botta del ragazzo. - Buon colpo, - disse anche il capo, - però qui non siamo a caccia. Vedessi anche un fagiano non devi più sparare.
Non era passata un'ora che nella fila si sentirono altri spari. - É il ragazzo di nuovo! - s'infuriò il capo e andò a raggiungerlo. Lui rideva, con la sua faccia bianca e rossa, a mela. - Pernici, - disse, mostrandole. Se n'era alzato un volo da una siepe.
- Pernici o grilli, te l'avevo detto. Dammi il fucile. E se mi fai imbestialire ancora torni al paese.
Il ragazzo fece un po' il broncio; a camminare disarmato non c'era gusto, ma finché era con loro poteva sperare di riavere il fucile.
La notte dormirono in una baita da pastori. Il ragazzo si svegliò appena il cielo schiariva, mentre gli altri dormivano. Prese il loro fucile più bello, riempì il tascapane di caricatori e uscì. C'era un'aria timida e tersa, da mattina presto. Poco discosto dal casolare c'era un gelso. Era l'ora in cui arrivavano le ghiandaie. Eccone una: sparò, corse a raccoglierla e la mise nel tascapane. Senza muoversi dal punto dove l'aveva raccolta cercò un altro bersaglio: un ghiro! Spaventato dallo sparo, correva a rintanarsi in cima ad un castagno. Morto era un grosso topo con la coda grigia che perdeva ciuffi di pelo a toccarla. Da sotto il castagno vide, in un prato più basso, un fungo, rosso coi punti bianchi, velenoso. Lo sbriciolò con una fucilata, poi andò a vedere se proprio l'aveva preso. Era un bel gioco andare così da un bersaglio all'altro: forse si poteva fare il giro del mondo. Vide una grossa lumaca su una pietra, mirò il guscio e raggiunto il luogo non vide che la pietra scheggiata, e un po' di bava iridata. Così s'era allontanato dalla baita, giù per prati sconosciuti.
Dalla pietra vide una lucertola su un muro, dal muro una pozzanghera e una rana, dalla pozzanghera un cartello sulla strada, bersaglio facile. Dal cartello si vedeva la strada che faceva zig-zag e sotto: sotto c'erano degli uomini in divisa che avanzavano ad armi spianate. All'apparire del ragazzo col fucile che sorrideva con quella faccia bianca e rossa, a mela, gridarono e gli puntarono le armi addosso. Ma il ragazzo aveva già visto dei bottoni d'oro sul petto di uno di quelli e fatto fuoco mirando a un bottone.
Sentì l'urlo dell'uomo e gli spari a raffiche o isolati che gli fischiavano sopra la testa: era già steso a terra dietro un mucchio di pietrame sul ciglio della strada, in angolo morto. Poteva anche muoversi, perché il mucchio era lungo, far capolino da una parte inaspettata, vedere i lampi alla bocca delle armi dei soldati, il grigio e il lustro delle loro divise, tirare a un gallone, a una mostrina. Poi a terra e lesto a strisciare da un'altra parte a far fuoco. Dopo un po' sentì raffiche alle sue spalle, ma che lo sopravanzavano e colpivano i soldati: erano i compagni che venivano di rinforzo coi mitragliatori. - Se il ragazzo non ci svegliava coi suoi spari, - dicevano.
Il ragazzo, coperto dal tiro dei compagni, poteva mirare meglio. Ad un tratto un proiettile gli sfiorò una guancia. Si voltò: un soldato aveva raggiunto la strada sopra di lui. Si buttò in una cunetta, al riparo, ma intanto aveva fatto fuoco e colpito non il soldato ma di striscio il fucile, alla cassa. Sentì che il soldato non riusciva a ricaricare il fucile, e lo buttava in terra. Allora il ragazzo sbucò e sparò sul soldato che se la dava a gambe: gli fece saltare una spallina.
L'inseguì. Il soldato ora spariva nel bosco ora riappariva a tiro. Gli bruciò il cocuzzolo dell'elmo, poi un passante della cintura. Intanto inseguendosi erano arrivati in una valletta sconosciuta, dove non si sentiva più il rumore della battaglia. A un certo punto il soldato non trovò più bosco davanti a sé, ma una radura, con intorno dirupi fitti di cespugli. Ma il ragazzo stava già per uscire dal bosco: in mezzo alla radura c'era una grossa pietra; il soldato fece appena in tempo a rimpiattarcisi dietro, rannicchiato con la testa tra i ginocchi.
Là per ora si sentiva al sicuro: aveva delle bombe a mano con sé e il ragazzo non poteva avvicinarglisi ma solo fargli la guardia a tiro di fucile, che non scappasse. Certo, se avesse potuto con un salto raggiungere i cespugli, sarebbe stato sicuro, scivolando per il pendio fitto. Ma c'era quel tratto nudo da traversare: fin quando sarebbe rimasto lì il ragazzo? E non avrebbe mai smesso di tenere l'arma puntata? Il soldato decise di fare una prova: mise l'elmo sulla punta della baionetta e gli fece far capolino fuori dalla pietra. Uno sparo, e l'elmo rotolò per terra, sforacchiato.
Il soldato non si perse d'animo; certo mirare lì intorno alla pietra era facile, ma se lui si muoveva rapidamente sarebbe stato impossibile prenderlo. In quella un uccello traversò il cielo veloce, forse un galletto di marzo. Uno sparo e cadde. Il soldato si asciugò il sudore dal collo. Passò un altro uccello, una tordella: cadde anche quello. Il soldato inghiottiva saliva. Doveva essere un posto di passo, quello: continuavano a volare uccelli, tutti diversi e quel ragazzo a sparare e farli cadere. Al soldato venne un'idea: «Se lui sta attento agli uccelli non sta attento a me. Appena tira io mi butto. Ma forse prima era meglio fare una prova. Raccattò l'elmo e lo tenne pronto in cima alla baionetta. Passarono due uccelli insieme, stavolta: beccaccini. Al soldato rincresceva sprecare un'occasione così bella per la prova, ma non si azzardava ancora. Il ragazzo tirò a un beccaccino, allora il soldato sporse l'elmo, sentì lo sparo e vide l'elmo saltare per aria. Ora il soldato sentiva un sapore di piombo in bocca; s'accorse appena che anche l'altro uccello cadeva a un nuovo sparo.
Pure non doveva fare gesti precipitosi: era sicuro dietro quel masso, con le sue bombe a mano. E perché non provava a raggiungere il ragazzo con una bomba, pur stando nascosto? Si sdraiò schiena a terra, allungò il braccio dietro a sé, badando a non scoprirsi, radunò le forze e lanciò la bomba. Un bel tiro; sarebbe andata lontano; però a metà della parabola una fucilata la fece esplodere in aria. Il soldato si buttò faccia a terra perché non gli arrivassero schegge.
Quando rialzò il capo era venuto il corvo. C'era nel cielo sopra di lui un uccello nero che volava a giri lenti, un corvo forse. Adesso certo il ragazzo gli avrebbe sparato. Ma lo sparo tardava a farsi sentire. Forse il corvo era troppo alto? Eppure ne aveva colpito di più alti e veloci. Alla fine una fucilata: adesso il corvo sarebbe caduto, no, continuava a girare lento, impassibile. Cadde una pigna, invece, da un pino lì vicino. Si metteva a tirare alle pigne, adesso? A una a una colpiva le pigne che cascavano con una botta secca.
A ogni sparo il soldato guardava il corvo: cadeva? No, l'uccello nero girava sempre più basso sopra di lui. Possibile che il ragazzo non lo vedesse? Forse il corvo non esisteva, era una sua allucinazione. Forse chi sta per morire vede passare tutti gli uccelli: quando vede il corvo vuol dire che è l'ora. Pure, bisognava avvertire il ragazzo che continuava a sparare alle pigne. Allora il soldato si alzò in piedi e indicando l'uccello nero col dito, - Là c'è il corvo! - gridò, nella sua lingua. Il proiettile lo prese giusto in mezzo a un'aquila ad ali spiegate che aveva ricamata sulla giubba.
Il corvo s'abbassava lentamente, a giri.
I tre erano nudi, seduti su una pietra. Intorno c'erano tutti gli uomini del paese e quello grande con la barba di fronte a loro.
-... e ho visto le fiamme più alte delle montagne, - diceva il vecchio con la barba, - e ho detto: come può bruciare così alto un paese?
Loro non capivano niente.
- E ho sentito l'odore del fumo che non si poteva sopportare, e ho detto: come può puzzare così il fumo del nostro paese?
Quello alto dei tre nudi s'abbracciava le spalle perché tirava un po' di vento e diede una gomitata all'anziano, che spiegasse: voleva ancora cercar di capire e l'anziano era l'unico che sapesse un po' la lingua. Ma l'anziano ora non alzava più la testa dalle mani, e solo ogni tanto sulla sua schiena china passava un brivido per la catena delle vertebre. Sul grasso non c'era più da far conto; s'era abbandonato a un tremito che agitava l'adipe donnesco del suo corpo, gli occhi come vetri rigati dalla pioggia.
- E poi mi hanno detto che erano le fiamme del nostro grano che bruciavano le case e che dentro c'erano i nostri figli ammazzati che facevano puzzo bruciando: il figlio di Tancin, il figlio di Gé, e il figlio della guardia del dazio.
- Mio fratello Bastian! - gridò quello con gli occhi spiritati. Era l'unico che interrompesse, ogni tanto. Gli altri stavano zitti e seri, con le mani poggiate sui fucili.
L'alto dei tre nudi non era proprio della nazionalità dei suoi compagni: era d'una regione che aveva avuto a suo tempo paesi bruciati e figli uccisi. Perciò sapeva cosa si pensa di chi brucia e uccide, e avrebbe dovuto avere meno speranza degli altri. Invece qualcosa gl'impediva di rassegnarsi, un'angosciosa incertezza.
- Ora noi siamo riusciti a prendere questi tre uomini soltanto, - diceva il grande con la barba.
- Tre soltanto, purtroppo! - gridò lo spiritato, ma gli altri stavano sempre zitti.
- Può darsi che anche tra loro ci siano i non cattivi, quelli che obbediscono malvolentieri, può forse darsi che questi tre siano di quelli...
Lo spiritato sbarrò gli occhi addosso al vecchio.
- Spiega, - diceva all'anziano l'alto dei tre nudi, sottovoce. Ma tutta la vita dell'anziano sembrava ormai corresse via per le colline delle vertebre.
- Ma quando si tratta di figli uccisi e di case bruciate non si può distinguere tra cattivi e non cattivi. E noi siamo sicuri d'essere nel giusto, condannando questi tre uomini a morte.
«Morte, - pensava l'alto dei tre nudi, - ho già sentito questa parola. Cosa vorrà dire? Morte».
Ma l'anziano non dava retta e il più grasso sembrava essersi messo a mormorare delle preghiere. A un tratto si ricordò d'essere cattolico, il più grasso. Era l'unico cattolico della compagnia e spesso i compagni lo canzonavano. - Io sono cattolico... prese a ripetere a mezza voce, nella sua lingua. Non si capiva se volesse implorare salvezza sulla terra, oppure in cielo.
- Io dico che prima di farli morire bisognerebbe... - fece lo spiritato ma gli altri s'alzarono e non gli diedero retta.
- Al Culdistrega, - disse quello coi baffi neri, così non c'è da scavare la fossa.
Fecero alzare i tre. Il più grasso si mise le mani sui genitali. Non c'era nulla che li facesse sentire in stato d'accusa quanto il fatto d'essere nudi.
Li condussero su per il sentiero di rocce, con le armi alle reni. Il Culdistrega era l'apertura d'una caverna verticale, un pozzo che scendeva nella pancia della montagna, giù giù, non si sapeva fin dove. I tre nudi furono condotti sull'orlo e i paesani armati si disposero davanti; allora l'anziano cominciò a gridare. Gridava frasi di disperazione, forse nel suo dialetto, gli altri due non lo capivano: era padre di famiglia, l'anziano, ma era anche il più cattivo di loro e i suoi gridi ebbero l'effetto di rendere gli altri due irritati contro di lui e più calmi di fronte alla morte. Quello alto, però, aveva ancora quella strana inquietudine, come se non fosse ben sicuro di qualcosa. Il cattolico teneva basse le mani giunte, non si capiva se per pregare o per nascondere i genitali che gli s'erano raggrinziti dalla paura.
A perdere la calma sentendo gridare l'anziano furono i paesani armati: vollero farla finita al più presto e cominciarono a sparare alla rinfusa, senz'attendere un ordine. Quello alto vide accasciarsi il cattolico, al suo fianco, e rotolare nel precipizio, poi l'anziano cadere a testa indietro, e sparire trascinando il suo ultimo grido giù per le pareti di roccia. Vide ancora tra la nube di polvere un paesano che s'accaniva su un otturatore inceppato, poi cascò nel buio.
Non perse conoscenza subito per una nuvola di dolore che gli arrivò addosso come uno sciame d'api: aveva traversato un roveto. Poi, tonnellate di vuoto appese al ventre, e svenne.
Improvvisamente gli sembrò di tornare in alto come per una grande spinta della terra: s'era fermato. Toccava bagnato e odorava sangue. Certo s'era sfracellato e stava per morire. Ma non si sentiva venir meno e tutti i dolori della caduta erano ancora ben vivi e distinti addosso a lui. Mosse una mano, la sinistra: rispondeva. Cercò a tastoni l'altro braccio, toccò il polso, il gomito: ma il braccio non sentiva nulla, era come morto, si muoveva solo se sollevato dall'altra mano. S'accorse che stava alzando il polso della mano destra tenendolo con due mani: questo era impossibile. Capì allora che aveva in mano il braccio d'un altro; era caduto sui cadaveri dei due compagni ammazzati. Tastò l'adipe del cattolico: era un molle tappeto che aveva attutito la sua caduta. Per questo era vivo. Per questo, e perché, ora ricordava, lui non era stato colpito ma s'era buttato giù prima; non ricordava però se l'aveva fatto con intenzione, ma ora ciò non aveva importanza. Poi scoprì che vedeva: un po' di luce arrivava fin là in fondo e l'alto dei tre nudi poté distinguere le sue mani e quelle che spuntavano dal carnaio sotto di sé. Si girò e guardò in alto: c'era un'apertura piena di luce, in cima: l'imboccatura del Culdistrega. Dapprima gli ferì la vista come un bagliore giallo; poi abituò l'occhio e distinse l'azzurro del cielo, lontanissimo da lui, doppiamente lontano che dalla crosta della terra.
La vista del cielo lo disperò: certo era meglio fosse morto. Ora egli era insieme ai due compagni fucilati in fondo a un pozzo, da cui non sarebbe potuto uscire mai. Gridò. La macchia di cielo lassù in cima si frastagliò di teste. - Ce n'è uno vivo! - dissero. Buttarono un oggetto. Il nudo lo guardò scendere giù come una pietra, poi urtare contro una parete e udì lo scoppio. C'era una nicchia nella roccia dietro di lui e il nudo ci si rattrappì dentro: il pozzo s'era riempito di polvere e scaglie di pietra che franavano. Tirò a sé il corpo del cattolico e lo alzò davanti alla nicchia; si teneva appena insieme ma era l'unica cosa che potesse servirgli da riparo. Fece proprio in tempo: un'altra bomba scese e raggiunse il fondo, alzando un volo di sangue e pietre. Il cadavere andò in pezzi: il nudo era senza più difesa né, speranza, ormai. Gridò. Nella stella di cielo apparve la bianca barba del grande. Gli altri si tirarono da parte.
- Ehi, - disse il grande con la barba.
- Ehi, - rispose l'uomo nudo, dal fondo.
E il grande con la barba ripeté: - Ehi.
Non c'era altro da dire, tra loro.
Allora il grande con la barba si voltò: - Tirategli una corda, - disse.
Il nudo non capì. Vide delle teste d'uomo andarsene e i rimasti fargli dei segni, segni di sì, di stare calmo. Il nudo li guardava sporgendo la testa dalla nicchia, non osando esporsi del tutto, sempre con quell'inquietudine di quand'era sulla pietra e lo processavano. Ma i paesani ora non tiravano più bombe, guardavano in giù e gli facevano domande, e lui rispondeva con dei gemiti. La corda non arrivava, a uno a uno i paesani s'allontanarono dall'orlo. Il nudo allora uscì dal nascondiglio e considerò l'altezza che lo separava di lassù, le pareti di roccia nuda e ripida.
In quella apparve la faccia dello spiritato. Si guardava intorno, sorrideva. Si sporse dall'orlo del Culdistrega; puntò in basso il fucile e sparò. Il nudo sentì fischiare il colpo all'orecchio: il Culdistrega era un cunicolo storto, non ben verticale, perciò le cose buttate raggiungevano di rado il fondo e gli spari era più facile incontrassero un'ansa della roccia e si fermassero lì. Si racquattò nel suo rifugio, con la bava alle labbra, come un cane. Ecco, ora lassù tutti i paesani erano tornati e uno srotolava una lunga corda giù nel precipizio. Il nudo vedeva la corda scendere scendere ma non si muoveva.
- Alé, - gridò giù quello coi baffi neri, - attaccati e sali.
Ma il nudo stava fermo nella nicchia.
- Su, bravo, - gridavano, - non ti facciamo niente. E gli facevano ballare quella corda davanti agli occhi. Il nudo aveva paura.
- Non ti facciamo niente. Giuro, - dicevano gli uomini, e cercavano di aver l'accento più sincero. Ed erano sinceri: volevano salvarlo a tutti i costi per poterlo fucilare di nuovo, ma in quel momento volevano salvarlo e nelle loro voci c'era un accento d'affetto, di fratellanza umana. Il nudo sentì tutto questo e poi aveva poco da scegliere: e diede mano alla corda. Però vide, tra gli uomini che la reggevano, apparire la testa di quello con gli occhi spiritati; allora mollò la corda e si nascose. Dovettero ricominciare a convincerlo, a pregarlo; finalmente lui si decise e incominciò a salire. La corda era nodosa e ci s'arrampicava bene, poi ci si poteva aggrappare alle sporgenze della roccia e il nudo riemergeva lentamente alla luce e le teste dei paesani in cima si facevano più chiare e più grandi. Quello con gli occhi spiritati ricomparve tutt'a un tratto e gli altri non fecero in tempo a trattenerlo: aveva un'arma automatica e si mise subito a far fuoco. La corda si spezzò alla prima raffica, proprio sopra le sue mani. L'uomo crollò giù sbatacchiando contro le pareti e andò a ripiombare sui resti dei compagni. Lassù, sullo sfondo del cielo, c'era il grande con la barba che apriva le braccia e scuoteva il capo.
Gli altri volevano spiegargli, a gesti, a gridi, che non era colpa loro, che a quel matto avrebbero dato il fatto suo, che ora avrebbero cercato un'altra corda e l'avrebbero fatto risalire, ma il nudo non aveva più speranza, ormai: non sarebbe più potuto ritornare sulla terra. Quello era un fondo di pozzo da cui non si poteva più uscire, dove sarebbe impazzito bevendo sangue e mangiando carne umana, senza poter mai morire. Lassù, sullo sfondo del cielo c'erano angeli buoni con corde e angeli cattivi con bombe e fucili e un grande vecchio con la barba bianca che apriva le braccia ma non poteva salvarlo. Gli armati, visto che non si lasciava convincere dalle loro buone parole, decisero di finirlo a furia di bombe, e cominciarono a gettarne. Ma il nudo aveva trovato un altro ricovero, una fessura piatta dove poteva strisciare al sicuro. A ogni bomba che cadeva lui s'approfondiva in questa fessura di roccia finche arrivò in un punto in cui non vedeva più nessuna luce, ma pure non toccava ancora la fine della fessura. Continuava a trascinarsi sulla pancia, come un serpente e tutt'intorno a lui c'era buio e il tufo umido e viscido. Da umido che era, il fondo di tufo divenne bagnato, poi coperto d'acqua; il nudo sentì un freddo ruscello che correva sotto la sua pancia. Era il cammino che le acque grondate giù dal Culdistrega s'erano aperto sotto la terra: una lunghissima e stretta caverna, un budello sotterraneo. Dove sarebbe andato a finire? Forse si perdeva in caverne cieche nel ventre della montagna, forse restituiva l'acqua attraverso vene sottilissime che sboccavano in sorgenti. Ed ecco: il suo cadavere sarebbe marcito così in un cunicolo e avrebbe inquinato le acque delle sorgenti avvelenando interi paesi.
L'aria era irrespirabile; il nudo sentiva avvicinarsi il momento in cui i suoi polmoni non avrebbero potuto più resistere. Invece aumentava il refrigerio dell'acqua sempre più alta e rapida; il nudo strisciava ora immerso con tutto il corpo e poteva nettarsi dalla crosta di fango e sangue proprio e altrui. Non sapeva se aveva avanzato poco o moltissimo; l'oscurità completa e quel muoversi strisciando gli toglievano il senso delle distanze. Era esausto: ai suoi occhi cominciavano a apparire disegni luminosi, in figure informi. Più avanzava più questo disegno negli occhi schiariva, prendeva contorni netti, pur trasformandosi di continuo. E se non fosse stato un bagliore della retina, ma una luce, una vera luce, alla fine della caverna? Sarebbe bastato chiudere gli occhi, o guardare nella direzione opposta per accertarsene. Ma a chi fissa una luce rimane un abbaglio alla radice dello sguardo, anche a chiudere le palpebre e voltare gli occhi: così lui non poteva distinguere tra luci esterne e luci sue, e rimaneva nel dubbio.
D'un'altra cosa nuova s'accorse al tatto: le stalattiti. Stalattiti viscide pendevano dal soffitto del cunicolo e stalagmiti s'alzavano da terra, ai margini della corrente, là dove non venivano erose. Il nudo avanzava attaccandosi a queste stalattiti sopra la sua testa. E procedendo s'accorgeva che le sue braccia da piegate che erano si dovevano man mano drizzare per toccare le stalattiti, cioè che il cunicolo s'andava ingrandendo. Presto l'uomo poté inarcare la schiena, camminare carponi, e il chiarore si faceva meno incerto, ora poteva distinguere se i suoi occhi erano aperti o chiusi, già indovinava i contorni delle cose, l'arco della volta, il pendere delle stalattiti, il luccicare nero della corrente.
E poi l'uomo camminò ormai in piedi, per la lunga caverna, verso l'apertura luminosa, con l'acqua alla vita, sempre aggrappandosi alle stalattiti per tenersi ritto. Una stalattite sembrava più grande delle altre e quando l'uomo l'afferrò sentì che gli s'apriva in mano e gli batteva in viso un'ala fredda e molle. Un pipistrello! Continuò a volare e altri pipistrelli appesi a testa in basso si svegliarono e volarono, presto tutta la caverna fu piena d'un volare silenzioso di pipistrelli, e l'uomo sentiva il vento delle loro ali intorno a sé e le carezze della loro pelle sulla sua fronte, sulla sua bocca. Avanzò in una nuvola di pipistrelli fino all'aria aperta.
La caverna sboccava in un torrente. L'uomo nudo era di nuovo sulla crosta della terra, sotto il cielo. Era salvo? Bisognava badare a non ingannarsi. Il torrente era silenzioso, aveva sassi bianchi e sassi neri. Intorno c'era un bosco fitto d'alberi deformi, nel sottobosco non crescevano che stecchi e spini. L'uomo era nudo in regioni selvagge e deserte, e gli esseri umani più vicini erano nemici che l'avrebbero inseguito con forche e fucili appena visto.
L'uomo nudo era salito in cima a un albero di salice. La vallata era tutta boschi e dirupi cespugliosi, sotto una fuga grigia di montagne. Ma in fondo, a una gobba del torrente c'era un tetto d'ardesia e un fumo bianco che s'alzava. La vita, pensò il nudo, era un inferno, con rari richiami d'antichi felici paradisi.
I giorni di rastrellamento, al bosco sembra che ci sia la fiera. Tra i cespugli e gli alberi fuori dai sentieri è un continuo passare di famiglie che spingono la mucca od il vitello, e vecchie con la capra legata a una corda, e bambine con l'oca sotto il braccio. C'è chi addirittura scappa coi conigli.
Da ogni parte si vada, più i castagni son fitti, più si incontrano panciuti bovi e scampananti mucche che non sanno come muoversi per quei dirupati pendii. Meglio ci si trovano le capre, ma i più contenti sono i muli che una volta tanto posson muoversi scarichi, brucando cortecce per i viottoli. I maiali vanno per grufolare in terra e si pungono coi ricci tutto il grugno; le galline s'appollaiano sugli alberi e fanno paura agli scoiattoli; i conigli che in secoli di stalla hanno disimparato a scavar tane, non trovano di meglio che cacciarsi dentro il cavo degli alberi. Alle volte s'incontrano coi ghiri che li mordono.
Quella mattina il contadino Giuà Dei Fichi, stava facendo legna in un remoto angolo del bosco. Non sapeva nulla di quel che succedeva al paese, perché n'era partito la sera del giorno prima con l'intento d'andare per funghi la mattina presto e aveva dormito in un casolare in mezzo al bosco, che serviva, d'autunno, a essiccare le castagne.
Perciò mentre menava colpi d'accetta contro un tronco morto, fu sorpreso a sentire, lontano e vicino per il bosco, un vago rintoccare di campani. S'interruppe e udì delle voci avvicinarsi. Gridò: Ooo-u!
Giuà Dei Fichi era un ometto basso e tondo, con una faccia da lunapiena nerastra di pelo e rubizza di vino, portava un verde cappello a pan di zucchero con una penna di fagiano, una camicia a grandi pallini gialli sotto il gilecco di fustagno, e una sciarpa rossa intorno alla pancia a pallone per sostenergli i pantaloni pieni di toppe turchine.
- Ooo-u! - gli risposero e apparve tra le rocce verdi di licheni un contadino coi baffi e il cappello di paglia, suo compare, che si portava dietro un caprone dalla barba bianca.
- Cosa fai qui, Giuà, - gli disse il compare, - sono arrivati i tedeschi al paese e girano tutte le stalle!
- Ohimè di me! - gridò Giuà Dei Fichi. - Troveranno la mia mucca Coccinella e la porteranno via!
- Corri che forse fai ancora in tempo a nasconderla, - lo consigliò il compare. - Noi abbiamo visto la colonna che saliva in fondovalle e siamo subito scappati. Ma può darsi che ancora non siano arrivati a casa tua.
Giuà lasciò legna, accetta e cestino dei funghi e corse via.
Correndo per il bosco s'imbatteva in file d'anatre che gli scappavano starnazzando di tra i piedi, e in greggi di pecore che marciavano compatte fianco a fianco senza lasciargli il passo, e in ragazzi e in vecchine che gli gridavano: - Sono arrivati già alla Madonnetta! Stanno frugando le case sopra il ponte! Li ho visti girare la svolta prima del paese! - Giuà Dei Fichi s'affrettava con le corte gambe, rotolando come una palla giù per i pendii, guadagnando le salite a cuore in gola.
Corri e corri, arrivò a un gomito di costone donde s'apriva la vista del paese. C'era un gran spaziare d'aria mattiniera e tenera, uno sfumato circondario di montagne, e in mezzo il paese di case ossute e accatastate tutte pietre e ardesia. E nell'aria tesa veniva dal paese un gridare tedesco e un battere di pugni contro porte.
«Ohimè di me! ci sono già i tedeschi nelle case!» Giuà Dei Fichi tremava tutto nelle braccia e nelle gambe: un po' di tremito ce l'aveva di natura per via del bere, un po' gli veniva adesso a pensare alla mucca Coccinella, unico suo bene al mondo, che stava per venir portata via.
Quatto quatto, tagliando per i campi, tenendosi al coperto dietro i filari delle vigne, Giuà Dei Fichi s'avvicinò al paese. La sua casa era una delle ultime ed esterne, là dove il paese si perdeva negli orti, in mezzo a un dilagar verde di zucche: poteva darsi che i tedeschi non fossero arrivati ancora lì. Giuà facendo capolino dai cantoni cominciò a scivolare nel paese. Vide una strada vuota coi consueti odori di fieno e di stallino, e questi nuovi rumori che venivano dal centro del paese: voci disumane e passi ferrati. La sua casa era lì: ancora chiusa. Era chiusa sia la porta della stalla a pianterreno sia quella delle stanze, in cima alla consunta scala esterna, tra cespi di basilico piantati dentro pentole di terra. Una voce dall'interno della stalla disse: - Muuuuuu.. - Era la mucca Coccinella che riconosceva l'avvicinarsi del padrone. Giuà si rimescolò di contentezza.
Ma ecco che sotto un archivolto si sentì rimbombare un passo umano: Giuà si nascose nel vano di una porta tirando indietro la pancia rotonda. Era un tedesco dall'aria contadina, coi polsi e il collo allampanati che sporgevano dalla corta giubba, le gambe lunghe lunghe e un fucilaccio lungo quanto lui. S'era allontanato dai compagni per veder di cacciare qualcosa per suo conto; e anche perché le cose e gli odori del paese gli ricordavano cose e odori noti. Così andava fiutando l'aria e guardando intorno con una gialla faccia porcina sotto la visiera dello schiacciato cheppì. In quella Coccinella disse: - Muuuu... - Non capiva come mai il padrone non arrivasse ancora. Il tedesco ebbe un guizzo in quei suoi panni striminziti e si diresse subito alla stalla; Giuà Dei Fichi non respirava più.
Vide il tedesco che s'accaniva a dar calci alla porta: presto l'avrebbe sfondata, di sicuro. Giuà allora scantonò e passò dietro la casa, andò al fienile e prese a rovistare sotto il fieno. C'era nascosta la sua vecchia doppietta da caccia, con una fornita cartuccera. Giuà caricò il fucile con due pallottole da cinghiale, si cinse la pancia con la cartuccera e quatto quatto, a fucile spianato, andò a appostarsi all'uscita della stalla. Già il tedesco stava uscendo tirandosi dietro Coccinella legata ad una fune. Era una bella mucca rossa a macchie nere e perciò si chiamava Coccinella. Era una mucca giovane, affettuosa e puntigliosa: ora non voleva lasciarsi portar via da quest'uomo sconosciuto, e s'impuntava; il tedesco la doveva spinger via per il garrese.
Nascosto dietro un muro Giuà Dei Fichi mirò. Ora bisogna sapere che Giuà era il cacciatore più schiappino del paese. Non era mai riuscito a centrare, manco per sbaglio, non dico una lepre ma nemmeno uno scoiattolo. Quando sparava ai tordi al fermo, quelli manco si muovevano dal ramo. Nessuno voleva andare a caccia con lui perché impallinava il sedere dei compagni. Non aveva mira e gli tremavano le mani. Figuriamoci adesso, tutto emozionato com'era!
Puntava, ma le mani gli tremavano e la bocca della doppietta continuava a girare in aria. Faceva per mirare al cuore del tedesco e subito gli appariva il sedere della mucca sul mirino. «Ohimè di me! - pensava Giuà, - e se sparo al tedesco e uccido Coccinella?» E non s'azzardava a tirare.
Il tedesco s'avanzava a stento con questa mucca che sentiva la vicinanza del padrone e non si lasciava trascinare. S'accorse a un tratto che i suoi commilitoni avevano già sgombrato il paese e scendevano per lo stradone. Il tedesco s'accinse a raggiungerli con quella testarda mucca dietro. Giuà li seguiva a distanza, saltando dietro le siepi e i muretti e puntando ogni tanto il fucilaccio. Ma non riusciva a tener ferma l'arma e il tedesco e la mucca eran sempre troppo vicini l'uno all'altra perché lui s'azzardasse a far partire un colpo. Che se la dovesse lasciar portare via?
Per raggiungere la colonna che s'allontanava, il tedesco prese una scorciatoia per il bosco. Adesso riusciva più facile a Giuà tenergli dietro nascondendosi tra i tronchi. E forse ora il tedesco avrebbe proceduto più discosto dalla mucca in modo che fosse possibile tirargli.
Una volta nel bosco Coccinella parve perdere la riluttanza a muoversi, anzi, poiché il tedesco tra quei viottoli si raccapezzava poco, era lei a guidarlo e a decidere nei bivi. Non passò molto e il tedesco s'accorse che non era sulla scorciatoia dello stradone ma in mezzo al bosco fitto: in una parola s'era smarrito insieme a quella mucca.
Graffiandosi il naso nei roveti e finendo a piè pari nei ruscelli Giuà Dei Fichi gli teneva dietro, tra frulli di scriccioli che prendevano il volo e sgusciar di ranocchi dei pantani. Prendere la mira in mezzo agli alberi era ancor più difficile, a farla passare attraverso tanti ostacoli e con quella groppa rossa e nera tanto estesa che gli si parava sempre sotto gli occhi.
Il tedesco già guardava con paura il bosco fitto, e studiava come poteva fare a uscirne, quando udì un fruscio in un cespuglio di corbezzoli e sbucò fuori un bel maiale rosa. Mai al suo paese aveva visto maiali che girassero nei boschi. Mollò la corda della mucca e si mise dietro al maiale. Coccinella appena si vide libera s'inoltrò trotterellando per il bosco, che sentiva pullulare di presenze amiche.
Per Giuà era venuto il momento di sparare. Il tedesco s'affaccendava intorno al porco, l'abbracciava per tenerlo fermo, ma quello gli sgusciava via.
Giuà era lì lì per schiacciare il grilletto, quando gli apparvero vicini due bambini, un maschietto e una piccina, coi berrettini di lana a pon-pon e le calze lunghe. I bambini avevano i lucciconi in pelle in pelle: - Tira bene, Giuà, mi raccomando, - dicevano, - se ci ammazzi il maiale non ci resta più nulla! - A Giuà Dei Fichi quel fucile nelle mani riprese a ballar la tarantella: era un uomo di cuore troppo tenero e s'emozionava troppo, non perché doveva ammazzare quel tedesco ma per il rischio che correva il maiale di quei due poveri bambini.
Il tedesco rotolava contro pietre e cespugli con quel maiale tra le braccia che si dibatteva e gridava: - Ghiii... ghiii... ghiii... - A un tratto ai gridi del maiale rispose un - Bee,... - e da una grotta uscì un agnellino. Il tedesco lasciò scappare il porco e si mise dietro all'agnellino. Strano bosco, pensava, con maiali nei cespugli e agnelli nelle tane. E acchiappato per una zampa l'agnellino che belava a perdifiato se lo issò in spalla come il Buon Pastore, ed andò via. Giuà Dei Fichi lo seguiva quatto quatto. "Stavolta non scappa. Stavolta c'è", diceva e già stava per tirare, quando una mano gli alzò la canna del fucile. Era un vecchio pastore con la barba bianca, che giunse le mani verso di lui dicendo: - Giuà, non mi ammazzare l'agnellino, uccidi lui ma non mi ammazzare l'agnellino. Mira bene, una volta tanto, mira bene! - Ma Giuà ormai non capiva più niente, e non trovava nemmeno il grilletto.
Il tedesco andando per il bosco faceva scoperte da restar a bocca aperta: pulcini sopra gli alberi, porcellini d'India che facevano capolino dal cavo dei tronchi. C'era tutta l'arca di Noè. Ecco che su un ramo di pino vide posato un tacchino che faceva la ruota. Subito, alzò la mano per pigliarlo, ma il tacchino, con un piccolo salto, andò ad appollaiarsi su un ramo del palco più alto, sempre continuando a far la ruota. Il tedesco, lasciando l'agnello, cominciò ad arrampicarsi su quel pino. Ma ogni palco di rami che lui saliva, il tacchino andava su d'un altro palco, senza scomporsi, impettito e coi penduli bargigli fiammeggianti.
Giuà avanzava sotto l'albero con un ramo frondoso sulla testa, altri due sulle spalle e uno legato alla canna del fucile. Ma arrivò una giovane grassottella con un fazzoletto rosso intorno al capo. - Giuà, - disse, - stammi a sentire, se ammazzi il tedesco io ti sposo, se m'ammazzi il tacchino ti taglio le budella -. Giuà che era anziano ma scapolo e pudico, diventò tutto rosso e il fucile gli ruotava davanti come un girarrosto.
Il tedesco salendo era arrivato ai rami più sottili, finché uno non gli si spezzò sotto i piedi e lui cascò. Per poco non finì addosso a Giuà Dei Fichi, che questa volta ebbe occhio e scappò via. Ma lasciò per terra tutti i rami che lo nascondevano, così il tedesco cadde sul morbido e non si fece niente.
Cadde e vide una lepre sul sentiero. Ma non era una lepre: era panciuta e ovale e sentendo rumore non scappò, ma s'appiattì per terra. Era un coniglio e il tedesco lo prese per gli orecchi. Avanzava così col coniglio che squittiva e si contorceva in tutti i sensi e lui era costretto per non farselo scappare a saltare in qua e in là col braccio alzato. Il bosco era tutto muggiti e belati e coccodé: a ogni passo si facevano nuove scoperte d'animali: un pappagallo su un ramo d'agrifoglio, tre pesci rossi sguazzanti in una polla.
A cavalcioni d'un alto ramo d'una annosa quercia Giuà seguiva la danza del tedesco col coniglio. Ma era difficile prenderlo di mira perché il coniglio cambiava continuamente posizione e capitava in mezzo. Giuà si sentì tirare per un lembo del gilecco: era una ragazzina con le trecce e la faccia lentigginosa: - Non uccidermi il coniglio, Giuà, se no è lo stesso che me lo porti via il tedesco.
Intanto il tedesco era arrivato a un posto tutte pietre grige, ròse da licheni azzurri e verdi. Solo pochi pini scheletriti crescevano intorno, e vicino s'apriva un precipizio. Nel tappeto d'aghi di pino che giaceva in terra, stava razzolando una gallina. Il tedesco fece per rincorrere la gallina e il coniglio gli scappò.
Era la gallina più magra, vecchia e spennacchiata che mai si fosse vista. Apparteneva a Girumina, la vecchia più povera del paese. Il tedesco l'ebbe presto tra le mani.
Giuà s'era appostato in cima a quelle rocce e aveva costruito un piedestallo di pietre per il suo fucile. Anzi aveva messo su proprio la facciata d'un fortino, con solo una stretta feritoia per far passare la canna del fucile. Adesso poteva sparare senza scrupoli, ché se anche ammazzava quella gallina spennacchiata era mal di poco. Ma ecco che la vecchia Girumina, raggomitolata in scialli neri e cenciosi, lo raggiunse e gli fece questo ragionamento: - Giuà, che i tedeschi mi portino via la gallina, unica cosa che mi resti al mondo, è già triste. Ma che sia tu che me l'ammazzi a fucilate è più triste ancora.
Giuà riprese a tremare più di prima, per la gran responsabilità che gli toccava. Pure si fece forza e schiacciò il grilletto.
Il tedesco sentì lo sparo e vide la gallina che gli starnazzava in mano restare senza coda. Poi un altro colpo, e la gallina restare senza un'ala. Era una gallina stregata, che esplodeva ogni tanto e gli si consumava in mano? Un altro scoppio e la gallina fu completamente spennata, pronta per andare arrosto, e pure continuava a starnazzare. Il tedesco che cominciava a esser preso dal terrore la teneva per il collo discosta da sé. Una quarta cartuccia di Giuà le troncò il collo proprio sotto la sua mano e lui rimase con la testa in mano che si muoveva ancora. Buttò via tutto e scappò via. Ma non trovava più sentieri. Vicino a lui s'apriva quel roccioso precipizio. Ultimo albero prima del precipizio era un carrubo e sui rami del carrubo il tedesco vide rampare un grosso gatto.
Ormai non si stupiva più di vedere animali domestici sparsi per il bosco e avanzò la mano per accarezzare il gatto. Lo prese per la collottola e sperava di consolarsi a sentirlo far le fusa.
Ora bisogna sapere che quel bosco era da tempo infestato da un feroce gatto selvatico che uccideva i volatili e talvolta si spingeva fino al paese nei pollai. Così il tedesco che credeva di sentir fare ronron, si vide precipitare il felino contro a pelo dritto e arruffato e sentì le sue unghie farlo a brani. Nella zuffa che seguì l'uomo e la belva rotolarono ambedue nel precipizio.
Fu così che Giuà, tiratore schiappino, fu festeggiato come il più grande partigiano e cacciatore del paese. Alla povera Girumina fu comprata una covata di pulcini a spese della comunità.
- Minato, - così il vecchio aveva detto, facendo girare una mano aperta davanti agli occhi, come schiarisse un vetro appannato. - Tutto per lì, non si sa bene dove. Sono venuti e hanno minato. Noi stavamo nascosti.
L'uomo coi calzoni zuavi aveva guardato un po' il versante della montagna, un po' il vecchio ritto sulla porta.
- Ma dalla fine della guerra ad ora, - aveva detto, - c'era tempo di provvedere. Pure il passaggio ci deve essere. Qualcuno lo saprà bene.
«Tu, vecchio, lo sai bene», aveva anche pensato, perché di certo il vecchio era un contrabbandiere e conosceva la frontiera come il fornello della sua pipa.
Il vecchio aveva guardato i calzoni zuavi rattoppati, il tascapane sdrucito e floscio dell'uomo e quella crosta di polvere, dai capelli alle scarpe, che testimoniava quanti chilometri a piedi doveva aver fatto. - Non si sa bene dove, - aveva ripetuto. Per il passo. Un campo di mine -. E aveva fatto ancora quel gesto, come se ci fosse stato un vetro appannato tra lui e tutto il resto.
- Dico, non sarò ancora tanto sfortunato di andare a battere proprio su una mina? - aveva chiesto l'uomo, con un sorriso che gli aveva legato i denti come un cachi acerbo.
- Eh, - il vecchio aveva detto. Così soltanto: - Eh -. Ora l'uomo cercava di ricordarsi l'intonazione di quell'eh. Perché avrebbe potuto essere un eh, ci mancherebbe, o un eh, non si sa mai, o un eh, niente di più facile. Ma il vecchio aveva detto solo un eh senza nessuna intonazione, brullo come il suo sguardo, come il terreno di quelle montagne su cui anche l'erba era corta e dura come una barba umana mal rasa.
Le piante delle rive non arrivavano ad alzarsi più su del cespuglio, con di tanto in tanto un albero di pino storto e gommoso, messo in modo da fare meno ombra che poteva. L'uomo camminava adesso per i rimasugli dei sentieri che salivano il versante, mangiati di anno in anno dai cespugli e battuti solo dal passo dei contrabbandieri, passo da selvatico che lascia poca traccia.
- Terra maledetta, - diceva l'uomo coi calzoni zuavi. - Non vedo l'ora di essere sull'altro versante -. Per fortuna aveva già compiuto il tragitto altra volta prima della guerra, e poteva fare a meno di guida. Sapeva anche che il passo era un grande vallone in salita, che non si poteva minarlo tutto.
Poi sarebbe bastato stare attento a dove metteva i piedi: un posto con sotto una mina doveva ben avere qualcosa di diverso da tutti gli altri posti. Qualcosa: terra smossa, pietre posate ad arte, erba più giovane. Lì, per esempio, si vedeva subito che non potevano esserci mine. Non potevano? E quella lastra di ardesia sollevata? E quella striscia nuda in mezzo al prato? E quel tronco abbattuto sul passaggio? S'era fermato. Ma il passo era ancora distante, non ci potevano essere mine ancora: proseguì.
Forse avrebbe preferito traversare i terreni minati di notte strisciando nel buio, non per sfuggire le pattuglie confinarie, ché quelli erano posti sicuri, ma per sfuggire alla paura delle mine, come se le mine fossero state delle grandi bestie sonnacchiose, che potessero svegliarsi al suo passaggio. Marmotte: delle enormi marmotte accoccolate in tane sotterranee, con una che faceva la guardia dall'alto di un sasso, come usano le marmotte, e dava l'allarme al vederlo, con un sibilo.
«A quel sibilo, - pensava l'uomo, - il campo minato salta in aria: le marmotte enormi si precipitano contro di me e mi sbranano a morsi».
Ma mai uomo era stato morsicato dalle marmotte, mai lui sarebbe saltato in aria sulle mine. Era la fame, a suggerirgli quei pensieri; l'uomo lo sapeva, conosceva la fame, gli scherzi della fantasia dei giorni di fame, quando ogni cosa vista o sentita prende un significato di cibo o di morsi.
Le marmotte c'erano, però. Se ne sentiva il sibilo: ghiii... ghiii... dall'alto delle pietraie. «Riuscissi ad ammazzare una marmotta con un sasso, - pensò l'uomo, - ad arrostirla infilata a uno stecco».
Pensò all'odore di grasso di marmotta, ma senza nausea; la fame gli metteva voglia anche di grasso di marmotta, di qualsiasi cosa si potesse masticare. Da una settimana girava per i casolari, faceva visita ai pastori per elemosinare un pane di segale, una tazza di latte cagliato.
- Ne avessimo per noi. Non si ha niente, - dicevano e gli indicavano le pareti nude e fumose, guarnite solo di qualche treccia d'aglio.
Arrivò in vista del passo prima che se l'aspettasse. Ebbe un moto di stupore, quasi di spavento, subito: non si aspettava fossero fioriti i rododendri. Credeva di trovare davanti a sé il vallone nudo, di poter studiare ogni pietra, ogni cespuglio prima di mettere avanti un passo, invece si trovò affondato fino al ginocchio in un mare di rododendri, un mare uniforme, impenetrabile da cui sporgeva solo il dorso delle pietre grige.
E sotto, le mine. - Non si sa bene dove, - aveva detto il vecchio. - Tutto per lì -. E aveva girato per l'aria quelle mani aperte. All'uomo dai calzoni zuavi sembrava di vedere l'ombra di quelle mani posarsi sulla distesa di rododendri, espandersi fino a coprirla.
S'era scelto una direzione di marcia, lungo un'anfrattuosità parallela al vallone, scomoda a camminarci, ma scomoda anche per chi volesse minarla. Più in su i rododendri diradavano e tra le pietre si sentiva il ghiii... ghiii... delle marmotte, senza tregua come il sole sulla nuca.
«Dove ci sono marmotte, - pensò, piegando in quella direzione, - è segno che non c'è minato».
Ma era un ragionamento sbagliato: le mine erano anti-uomo, il peso di una marmotta non bastava a farle brillare. Solo allora si ricordò che le mine si chiamavano anti-uomo, e questo lo spaventò.
«Anti-uomo, - si ripeteva, - anti-uomo».
Quel nome era bastato a mettergli paura, tutt'a un tratto. Certo, se minavano un passo, era per renderlo del tutto impraticabile: gli conveniva tornare indietro, interrogare meglio gli uomini dei dintorni, tentare un'altra via.
Si girò per tornare indietro. Ma dove aveva posato il piede, prima? I rododendri si stendevano alle sue spalle come un mare vegetale, impenetrabile, senza tracce del suo passaggio. Forse egli era già in mezzo al campo minato, un passo falso avrebbe potuto perderlo: tanto valeva proseguire.
«Terra maledetta, - pensò. - Terra maledetta fino all'ultimo».
Avesse avuto un cane, un grosso cane pesante come un uomo, da mandare avanti. Gli venne fatto di schioccare la lingua come se incitasse un cane a correre. «Devo fare da cane a me stesso», pensò.
Forse bastava una pietra. Ce n'era una accanto a lui, grossa ma sollevabile, che faceva al caso. L'afferrò con due mani e la gettò davanti a sé il più lontano possibile, in salita. La pietra non cadde lontano e rotolò indietro verso di lui. Non c'era che tentare la sorte, così.
Era già nella parte alta del vallone, tra le pietraie infide. Le colonie di marmotte avevano sentito l'uomo ed erano in allarme. L'aria era punta dal loro stridere come da spine di cactus.
Ma l'uomo non pensava più a dar loro la caccia. Si era accorto che il vallone, assai spazioso all'imbocco, s'era andato man mano restringendo, e ormai non era che un canalone di rocce e di arbusti. Allora l'uomo comprese: il campo minato non poteva essere che lì. Solo in quel punto un certo numero di mine, poste alla distanza dovuta, potevano sbarrare tutti i passaggi obbligati. Questa scoperta, anziché terrorizzarlo, gli diede una strana tranquillità. Bene: ormai egli si trovava in mezzo al campo minato, era certo. Ormai non c'era che continuare a salire a caso, andasse come voleva. Se era destino che lui morisse quel giorno, sarebbe morto; se no, sarebbe passato tra una mina e l'altra e si sarebbe salvato.
Formulò questo pensiero sul destino senza convinzione: non credeva al destino. Certo, se egli faceva un passo era perché non poteva fare diversamente, era perché il movimento dei suoi muscoli, il corso dei suoi pensieri lo portavano a fare quel passo. Ma c'era un momento in cui poteva fare tanto un passo quanto l'altro, in cui i pensieri erano in dubbio, i muscoli tesi senza direzione. Decise di non pensare, di lasciar muovere le gambe come un automa, di mettere i passi a caso sulle pietre; ma sempre aveva il dubbio che fosse la sua volontà a scegliere se voltarsi a destra o a sinistra, se posare un piede su una pietra o sull'altra.
Si fermò. Aveva una strana smania addosso, fatta di fame e di paura, che non sapeva soddisfare. Cercò nelle tasche: aveva con sé uno specchietto, ricordo di una donna. Forse era questo che voleva: guardarsi in uno specchio. Nel pezzetto di vetro appannato apparve un occhio, gonfio e arrossato; poi una guancia incrostata di polvere e di pelo, poi le labbra aride screpolate, le gengive più rosse delle labbra, i denti... Pure l'uomo avrebbe voluto vedersi in un grande specchio, vedersi tutto. Far girare quel pezzetto di specchio intorno al viso per vedersi un occhio, un orecchio, non lo soddisfaceva.
Proseguì. «Non ho incontrato il campo di mine fino ad ora, - pensò. - Ormai ci saranno cinquanta, quaranta passi...»
Ogni volta che posava il piede, al sentire sotto di sé la terra dura e ferma, tirava il respiro. Un passo è fatto, un altro, un altro ancora. Questa lastra di galestro sembrava un trabocchetto, invece è solida; questo cespo di erica non nasconde niente: questa pietra... la pietra sotto il suo peso affondò di due dita. - Ghiii... ghiii... - facevano le marmotte. Avanti, l'altro piede.
La terra che divenne sole, l'aria che divenne terra, il ghiii delle marmotte che divenne tuono. L'uomo sentì una mano di ferro che lo afferrava per i capelli, alla nuca. Non una mano, ma cento mani che lo afferravano ognuna per un capello e lo strappavano fino ai piedi, come si strappa un foglio di carta, in centinaia di piccoli pezzi.
Subito compresi che sarebbe successo qualcosa. I due si guardavano attraverso il tavolo, con occhi senza espressione, come pesci in un acquario. Ma si capiva che erano estranei, incommensurabili l'uno all'altro, due animali sconosciuti tra loro che si studiano e diffidano. Lei era arrivata per prima: era una donna enorme nero-vestita, certo una vedova. Una vedova di campagna, venuta in città per commerci, così la definii subito. Nelle mense popolari da sessanta lire dove mangio io, viene anche questa specie di gente: borsaneristi grossi o piccoli con un gusto per l'economia rimasto in loro dai tempi di miseria, e con slanci di prodigalità ogni tanto, quando si ricordano di avere le tasche piene di carte da mille, slanci che li fanno ordinare tagliatelle e bistecche, mentre tutti noialtri, scapoli magri che mangiamo col buono, facciamo gli occhi lunghi e ingolliamo cucchiai di minestra. La donna doveva essere una borsanerista ricca; seduta occupava un lato del tavolo e andava tirando fuori dalla sua borsa pani bianchi, frutti, formaggi male involti in carta, e ne invadeva la tovaglia. Intanto, macchinalmente, con le dita orlate di nero, andava piluccando chicchi d'uva, pezzetti di pane, e li portava alla bocca dove sparivano in un mastichìo sommesso.
Fu allora che lui s'avvicinò, vide la sedia libera con davanti un angolo di tovaglia ancora sgombro. Chiese: - Permesso? - La donna lo guardò di sfuggita, masticando. Chiese ancora: - Scusi... Permesso? - La donna allargò le braccia ed emise un grugnito a bocca piena di pane masticato. L'uomo salutò sollevando leggermente il cappello e sedette. Era un vecchietto, lindo e logoro, col colletto inamidato, col cappotto benché non fosse inverno, col filo dell'apparecchio acustico che gli pendeva dall'orecchio. Subito, a vederlo, si provava disagio per lui, per quella beneducazione che traspariva da ogni suo gesto. Era di certo un nobile decaduto, piovuto tutt'a un tratto da un mondo di complimenti e inchini in un mondo di spintoni e di pugni nei fianchi, senza aver capito nulla, continuando a fare inchini tra la folla della mensa popolare come in un ricevimento a corte.
Ora erano una di fronte all'altro, la nuova ricca e l'ex ricco, animali sconosciuti l'uno all'altro; la donna larga e bassa, con grandi mani poggiate sulla tovaglia come zampe di granchio, e un movimento come il respirare di un granchio alla gola; il vecchietto seduto in cima alla sedia, coi gomiti stretti ai fianchi, le mani inguantate rattrappite dall'artrite e piccole vene turchine che gli sporgevano dalla faccia come su un sasso roso dai licheni.
- Scusi il cappello, - disse. La donna lo guardava col giallo degli occhi. Non capiva nulla di lui.
- Scusi, - ripeté l'uomo, - se tengo il cappello in testa. C'è un po' d'aria.
La gran vedova allora ebbe un sorriso agli angoli della bocca, guernita d'una peluria da insetto, senza quasi muovere i muscoli del volto, un sorriso inghiottito, da ventriloquo. - Vino, - disse alla cameriera che passava.
Il vecchio inguantato a quella parola batté gli occhi: il vino doveva piacergli, le vene in cima al naso testimoniavano bevute lunghe e attente, da buongustaio. Ma da tempo doveva aver rinunciato al bere. Ora la gran vedova inzuppava pezzi di pane bianco in un bicchiere di vino e masticava, masticava.
Al vecchio coi guanti alle volte dovevano prendere degli attacchi di vergogna, come stesse corteggiando una donna e temesse di farsi vedere avaro. - Vino anche a me! - disse.
Poi, subito, si pentì d'averlo detto, pensò che forse avrebbe dato fondo alla sua pensione prima della fine del mese e avrebbe dovuto digiunare per giorni e giorni incappottato nel freddo della sua soffitta. Non versò il vino nel bicchiere. «Forse, pensò, - lo posso restituire senza toccarlo, dire che m'è passata la voglia, e non pagarlo».
E la voglia gli era passata davvero, anche la voglia di mangiare; scucchiaiava nella minestra scipita masticando sotto i pochi denti, mentre la gran vedova ingurgitava forchettate di maccheroni grassi di burro.
«Speriamo che adesso stiano zitti, - pensavo, - che l'uno o l'altro finisca presto e se ne vada». Non so di cosa avessi paura. Erano esseri mostruosi l'uno e l'altro, carichi, sotto quella pigra apparenza di crostacei, d'un odio reciproco e terribile. Immaginavo una lotta tra di loro come un lento sbranarsi di mostri degli abissi marini.
Già il vecchio era quasi cinto d'assedio dalle cibarie della vedova nei cartocci sparsi per il tavolo: confinato in un angolo con la sua minestra scipita e i due panini smilzi della tessera. Fece per tirarli ancora indietro, i suoi panini, come per paura che si smarrissero nel campo nemico, ma per una mossa falsa della mano inguantata e rattrappita, urtò un pezzo di formaggio che cascò per terra.
La vedova era enorme davanti a lui: ghignava.
- Mi scusi... mi scusi... - disse l'inguantato. La vedova lo guardava come si guarda un nuovo animale; non rispose.
«Ecco, - pensavo io, - adesso lui grida: Basta! e strappa la tovaglia!»
Si chinò, invece, fece dei goffi movimenti sotto il tavolo per cercare il formaggio. La gran vedova stette un po' a guardarlo, poi, quasi senza muoversi, calò una delle sue zampe enormi verso terra, tirò su il pezzo di formaggio, lo nettò, l'avvicinò alla sua bocca da insetto, l'inghiottì prima ancora che il vecchio coi guanti fosse riemerso.
Finalmente egli si rialzò, dolorante per lo sforzo, rosso di confusione, col cappello storto e il filo dell'apparato acustico di sghimbescio.
«Ecco, - pensavo io, - ora prende il coltello e la uccide!»
Invece sembrava che non trovasse il modo di consolarsi della brutta figura ch'era convinto d'aver fatto. E gli prese la voglia di parlare, di discorrere su qualsiasi cosa, pur di dissipare quell'atmosfera di disagio. Ma non riusciva a dire una frase che non nascesse da quel disagio, che non fosse di scusa.
- Quel formaggio... - disse. - Davvero un peccato... Mi dispiace...
Alla gran vedova non bastava più umiliarlo col suo silenzio, voleva schiacciarlo addirittura.
- Me ne importa assai, - disse. - A Castel Brandone ne ho delle forme così di quel formaggio, - e fece un gesto. Ma non fu l'ampiezza del gesto che impressionò il vecchio inguantato.
- Castel Brandone? - disse e i suoi occhi luccicavano. - Io fui a Castel Brandone da sottotenente! Nel '95: per i tiri. Lei che è di là conoscerà certo i conti Brandone D'Asprez!
La vedova non ghignava più soltanto: rideva. Rideva e si voltava intorno per vedere se anche gli altri avventori avevano notato quant'era ridicolo quell'uomo.
- Lei non si ricorderà, - proseguì il vecchio, - lei non si ricorderà di certo... ma quell'anno a Castel Brandone, per i tiri, venne il re! Ci fu un ricevimento al castello dei D'Asprez! E fu allora che avvenne il fatto che sto per raccontarle...
La gran vedova guardò l'orologio, ordinò un piatto di fegato e riprese a mangiare in fretta, senza dargli ascolto. Il vecchio coi guanti capì che stava parlando solo per sé, ma non smise: avrebbe fatto una brutta figura a smettere, doveva terminare il racconto incominciato.
- Sua maestà entrò nel salone tutto illuminato, - continuò con le lacrime agli occhi. - E da una parte c'erano le dame in abito da sera che facevano l'inchino, e dall'altra tutti noi ufficiali sull'attenti. E il re baciò la mano alla contessa e salutò l'uno e l'altro. Poi s'avvicinò a me...
I due quarti di vino erano vicini sul tavolo: quello della vedova quasi finito, quello del vecchio ancora pieno. La vedova distrattamente si versò il vino del quarto pieno e bevve. Il vecchio, pur nel calore del racconto, se ne accorse: ecco, ormai non c'era più speranza, doveva pagarlo. E forse la gran vedova se lo sarebbe bevuto tutto. Ma non sarebbe stato delicato farle notare lo sbaglio, forse lei ci sarebbe rimasta male. No, non sarebbe stato delicato!
- E sua maestà mi chiese: E lei, tenente? Proprio così, mi chiese. E io, sull'attenti: Sottotenente Clermont De Fronges, maestà. E il re: Clermont! Ho conosciuto suo padre, disse, un bravo soldato! E mi strinse la mano... Proprio così disse: un bravo soldato! La gran vedova aveva finito di mangiare e s'era alzata. Ora stava frugando nella sua borsa posata sull'altra sedia. Stava chinata e al disopra del tavolo le si vedeva solo il sedere, un enorme sedere di donna grassa, coperto di stoffa nera. Il vecchio Clermont De Fronges aveva di fronte a sé questo grande sedere che si muoveva. Continuava a raccontare trasfigurato in volto: -...Tutta la sala con i lampadari accesi e le specchiere... E il re che mi strinse la mano. Bravo, Clermont De Fronges, mi disse... E tutte le signore intorno in abito da sera...
Il Dritto arrivò al posto convenuto e gli altri lo stavano aspettando già da un po'. C'erano tutt'e due: Gesubambino e Uora-uora. C'era tanto silenzio che dalla via si sentivano suonare gli orologi nelle case: due colpi, bisognava sbrigarsi se non si voleva farsi cogliere dall'alba.
- Andiamo, - disse il Dritto.
- Dov'è? - chiesero.
Il Dritto è uno che non spiega mai il colpo che ha intenzione di fare.
- Ora ci andiamo, - rispose.
E camminava in silenzio per le vie vuote come fiumi in secca, con la luna che li seguiva lungo i fili dei tram, il Dritto avanti con quei suoi occhi gialli mai fermi, e quel suo movimento alle narici che sembra che fiuti.
Gesubambino lo chiamano così perché ha la testa grossa da neonato e il corpo tozzo; forse anche perché ha i capelli tagliati corti e un bel faccino coi baffetti neri. É tutto muscoli e si muove soffice che sembra un gatto; per arrampicarsi e raggomitolarsi non c'è nessuno come lui e quando il Dritto lo porta con sé c'è sempre una ragione.
- Sarà un buon colpo, Dritto? - chiese Gesubambino.
- Se si fa, - disse il Dritto, una risposta che non voleva dir niente.
Ma intanto, per dei giri che sapeva solo lui, li aveva fatti scantonare in un cortile. I due capirono che c'era da lavorare in un retrobottega e Uora-uora si fece avanti perché non voleva fare il palo. Il destino di Uora-uora è fare il palo; il suo sogno sarebbe di entrare nelle case, frugare, riempirsi le tasche come gli altri, ma gli tocca sempre di fare il palo nelle strade fredde, nel pericolo delle pattuglie, battendo i denti perché non gelino e fumando per darsi un contegno. É un siciliano allampanato, Uora-uora, con una faccia triste da mulatto e i polsi che gli sporgono dalle maniche. Quando c'è un colpo da fare si veste tutto elegante, non si sa perché: col cappello, la cravatta e l'impermeabile, e se c'è da scappare si prende le falde dell'impermeabile in mano che sembra voglia aprire le ali.
- A fare il palo, Uora-uora, - disse il Dritto, muovendo le narici. Uora-uora s'allontanò mogio: sapeva che il Dritto può continuare a muovere le narici sempre più svelto, ma a un certo punto smette e tira fuori la rivoltella.
- Lì, - disse il Dritto a Gesubambino. C'era una finestrella alta da terra, con un cartone al posto del vetro sinistrato.
- Tu monti, entri e mi apri, - disse. - Bada a non accendere le luci che di fuori si vede. Gesubambino si tirò su come una scimmia per il muro liscio, sfondò il cartone senza rumore e mise la testa dentro. Fin allora non s'era accorto dell'odore: respirò e gli salì alle narici una nuvola di quel profumo caratteristico dei dolci. Più che un senso d'ingordigia provò una trepida commozione, un senso di remota tenerezza.
«Ci devono essere dei dolci, qua dentro», pensò. Erano anni che non mangiava un po' di dolci come si deve, forse da prima della guerra. Avrebbe frugato dappertutto finché non avesse trovato i dolci; sicuro. Si calò giù, nel buio; diede un calcio a un telefono, una scopa gli s'infilò nei pantaloni, poi fu a terra. L'odore di dolci era sempre più forte ma non si capiva da che parte venisse.
«Ci devono essere molti dolci, qui» pensò Gesubambino.
Allungò una mano, cercando d'ambientarsi nel buio per raggiungere la porticina e aprire al Dritto. Subito ritirò la mano, con schifo: ci doveva essere una bestia davanti a lui, una bestia marina, forse, molle e vischiosa. Rimase con la mano in aria, una mano diventata appiccicaticcia, umida, come coperta di lebbra. Tra le dita sentì che gli era spuntato un corpo tondo, un'escrescenza, forse un bubbone. Sbarrava gli occhi nel buio ma non vedeva nulla, nemmeno a mettere la mano sotto il naso. Non vedeva nulla ma odorava: allora rise. Capì che aveva toccato una torta e sulla mano aveva crema e una ciliegia candita.
Cominciò a leccarsi la mano, subito, e con l'altra continuava a brancolare intorno. Toccò un qualcosa di solido ma soffice, con un velo granuloso in superficie: un crafen! Sempre brancolando, se lo ficcò in bocca intero. Diede un piccolo grido di sorpresa, scoprendo che aveva la marmellata dentro. Era un posto bellissimo: in qualsiasi direzione s'allungasse la mano, nel buio, si trovavano nuove specie di dolciumi.
Si sentì bussare a una porta, poco distante, con impazienza: era il Dritto che aspettava gli si aprisse. Gesubambino si diresse verso il rumore e le sue mani urtarono prima in meringhe, poi in croccanti. Aprì. La lampadina tascabile del Dritto gli illuminò la faccia coi baffetti già bianchi di crema.
- C'è pieno di dolci, qui! - disse Gesubambino come se l'altro non lo sapesse.
- Non è tempo di dolci, - fece il Dritto, scansandolo, - non c'è tempo da perdere -. E andò avanti rimestando nel buio col bastone di luce della lampadina. E in ogni punto che illuminava scopriva file di scaffali e sopra gli scaffali file di vassoi e sopra i vassoi file di paste allineate di tutte le forme e di tutti i colori e torte cariche di creme che stillavano come cera da candele accese, e batterie schierate di panettoni e muniti castelli di torroni.
Allora uno sgomento terribile s'impadronì di Gesubambino: lo sgomento di non avere il tempo di saziarsi, di dover scappare prima d'aver assaggiato tutte le qualità di dolci, d'avere sottomano tutta quella cuccagna solo per pochi minuti in vita sua. E più dolci scopriva più il suo sgomento aumentava, e ogni nuovo andito, ogni nuova prospettiva del negozio che appariva illuminata dalla pila del Dritto, gli si parava dinanzi come per chiudergli ogni strada.
Si buttò sugli scaffali ingozzandosi di paste, cacciandone in bocca due, tre per volta, senza nemmeno sentirne il sapore, sembrava lottasse con i dolci, minacciosi nemici, strani mostri che lo stringevano d'assedio, un assedio croccante e sciropposo in cui doveva aprirsi il varco a forza di mandibole. I panettoni mezzo tagliati aprivano fauci gialle e occhiute contro di lui, strane ciambelle sbocciavano come fiori di piante carnivore; Gesubambino ebbe per un momento la sensazione che sarebbe stato lui a esser divorato dai dolci.
Il Dritto lo tirava per un braccio.
- La cassa, - disse, - dobbiamo prendere la cassa. Ma intanto, passando, si ficcò in bocca un pezzo di pandispagna multicolore, e poi la ciliegina d'una torta, e poi una "brioche", sempre con fretta, cercando di non distrarsi dal suo compito. Aveva spento la pila.
- Di fuori ci vedono come vogliono, - disse.
Erano arrivati nel locale della pasticceria, con le bacheche di vetro e i tavolini di marmo. C'era la luce notturna della strada, perché le saracinesche erano a griglia e fuori si vedevano le case e gli alberi, con uno strano gioco d'ombre.
Ora bisognava forzare la cassa.
- Tieni qua, - disse il Dritto a Gesubambino dandogli la pila da reggere verso il basso perché non si vedesse da fuori.
Ma Gesubambino con una mano teneva la pila e con l'altra annaspava intorno. Afferrò un plum-cake intero e mentre il Dritto s'affannava coi suoi ferri alla serratura, cominciò a morsicarlo come fosse pane. Se ne stufò presto e lo lasciò sul marmo mezzo mangiato.
- Leva di lì! Guarda che porcaio fai! - gli gridò a denti stretti il Dritto, che malgrado il suo mestiere aveva uno strano amore per il lavoro ordinato. Poi non resistette alla tentazione e si mise due biscotti in bocca, di quelli mezzo savoiardi mezzo di cioccolato, sempre senza smettere di lavorare.
Ma Gesubambino, per avere le mani libere, aveva costruito una specie di paralume con pezzi di torrone e tovagliette da vassoio. Aveva visto certe torte con la scritta "buon onomastico". Ci si aggirò intorno, studiando il piano d'attacco: prima le passò in rassegna con il dito e leccò un po' di crema al cioccolato, poi ci affondò la faccia dentro cominciando a morderle dal centro una per una.
Ma gli restava una smania che non sapeva come soddisfare, non riusciva a trovare il modo per goderle del tutto. Ora era carponi sul tavolo, con le torte sotto di sé: gli sarebbe piaciuto spogliarsi e coricarsi nudo sopra quelle torte, rivoltarcisi sopra, non doversene staccare mai. Di lì a cinque, dieci minuti, invece, tutto sarebbe finito: per tutta la vita le pasticcerie sarebbero tornate proibite per lui, come quando da bambino schiacciava il naso contro le vetrine. Almeno ci si potesse fermare tre, quattro ore...
- Dritto! - fece. - Se ce ne stiamo qui nascosti fino all'alba, chi ci vede?
- Non fare lo scemo, - disse il Dritto che era riuscito a forzare il cassetto e stava frugando tra i biglietti. - Qui bisogna portare via i piedi prima che arrivi la Celere.
Proprio in quel momento si sentì picchiare alla vetrina. Nella mezzaluna si vide Uora-uora che bussava attraverso la griglia della saracinesca e faceva gesti. I due nella bottega ebbero un balzo ma Uora-uora faceva segno di star calmi, e a Gesubambino di venire al suo posto, che lui sarebbe venuto lì. Gli altri gli mostrarono i pugni e i denti, e fecero segno di togliersi da davanti al negozio, se non gli dava di volta il cervello.
Intanto il Dritto aveva scoperto che in cassa c'erano solo poche migliaia di lire e sacramentava, e se la pigliava con Gesubambino che non lo voleva aiutare. Gesubambino sembrava fuori di sé: addentava strudel, piluccava zibibbi, leccava sciroppi, imbrattandosi e lasciando rimasugli sui vetri delle bacheche. Aveva scoperto che non aveva più voglia di dolci, anzi sentiva la nausea salirgli su per le volute dello stomaco, ma non voleva cedere, non poteva arrendersi ancora. E i crafen diventarono pezzi di spugna, le omelette rotoli di carta moschicida, le torte colarono vischio e bitume. Egli vedeva solo cadaveri di dolci, che putrefacevano stesi sui bianchi loro sudari, o che si disfacevano in torbida colla dentro il suo stomaco.
Il Dritto prese a imbestialirsi contro la serratura d'un altro cassetto, dimentico ormai dei dolci e della fame. Fu allora che dal retrobottega entrò Uora-uora bestemmiando in siciliano che nessuno lo capiva.
- La Celere? - chiesero gli altri due, già pallidi.
- Il cambio! Il cambio! - gemeva Uora-uora nel suo dialetto, e s'affaticava a spiegare a furia di parole in "u" l'ingiustizia di lui digiuno nel freddo mentre loro s'ingozzavano di dolci.
- Va' a fare il palo! Va' a fare il palo! - gli gridava Gesubambino con rabbia; la rabbia d'essere già sazio che lo faceva ancor più egoista e cattivo.
Il Dritto capiva che dare il cambio a Uora-uora sarebbe stato più che giusto, ma capiva anche che Gesubambino non si sarebbe lasciato convincere così facilmente, e senza palo non si poteva restare. Perciò tirò fuori la rivoltella e la puntò su Uora-uora.
- Subito al tuo posto, Uora-uora, - disse.
Disperato, Uora-uora pensò di far la sua provvista prima d'andarsene, e si radunò un mucchietto d'amaretti coi pinoli nelle grandi mani.
- E se ti pescano coi dolci in mano, scemo, cosa gli racconti, - inveì ancora il Dritto. - Lascia lì tutto e fila.
Uora-uora piangeva. Gesubambino sentì d'odiarlo. Sollevò una torta col «buon compleanno» e gliela tirò in faccia. Uora-uora avrebbe potuto benissimo schivarla, invece sporse la faccia in avanti per pigliarla in pieno, poi rise, con la faccia, il cappello, la cravatta impiastricciati di torta, e scappò via dandosi linguate fin sul naso e sugli zigomi.
Alla fine il Dritto era riuscito a forzare il cassetto buono e stava intascando banconote, imprecando perché gli si appiccicavano alle dita sporche di marmellata.
- Dài, Gesubambino, è ora d'andarcene, - disse.
Ma per Gesubambino tutto non poteva finire così: quella doveva essere una mangiata da raccontare per anni ai compagni e a Mary la Toscana. Mary la Toscana era l'amante di Gesubambino: aveva delle gambe lunghe e lisce e un corpo e un viso quasi equini. Gesubambino le piaceva perché si raggomitolava e s'arrampicava sul suo corpo come un grosso gatto.
La seconda entrata di Uora-uora interruppe il corso di questi pensieri. Il Dritto tirò fuori la rivoltella, subito, ma Uora-uora disse: - La Celere! - e scappò di corsa, svolazzando con le falde dell'impermeabile in mano. Il Dritto, raccolti gli ultimi biglietti, fu in due salti alla porta; e Gesubambino dietro.
Gesubambino stava pensando a Mary: solo allora s'era ricordato che poteva portarle delle paste, che non le faceva mai regali, che forse lei ci avrebbe fatto su una scena. Tornò indietro, arraffò dei cannoli, se lì ficcò sotto la camicia, poi rapidamente pensò che aveva scelto le paste più fragili, ne cercò delle più solide e se ne infarcì il seno. In quella vide le ombre dei poliziotti sulla vetrina che s'agitavano e indicavano qualcuno in fondo alla via; e uno puntò un'arma in quella direzione e sparò.
Gesubambino s'acquattò dietro a un banco. Non dovevano aver colpito il bersaglio: ora facevano gesti di dispetto e guardavano dentro. Poco dopo sentì che avevano scoperto la porticina aperta, e che entravano. La bottega fu piena di poliziotti armati. Gesubambino stava aggomitolato, ma intanto, scoperta della frutta candita a portata delle sue braccia, per tenersi calmo s'ingozzava di cedri e bergamotti.
Quelli della Celere constatavano il furto e le tracce della mangiata sugli scaffali. E così, distrattamente, cominciarono a portarsi alla bocca qualche pasticcino rimasto sbandato, badando bene a non confondere le tracce. Dopo qualche minuto, infervorati alla ricerca dei corpi del reato, erano tutti lì che mangiavano a quattro palmenti.
Gesubambino masticava, ma gli altri masticavano più forte di lui e coprivano il rumore. E sentiva un denso liquefarsi tra pelle e camicia, e la nausea salirgli per lo stomaco. S'era tanto stordito a furia di canditi che tardò un po' ad accorgersi che la via della porta era libera. Quelli della Celere dissero poi d'aver visto una scimmia col muso impiastricciato, che traversava a salti la bottega, rovesciando vassoi e torte. E prima che si fossero riavuti dallo stupore e spiccicate le torte di sotto i piedi lui s'era già messo in salvo.
Da Mary la Toscana quando aprì la camicia si trovò col petto ricoperto da uno strano impasto. E rimasero fino al mattino, lui e lei, sdraiati sul letto a leccarsi e piluccarsi fino all'ultima briciola e all'ultimo rimasuglio di crema.
Dopo cena Emanuele giocava con l'ammazzamosche contro i vetri. Aveva trentadue anni ed era grasso. Sua moglie Jolanda si cambiava le calze per andare a passeggio.
Fuori dai vetri c'era lo spiazzo sinistrato dell'antico Deposito Franco che apriva la vista del mare tra le case in discesa: il mare diventava nero e un vento teso saliva per le vie: sei marinai del cacciatorpediniere americano Shenandoah ancorato fuori del porto erano entrati nel bar «La botte di Diogene».
- Sei americani da Felice, - disse Emanuele.
- Ufficiali? - chiese Jolanda.
- Marinai. Meglio. Spicciati -. Aveva alzato il cappello e girava su se stesso cercando d'indovinare la manica della giacca.
Jolanda aveva finito con quella giarrettiera e adesso si nascondeva i nastri del reggipetto che sporgevano davanti.
- Pronti. Andiamo.
Trafficavano in dollari, perciò volevano chiedere a quei marinai se avevano da venderne. Gente rispettabile, però, anche se trafficavano in dollari.
Sullo spiazzo sinistrato qualche palma piantata lì per rallegrare l'ambiente si spettinava al vento come inconsolabilmente disperata. E in mezzo, tutto illuminato, c'era il padiglione «La botte di Diogene» messo su dal reduce Felice per concessione del Comune, sebbene i consiglieri d'opposizione protestassero che rovinava il paesaggio. Era a forma di botte, con dentro bar e tavolini.
Emanuele disse: - Dunque, prima vai tu, vedi, attacchi discorso, e chiedi se vogliono cambiare. Con te è più facile accettino subito. Poi arrivo io e si contratta.
Da Felice i sei occupavano il banco del bar da una parte all'altra, con tutti quei pantaloni bianchi e quei gomiti appoggiati al marmo che sembrava fossero in dodici. Jolanda si fece sotto e si vide addosso dodici occhi ruotanti al tempo delle bocche che masticavano e mugolavano chiuse. Per lo più erano spilungoni malcresciuti, insaccati in quei camicioni bianchi e con quei cappellini sul cocuzzolo, ma uno ce n'era vicino a lei, alto due metri, con le guance di mela e un collo a piramide, che stava in quella divisa come fosse nudo, e aveva due occhi tondi in cui le pupille giravano su e giù senza incontrare mai gli orli. Jolanda si nascose un nastro del reggipetto che le saltava sempre fuori sul davanti.
Di là dal banco, Felice, con il berrettone da cuoco e gli occhi gonfi di sonno, riempiva bicchieri a tutt'andare. Le fece un sogghigno di saluto con quella sua faccia da ciabattino sempre nerastra di barba rasa. Parlava inglese, Felice, e Jolanda disse: - Felice, di' un po' se vogliono cambiare dei dollari.
Felice era sempre sogghignante ed evasivo: - Diglielo tu, - disse. E faceva portar avanti nuovi vassoi di pizze e di frittelle a un ragazzino coi capelli incatramati e la faccia color cipolla.
Jolanda aveva tutt'intorno questi spilungoni bianchi che la guardavano masticando e scambiandosi mugolii disumani.
- Please... - disse, facendo tutti i gesti, - io, a voi, lire... Voi, a me, dollari.
Quelli masticavano. Il grande dal collo di toro sorrise: aveva dei denti bianchissimi, così bianchi che non se ne vedeva gli intervalli.
Si fece largo uno basso, scuro in faccia come uno spagnolo: - Io, dollari, a te, - fece, sempre con tutti i gesti, - te, a letto con me.
Poi ripeté tutto in inglese e gli altri risero a lungo, ma sempre con discrezione, senza smettere di masticare e di tenerle gli occhi fissi addosso.
Jolanda si voltò verso Felice. - Felice, - disse, spiegagli.
-Whisky and soda, - diceva Felice con una pronuncia inverosimile, facendo ruotare i bicchieri sul marmo: il suo sogghigno sarebbe stato odioso se non fosse stato così pieno di sonno.
Allora il gigante parlò: aveva la voce della boa di ferro, quando le ondate fanno sobbalzare l'anello. Ordinò da bere per Jolanda. Prese il bicchiere di mano a Felice e lo porse a Jolanda: non si capiva come il gambo di vetro sottile non si spezzasse tra quelle dita così grandi.
Jolanda non sapeva cosa fare. - Io lire, voi dollari... - ripeteva.
Ma quelli avevano già imparato l'italiano: - A letto, - dicevano. - A letto dollari...
In quella entrò il marito e vide quel cerchio di schiene inquiete e la voce di sua moglie che veniva da dentro. Si fece al banco: - Ehi, Felice, dimmi un po', - fece.
- Cosa ti posso offrire? - disse Felice col suo stanco sogghigno tra la barba rasa due ore prima che cominciava a rispuntargli.
Emanuele si scollò il cappello dalla fronte sudata e faceva piccoli salti per vedere dietro quel muro di schiene: - Mia moglie, cosa fa?
Felice s'arrampicò su uno sgabello, sporse il mento e saltò giù: - È sempre lì, - disse.
Emanuele ammainò un po' il nodo della cravatta per respirare meglio: - Digli che si levi, - disse. Ma Felice era già occupato a sgridare il ragazzino color cipolla perché lasciava i vassoi senza frittelle.
- Jolanda...? - chiamava il marito, e provò a intrufolarsi tra due americani; si prese una gomitata al mento e una allo stomaco e fu di nuovo fuori a saltellare intorno al crocchio. Una voce un po' tremula gli rispose, dal folto: - Emanuele...?
Lui si schiarì la voce: - Come va...?
- Pare, - disse la voce di lei, come parlasse per telefono, - pare che non vogliano lire...
Lui si teneva calmo; tamburellò sul marmo. - Ah no...? - disse. - Allora vieni via.
- Subito... - lei disse. E tentò una nuotatina in mezzo a quella siepe d'uomini. Ma c'era qualcosa che la tratteneva: abbassò lo sguardo e vide una grande mano posata sotto il suo seno sinistro, una grande mano forte e soffice. E il gigante dalle gote di mela era davanti a lei con i denti che scintillavano come il bulbo degli occhi.
- Please... - disse lei, piano, cercando di spiccicare quella mano, e a Emanuele gridò: - Ora vengo. - Invece restava lì in mezzo. - Please, - ripeteva, - please...
Felice posò un bicchiere sotto il naso di Emanuele. - Cosa ti posso servire? - chiese chinando il capo col berrettone da cuoco e appoggiandosi sul banco con le dieci dita aperte.
Emanuele guardava nel vuoto. - Un'idea. Aspetta, - e uscì.
Fuori eran già accese le lampade. Emanuele traversò la via di corsa, entrò nel Caffè Lamarmora, girò lo sguardo intorno. Non c'erano che i soliti che facevano il tressette. - Vieni a fare la partita, Manuele! - dissero. - Che faccia hai, Manuele! Lui era già corso via. Si fece tutta una tirata fino al bar Parigi. Girò tra i tavoli, si batteva il pugno contro il palmo. Finì per chiedere in un orecchio al barista. Quello disse: - Non c'è ancora. Stasera -. Lui scappò. Il barista scoppiò a ridere e andò a raccontarlo alla cassiera.
Al Giglio la Bolognese aveva appena disteso le gambe sotto il tavolino, perché le varicose cominciavano a dolerle, quando arrivò il grassone col cappello sulla nuca, trafelato che non si capiva cosa volesse.
- Vieni, - diceva e la tirava per la mano, - vieni presto che è urgente.
- Manuelino? Cosa ti piglia? - diceva la Bolognese, sgranando gli occhi zigrinati di rughe sotto la frangetta nera. - Dopo tanti anni... Cosa ti piglia, Manuelino?
Ma lui correva già con lei per mano che gli arrancava dietro, le gonfie gambe impastoiate nella sottana attillata a mezza coscia.
Davanti al cinema incontrò Maria la Matta che corrompeva un caporale.
- Alé. Vieni anche tu. Ti porto dagli americani.
Maria la Matta non se lo fece dire due volte, piantò il caporale con un buffetto e prese a correre a fianco a lui, coi capelli rossi stopposi al vento e gli occhi che squarciavano il buio dal languore.
Nella «Botte di Diogene» la situazione era cambiata di poco. Sulla scansia di Felice c'erano parecchi vuoti, il gin se n'era già andato tutto e le pizze stavano per finire. Le due donne piombarono lì con Emanuele che le spingeva per la schiena e i marinai se le videro schizzare di forza in mezzo a loro e le salutarono con grida. Emanuele si appollaiò su uno sgabello, spossato. Felice gli versò qualcosa di forte. Un marinaio si staccò dal gruppo e venne a battere una mano sulla schiena di Emanuele. Anche gli altri lo guardavano con amicizia. Felice stava dicendo loro qualcosa su di lui.
- Eh? - chiese Emanuele. - Come ti sembra che vada?
Felice aveva quel suo eterno sogghigno assonnato: - Mah! Ce ne vorrebbero almeno sei...
La situazione non migliorava, infatti. Maria la Matta era finita in collo a uno spilungone con la faccia da feto e si contorceva tutta nella vestina verde come un serpente che vuol cambiar di pelle; la Bolognese aveva sommerso col suo seno il basso spagnolo e lo coccolava tutta materna. Jolanda intanto non spuntava. Aveva sempre quell'enorme schiena davanti che impediva la vista. Emanuele faceva dei segni nervosi alle due, che non si perdessero in stupidaggini, che si dessero d'attorno; ma quelle sembrava avessero dimenticato tutto.
- Ohi... - fece Felice smicciando sopra le spalle d'Emanuele.
- Cosa? - disse lui, ma il barista stava già sgridando il ragazzo che non era svelto ad asciugare i bicchieri. Emanuele si voltò e vide i nuovi che arrivavano. Saranno stati in quindici. «La Botte di Diogene» fu subito piena di marinai già tutti brilli; Maria la Matta e la Bolognese si dispersero in mezzo a quel cancan: una saltava dal collo dell'uno a quello dell'altro roteando per aria quelle sue gambe di scimmia, l'altra con l'inverosimile sorriso fissato dal rossetto raccoglieva gli smarriti sotto il suo petto di chioccia.
Emanuele vide un momento Jolanda turbinare in mezzo a loro, poi risparire. A Jolanda sembrava ogni tanto di venir travolta da quella folla intorno a lei, ma ogni volta s'accorgeva che vicino aveva quel marinaio gigantesco coi denti e il bulbo degli occhi così bianchi, e ogni volta sentiva, non sapeva perché, di trovarsi sicura. Quell'uomo si muoveva soffice sempre vicino a lei: nella sua immobile divisa bianca il suo grande corpo doveva spostarsi sui muscoli striscianti come gatti; il suo petto s'alzava e s'abbassava lentamente, come pieno della grande aria del mare. A un certo punto quella sua voce di pietre in fondo a una boa cominciò a dire parole distanziate con un insolito ritmo e ne nacque un gran canto, e tutti giravano su se stessi come ci fosse la musica.
Intanto Maria la Matta che conosceva tutti i posti, d'in braccio a uno coi baffi, stava aprendosi la via a calci verso una porticina del retrobottega. Felice da principio non voleva che aprissero, ma dietro c'era tutta la fiumana che spingeva, e strariparono dentro.
Emanuele, rincantucciato in cima al suo sgabello, seguiva la scena con occhi acquatici. - Che c'è dì là, Felice? Che c'è di là? - Ma Felice non rispondeva, era in pensiero perché non c'era più né da bere né da mangiare.
- Va' fin dal Valchiria e di' che ci prestino qualcosa da bere, - disse al ragazzino-cipolla; - qualsiasi cosa, anche birra. E paste. Di corsa!
Jolanda intanto era stata spinta oltre la porticina. C'era una cameretta, pulita e con le tendine, e nella cameretta c'era un lettino, tutto in ordine, con un copriletto azzurro, e il lavabo e tutto il resto. Allora il gigante prese a cacciare gli altri fuori dalla stanzetta, con calma e fermezza, a spinte delle sue grandi mani e lasciava Jolanda dietro le sue spalle. Ma i marinai chissà perché volevano tutti rimanere nella cameretta e ogni ondata che il marinaio gigantesco spingeva fuori era un'ondata che tornava dentro, ma sempre di meno, perché qualcuno si stancava e si fermava fuori. Jolanda era contenta che il gigante facesse quel lavoro perché così poteva respirare più a suo agio e nascondere i nastri del reggipetto che le saltavano sempre fuori.
Emanuele osservava, intanto: vedeva le mani del gigante spinger gente fuori della porticina, e sua moglie sparita che certo doveva esser là dentro, e gli altri marinai tornar continuamente dentro a ondate, e ogni ondata uno o due in meno: prima dieci, poi nove, poi sette. Di qui a quanti minuti il gigante sarebbe riuscito a chiudere la porta? Allora Emanuele corse fuori. Traversò la piazza come nella corsa nei sacchi. A1 posteggio c'era la fila dei tassì con gli autisti che sonnecchiavano. Lui passò dall'uno all'altro e li svegliò tutti e spiegò loro cosa dovevano fare arrabbiandosi se non capivano. A uno a uno i tassì partirono in direzioni diverse. Anche Emanuele partì su un tassì, ritto sul predellino.
Bacì, il vecchio carrozziere, a sentire quel movimento s'era svegliato dall'alto della cassetta e s'era precipitato a sentire se c'era qualche viaggio da fare. Capì subito tutto da quel vecchio lupo del mestiere che era, rimontò in carrozza e svegliò il suo antico cavallo. Quando anche la carrozza di Bacì si fu allontanata cigolando, la piazza rimase deserta e silenziosa tranne il rumore che veniva dalla «Botte di Diogene» sullo spiazzo dell'antico Deposito Franco.
All'«Iris» le ragazze stavano ballando: erano minorenni con la bocca a fiorellino e maglioni attillati che modellavano i seni a palla. Emanuele non aveva pazienza d'aspettare che finisse il ballo. - Ehi, tu! - fece a una che ballava con un garzone con la fronte mangiata dai capelli. - Cosa cerchi? - gli fece lui. Altri tre o quattro si fermarono intorno: facce da pugili che tiravano su dal naso. - Vieni via, - fece l'autista a Emanuele. - Qui succede un altro putiferio.
Andarono a casa della Pantera; ma lei non voleva aprire perché aveva un cliente. - Dollari, - gridava Emanuele. - Dollari -. Aprì, in vestaglia che sembrava una statua allegorica. La trascinarono giù per le scale e la caricarono in tassì. Poi rastrellarono la Balilla alla passeggiata a mare col cane al guinzaglio, la Belbambin al Caffè dei viaggiatori con la volpe al collo, la Beciuana all'Albergo Pace col bocchino d'avorio. Poi trovarono tre nuove arrivate con la signora del «Ninfea» che ridevano sempre e credevano si andasse in campagna. Caricarono tutte. Emanuele era seduto davanti, un po' allarmato dal baccano di tutte quelle donne schiacciate lì dentro; l'autista si preoccupava solo che non spezzassero le balestre.
A un certo punto un tale si fece in mezzo alla via che sembrava volesse andare sotto. Faceva segno di fermarsi. Era il ragazzino con la faccia a cipolla carico d'una cassetta di birre e d'un vassoio di paste che voleva esser preso a bordo. Lo sportello s'aperse e si vide il ragazzino aspirato con cassetta e tutto. La macchina ripartì. I nottambuli sbarravano gli occhi dietro quel tassì che correva come il pronto soccorso con dentro quello scatenio di versi acuti. Emanuele sentiva che qualcosa mandava un cigolio lunghissimo ogni tanto, e lo disse all'autista: - Guarda che ci dev'essere un guasto, non senti il rumore? - L'autista scosse il capo: - É il ragazzo, - disse. Emanuele s'asciugava il sudore.
Fermato il tassì davanti alla «Botte», il ragazzo schizzò fuori per primo, col vassoio alzato e la cassetta sotto l'altro braccio. Aveva i capelli dritti, gli occhi che gli prendevano metà faccia e corse via con salti da scimmia perché non gli era restato addosso neanche un bottone.
- Felice! - gridava. - Tutto in salvo! Non ho lasciato che pigliassero niente! Ma sapessi cosa m'han fatto, Felice!
Jolanda era ancora nella stanzetta e il gigante giocava ancora a spintoni sulla porticina. Ormai c'era solo uno che insisteva a voler entrare, ubriaco fradicio, e rimbalzava ogni volta sulle mani del gigante. In quella fece il suo ingresso il nuovo arrivo, e Felice, salito in piedi sullo sgabello per contemplare stancamente la scena, vedeva la distesa di berrettini bianchi aprirsi per far fiorire un cappello a piume, un sedere involto in seta nera, una gamba grassa come uno zampone, un paio di seni apparecchiati con guarnizioni di fiori, tutto che veniva a galla e spariva come bollicine d'aria.
Intanto si sentì rumor di freni e quattro cinque sei una fila intera di tassì arrivarono. E da ogni tassì uscivano donne. C'era la Millemosse, con una pettinatura signorile, che veniva avanti maestosa, strabuzzando gli occhi miopi; c'era Carmen la Spagnola, tutta avvolta in veli, la faccia scavata come un teschio, e il contorcersi felino delle anche ossute; c'era Giovannassa la Zoppa, che arrancava appoggiandosi all'ombrellino cinese; c'era la Nera di Carrugio Lungo con i capelli da negra e le gambe pelose; c'era la Topolino col vestito disegnato a marche di sigarette; c'era Milena la Sulfamidica col vestito disegnato a carte da gioco; c'era la Succhiacani con la faccia piena di foruncoli; c'era la Ines-la-Fatale con un abito tutto di pizzo.
Si sentì qualcosa rotolare sul selciato ed era la carrozza di Bacì che arrivava, col cavallo mezzo morto; si fermò e saltò fuori una donna anche di lì. Aveva un'ampia sottana di velluto guernita di gale e di trine, un petto inghirlandato di collane, un fettuccino nero al collo, orecchini pendenti ed istoriati, l'occhialino con il manico, i capelli d'un giallo-parrucca, e un grande cappello alla moschettiera su cui c'erano rose e uva e uccelli e una nuvola di piume di struzzo.
Al padiglione della «Botte di Diogene» erano accorse altre schiere di marinai. Uno suonava la fisarmonica e uno il sassofono. Sui tavoli c'erano donne che facevano danze. Per quanto si fosse fatto c'erano sempre molti più marinai che donne, pure ognuno che allungasse una mano incontrava una natica o una mammella o una coscia che sembravano smarrite e non si vedeva di chi fossero: natiche a mezz'aria e mammelle all'altezza dei ginocchi. E mani vellutate e artigliate strisciavano in mezzo a quella calca, mani dalle rosse unghie aguzze e dai vibranti polpastrelli, che s'intrufolavano sotto le casacche, sbottonavano asole, carezzavano muscoli, solleticavano anditi. E bocche s'incontravano quasi volanti nell'aria che s'appiccicavano sotto gli orecchi come ventose e lingue dolciastre e ruvide che insalivano la pelle corrodendola, e labbra enormi con le gobbe di carminio che arrivavano fin nelle narici. E gambe si sentivano scorrere dappertutto interminabili e innumerevoli come i tentacoli d'un enorme polipo, gambe che s'intrufolavano tra le gambe e si dibisciavano con colpi di coscia e di polpaccio. E poi parve che tutto stesse dissolvendosi nelle loro mani, e chi si trovava in mano un cappello guernito di grappoli d'uva, chi un paio di mutandine coi pizzi, chi una dentiera, chi una calza avvoltolata al collo, chi una gala di seta.
Jolanda era rimasta sola nella cameretta con il marinaio gigantesco. La porta era chiusa a chiave e lei si pettinava davanti allo specchio del lavabo. Il gigante andò alla finestra e scostò la tendina. Fuori si vedeva il quartiere buio della marina e il molo con la fila dei lampioni che si ripetevano nell'acqua. Allora il gigante cominciò una canzone americana che diceva: - Il giorno è finito, cade la notte, i cieli sono azzurri, le campane cominciano a suonare.
E Jolanda s'avvicinò anche lei a guardare fuori dai vetri e le loro mani s'incontrarono sul davanzale e stettero ferme vicine. E il grande marinaio dalla voce di ferro cantava: - Progenie di Dio, cantiamo alleluja.
E Jolanda ripeteva: - Cantiamo alleluja, alleluja.
Intanto Emanuele girava angosciosamente tra i marinai senza trovare la moglie, scansando corpi di donne trasfigurate che ogni tanto gli piovevano tra le braccia. A un certo punto si trovò di fronte il gruppo degli autisti che lo stavano cercando per farsi pagare da lui il conto dei loro tassametri. Emanuele aveva gli occhi pieni di lacrime; quelli non volevano lasciarlo andare se non pagava. Li aveva raggiunti anche il vecchio Bacì, mulinando la sua grande frusta di cocchiere. - Se non mi pagate me la riporto via! - diceva.
Poi si udirono i fischi e il padiglione era circondato dalla polizia. C'era la ronda del cacciatorpediniere Shenandoah con gli elmi e i fucili che faceva uscire i marinai a uno a uno. Intanto s'erano fermate le camionette della polizia italiana e tutte le donne che acchiappavano le caricavano e via.
I marinai furono messi in fila e fatti marciare verso il porto. Davanti a loro passarono le camionette della polizia cariche di donne e ci fu un gran sbracciarsi di saluti da una parte e dall'altra. Il gigante ch'era in testa attaccò a voce spiegata: - Il giorno è passato, il sole discende, cantiamo alleluja alleluja.
Jolanda, rannicchiata in una camionetta tra la Millemosse e la Succhiacani, sentì la sua voce correndo via e riprese il canto: - Il giorno è andato, il lavoro è compiuto, alleluja.
E tutti cantarono quella canzone, i marinai e le donne, gli uni andando verso l'imbarco, le altre verso la questura.
Alla «Botte di Diogene» il reduce Felice cominciava ad accatastare i tavolini. Emanuele era rimasto abbandonato su una seggiola col mento sul petto e il cappello informe sulla nuca. Stavano per arrestare anche lui, ma l'ufficiale della marina americana che comandava l'operazione aveva chiesto intorno e aveva fatto segno di lasciarlo stare. E anche lui, l'ufficiale, era restato, e ora nel locale non c'erano che loro due: Emanuele desolato su quella seggiola e l'ufficiale davanti a lui in piedi a braccia conserte. Quando fu sicuro d'esser solo, l'ufficiale scosse il grassone per un braccio e cominciò a parlargli. Felice s'avvicinò per far l'interprete, sogghignando nella sua nerastra faccia ciabattina.
- Dice se gli puoi procurare una ragazza anche a lui, - fece ad Emanuele.
Emanuele sbatté un po' gli occhi, poi ricascò col mento sul petto.
- Voi, a me, ragazza, - diceva l'ufficiale; - io, a voi, dollari.
- Dollari -. Emanuele si rinfrescava le guance a colpi di fazzoletto. S'alzò.
- Dollari, - ripeteva. - Dollari.
Uscirono insieme. Nel cielo volavano nuvole notturne. Il faro in cima al molo continuava i suoi ammicchi misurati. L'aria era ancora piena di quella canzone Alleluja.
- Il giorno finisce, sono azzurri i cieli, alleluja, - cantavano il grassone e l'ufficiale camminando in mezzo alle vie a braccetto in cerca di un locale dove far baldoria tutta la notte.
Nello scompartimento, accanto al fante Tomagra, venne a sedersi una signora alta e formosa. Una vedova provinciale, doveva essere, a giudicare dal vestito e dal velo: il vestito era di seta nera, appropriato a un lungo lutto, ma con guarnizioni e gale inutili, e il velo le passava intorno al viso piovendole dal giro d'un pesante antiquato cappello. Altri posti erano liberi, notò il fante Tomagra, nello scompartimento; e pensava che la vedova avrebbe certo scelto uno di quelli; invece, nonostante la ruvida vicinanza di lui soldato, ella venne a sedersi proprio lì, certo per via di qualche comodità del viaggiare, s'affrettò a pensare il fante, correnti d'aria o direzione della corsa.
Per la floridezza del corpo, sodo, anzi un po' quadro, se le alte curve non ne fossero state addolcite da una matronale morbidezza, le si sarebbero dati poco più di trent'anni; ma a guardarla in viso, l'incarnato marmoreo e rilassato insieme, lo sguardo irraggiungibile sotto palpebre gravi e sopracciglia nere intense, e pure le labbra severamente suggellate, tinte di sfuggita d'un rosso urtante avevano l'aria d'averne invece oltre i quaranta.
Tomagra, giovane soldato di fanteria alla prima licenza (era Pasqua), si rimpicciolì sul sedile per timore che la signora, così formosa e grande, non ci entrasse; e subito si trovò nell'ala del profumo di lei, un profumo noto e forse andante, ma ormai, per la lunga consuetudine, amalgamato ai naturali odori umani.
La signora s'era seduta con compostezza, rivelando, lì accanto a lui, proporzioni meno maestose di quanto gli eran sembrate vedendola in piedi. Teneva le mani, grasse e con stretti anelli scuri, incrociate sul grembo, sopra una borsetta lucida e una giacca che s'era tolta scoprendo tonde e chiare braccia. Tomagra, al gesto, s'era scansato come per far posto a un ampio sbracciarsi, ma lei era rimasta quasi immobile, sfilandosi le maniche con brevi movimenti delle spalle e del torso.
Il sedile ferroviario era dunque abbastanza comodo per due, e Tomagra poteva sentire l'estrema vicinanza della signora pur senza il timore d'offenderla col suo contatto. Ma, ragionò Tomagra, di certo lei, seppur signora, non aveva dimostrato d'avere ripugnanza per lui, per l'ispido della sua divisa, se no si sarebbe seduta più lontano. E, a questi pensieri, i suoi muscoli che erano rimasti contratti e rincagnati, si distesero liberi e sereni; anzi, senza che lui si muovesse cercarono d'espandersi nella loro maggiore ampiezza, e la gamba che prima se ne stava a tendini tesi, staccata perfino dalla stoffa del pantalone, si dispose più larga, tese a sua volta il panno che la vestiva, e il panno sfiorò la nera seta della vedova, ed ecco attraverso questo panno e questa seta la gamba del soldato aderiva ormai a quella di lei con un movimento morbido e fuggevole, come un incontro di squali, e con un muoversi d'onde per le sue vene verso quelle vene altrui.
Era pur sempre un contatto lievissimo, che ogni battito del treno bastava a ricreare e a perdere; la signora aveva ginocchia forti e grasse e le ossa di Tomagra ne indovinavano a ogni scossa il balzo pigro della rotula; e il polpaccio aveva una serica guancia rilevata che bisognava con impercettibile spinta far combaciare con la propria. Quest'incontro di polpacci era prezioso, ma costava una perdita: difatti il peso del corpo era spostato e il vicendevole appoggio delle anche non avveniva più col docile abbandono di prima. Occorse, per raggiungere una posizione naturale e soddisfatta, spostarsi leggermente sul sedile, con l'aiuto d'una svolta dei binari, e anche del comprensibile bisogno di muoversi ogni tanto.
La signora era impassibile, sotto il matronale cappello, il fisso sguardo palpebrato, e mani ferme sulla borsetta in grembo: pure il suo corpo, per una lunghissima striscia, appoggiava a quella striscia d'uomo: che non se ne fosse accorta ancora? oppure che preparasse una fuga? o una rivolta?
Tomagra decise di trasmetterle, in qualche modo, un messaggio: contrasse il muscolo del polpaccio come fosse un duro quadrato pugno, e poi con questo pugno di polpaccio, come se una mano dentro volesse aprirsi, corse e bussò al polpaccio della vedova. Certo, questo fu un movimento velocissimo, appena il tempo d'un gioco di tendini: a ogni modo lei non si tirò indietro, almeno per quel che poté capire lui! perché subito Tomagra per bisogno di giustificare quel gesto segreto, aveva spostato la gamba come per sgranchirla.
Ora bisognava ricominciare da capo; quella paziente e prudentissima opera di contatto era perduta. Tomagra decise d'avere più coraggio; come per cercare qualcosa ficcò la mano in tasca, la tasca dalla parte della donna, e poi come distratto non la tirò più via. Era stato un gesto veloce, Tomagra non sapeva se l'aveva o no toccata, un gesto da nulla; pure adesso comprendeva quanto importante fosse il passo avanti fatto, e in quale rischioso gioco egli ormai fosse preso. Sul dorso della sua mano ora premeva l'anca della signora in nero; egli la sentiva gravare sopra ogni dito, ogni falange, ormai qualsiasi movimento della sua mano sarebbe stato un inaudito gesto d'intimità verso la vedova. Tomagra, trattenendo il fiato, voltò la mano nella tasca: la mise cioè con la palma dalla parte della signora, aperta su di lei, pur dentro a quella tasca. Era una posizione impossibile, con un polso contorto. Pure, oramai, tanto valeva tentare un gesto decisivo: così, con quella stravolta mano, lui azzardò un muovere di dita. Non c'erano più dubbi possibili: la vedova non poteva non essersi accorta di quel suo armeggio, e se non si ritraeva, e fingeva impassibilità e assenza, voleva dire che non respingeva i suoi approcci. A pensarci, però, quel suo non far caso alla mobile mano di Tomagra poteva voler dire che veramente credesse ad una vana ricerca in quella tasca: d'un biglietto ferroviario, d'un fiammifero... Ecco: e se ora i polpastrelli del soldato, come dotati d'una improvvisa chiaroveggenza, indovinavano d'attraverso quelle diverse stoffe gli orli d'indumenti sotterranei e perfino minutissime asperità della pelle, pori e nei, se, dico, i polpastrelli di lui arrivavano a questo, forse la carne di lei, marmorea e pigra, avvertiva appena che proprio di polpastrelli si trattava e non, mettiamo, di dorsi d'unghia o nocche.
Allora la mano con passi furtivi uscì dalla tasca, si fermò lì indecisa, poi con improvvisa fretta di rassettare il pantalone sulla cucitura della costa camminò via via fino al ginocchio. Sarebbe più giusto dire che s'aprì un varco: perché dovette per procedere intrufolarsi tra lui e la donna, e fu un percorso, pur nella sua velocità, ricco d'ansie e di dolci commozioni.
Bisogna dire che Tomagra s'era messo a capo riverso contro il sostegno, così che si sarebbe anche potuto dire che dormisse: era questo, più che un alibi per sé, un offrire alla signora, nel caso che le sue insistenze non la indisponessero, il modo di non sentirsene in disagio, sapendoli gesti separati dalla coscienza, affioranti appena da uno stagno di sonno. E di lì, da questa vigile parvenza di sonno, la mano di Tomagra stretta al ginocchio staccò un dito, il mignolo, e lo mandò a esplorare in giro. Il mignolo strisciò sul ginocchio di lei che se ne stette zitto e docile; Tomagra poteva compiere diligenti evoluzioni di mignolo sulla seta della calza ch'egli con gli occhi semichiusi intravedeva appena chiara e arcuata. Ma s'accorse che l'azzardo di questo gioco era senza compenso, perché il mignolo, per povertà di polpa e impaccio di movimenti, trasmetteva solo parziali accenni di sensazioni, non serviva a concepire la forma e la sostanza di quello che toccava.
Allora riattaccò il mignolo al resto della mano, non ritirandolo ma addossando ad esso l'anulare, il medio, l'indice: ecco che la sua mano posava inerte su quel ginocchio di donna e il treno la cullava in una carezza ondosa.
Fu allora che Tomagra pensò agli altri: se la signora, per condiscendenza o per una misteriosa intangibilità, non reagiva ai suoi ardimenti, c'erano però sedute dirimpetto altre persone che potevano far scandalo di quel suo comportarsi non da soldato, e di quella possibile omertà da parte della donna. Soprattutto per salvare la signora da quel sospetto Tomagra ritirò la mano, anzi la nascose, come fosse la sola colpevole. Ma quel nasconderla, pensò poi, non era che un pretesto ipocrita: difatti, abbandonandola lì sul sedile non intendeva altro che più intimamente avvicinarla alla signora, che occupava appunto sul sedile tanto spazio.
Difatti la mano annaspò intorno, ecco già le dita avvertivano la presenza di lei come un posarsi di farfalla, ecco bastava con dolcezza spingere tutto il palmo, e impenetrabile era lo sguardo della vedova sotto la veletta, il petto appena mosso dal respiro, macché! Tomagra aveva già ritratto la mano come un correre di topo.
«Non s'è mossa, - pensava, - forse vuole», ma pensava anche: «Un attimo ancora e sarebbe troppo tardi. Forse è lì che mi studia per fare una scenata».
Allora, non per altro che per un prudente sincerarsi, Tomagra strisciò la mano di dorso sul sedile e attese che fossero le scosse del treno, insensibilmente, a far scivolare sopra le sue dita la signora. Dire che attese è improprio: infatti con la punta delle dita spingeva a cuneo tra il sedile e lei, con un movimento impercettibile, che sarebbe anche potuto essere effetto del correre del treno. Se si fermò, a un certo punto, non fu perché la signora avesse dato in qualche modo segno di disapprovare; ma perché, pensò Tomagra, se invece lei accettava, le sarebbe stato facile con un mezzo roteare di muscoli venirgli incontro, posarglisi, per così dire, su quella mano in attesa. Per dimostrarle il proposito amichevole di questa sua assiduità, Tomagra, così sotto alla signora, tentò un discreto scodinzolio di dita; la signora guardava fuori del finestrino, e con la pigra mano giocherellava, apri e chiudi, col fermaglio della borsa. Erano segni per fargli capire di desistere, era un estremo rinvio ch'ella gli concedeva, un avvertimento che la sua pazienza non poteva essere più a lungo messa a prova? Era questo? - Tomagra si chiedeva, - era questo?
S'accorse che la sua mano, come un corto polpo, stringeva la carne di lei. Ormai tutto era deciso: non poteva più tirarsi indietro, Tomagra; ma lei, lei, lei era una sfinge.
La mano del soldato ora rampava con passi sbiechi di granchio per la coscia; era allo scoperto, di fronte agli occhi altrui? No, ecco che la vedova rassettava la giacchetta che portava piegata in grembo, ecco che la faceva spiovere da un lato. Per offrirgli un riparo o per sbarrargli il varco? Ecco: ora la mano si muoveva libera e non vista, s'aggrappava a lei, si tendeva in carezze radenti come un breve propagarsi di vento. Ma il viso della vedova restava voltato in là, lontano; Tomagra fissava di lei una zona di pelle nuda, tra l'orecchio e il giro del ricolmo chignon. Ed in quell'ascella d'orecchio il pulsare d'una vena; era questa la risposta che lei gli dava, chiara, struggente e inafferrabile. Girò il viso tutt'a un tratto, fiero e marmoreo, si mosse come una tenda il velo giù dal cappello, e lo sguardo perduto tra le pesanti palpebre. Ma quello sguardo aveva sorpassato lui, Tomagra, forse non l'aveva neppur sfiorato, guardava, al di là di lui, qualcosa, o nulla, l'appiglio ad un pensiero, ma comunque sempre qualcosa più di lui importante. Questo lo pensò dopo, perché prima, appena aveva visto quel muoversi di lei, s'era gettato indietro subito e aveva stretto gli occhi come dormisse, cercando di trattenere il rossore che gli s'andava propagando in viso, e perdendo così forse l'occasione di cogliere nel primo lampo del suo sguardo una risposta ai propri estremi dubbi.
La mano, nascosta sotto la nera giacchetta, era rimasta quasi staccata da lui, rattrappita e con dita risucchiate verso il polso, non più una vera mano, ormai senza sensibilità se non quella arborea delle ossa. Ma poiché la tregua data dalla vedova alla propria impassibilità con quell'imprecisa occhiata in giro aveva presto avuto fine, nella mano rifluì sangue e coraggio. E fu allora che riprendendo contatto con quella morbida groppa di gamba egli s'accorse d'esser giunto a un limite: le dita scorrevano sull'orlo della gonna, più in là c'era lo sbalzo del ginocchio, il vuoto.
Era la fine, pensò il fante Tomagra, di questa baldoria segreta: e adesso, a ripensarci, essa appariva una ben misera cosa ai suoi ricordi, sebbene egli l'avesse avaramente ingigantita nel viverla: una goffa carezza su una veste di seta, qualcosa che non poteva in alcun modo venirgli negata, proprio per quella sua pietosa condizione di soldato, e che discretamente la signora s'era degnata, senza farne mostra, di concedergli.
Però, nell'intenzione di ritrarre, desolato, la mano, fu interrotto dall'accorgersi di come lei teneva la giacchetta sulle ginocchia: non più piegata (eppure tale prima gli era parsa), bensì gettata con trascuratezza in modo che un lembo le piovesse sul davanti delle gambe. Era in una chiusa tana, così: un'ultima prova, forse, di fiducia che la signora gli concedeva, sicura che la sproporzione tra lei e il soldato era tanta ch'egli non ne avrebbe certo profittato. E il soldato rievocava, con fatica, quello che fino allora era passato tra la vedova e lui, cercando di scoprire qualcosa nel ricordo del contegno di lei che accennasse a un condiscendere più oltre, e ripensava i propri gesti ora come d'una levità irrilevante, sfioramenti e strofinamenti casuali, ora come d'un'intimità decisiva, che lo impegnavano a non più tirarsi indietro.
La sua mano certo cedette a quest'ultimo modo del ricordo, perché, prima ch'egli avesse ben riflettuto sull'irreparabilità dell'atto, ecco che già superava il valico. E la signora? Dormiva. Aveva abbandonato il capo, col fastoso cappello, contro un angolo, e teneva gli occhi chiusi. Doveva lui, Tomagra, rispettare questo sonno, vero o finto che fosse, e ritirarsi? O era un espediente di donna complice, ch'egli avrebbe dovuto già conoscere, e di cui doveva in qualche modo mostrare gratitudine? Il punto dove ormai era giunto non consentiva indugi; non gli restava che avanzare. La mano del fante Tomagra era piccola e corta, e le durezze e callosità d'essa erano bene compenetrate nel muscolo così da renderla morbida e uniforme; l'osso non vi si sentiva e il muoversi era fatto più di nervi, ma con dolcezza, che di falangi. E questa piccola mano aveva movimenti continui e generali e minuscoli, per tenere la completezza del contatto viva e accesa. Ma quando finalmente un primo sommovimento passò per la morbidezza della vedova, come un trasportarsi di lontane correnti marine per segrete vie subacquee, il soldato ne fu così sorpreso che, proprio come se supponesse che la vedova non si fosse fino allora accorta di nulla, avesse dormito veramente, spaventato ritirò via la mano.
Ora egli se ne restava con le mani sulle proprie ginocchia, rattrappito sul sedile come quando lei era entrata: si comportava in un modo assurdo, lo comprese. Allora, con uno scalpicciare di tacchi, uno sgranchirsi d'anche, parve ansioso di ristabilire i contatti, ma pure quella sua prudenza era assurda, come volesse ricominciare da capo il suo pazientissimo lavoro e non fosse sicuro ormai delle profonde mete già raggiunte. Ma le aveva davvero raggiunte? Oppure era stato solo un sogno?
Una galleria piombò loro addosso. Il buio si faceva sempre più fitto e Tomagra allora, prima con gesti timidi, ogni tanto ritraendosi come fosse davvero ai primi approcci e si meravigliasse del suo ardire, poi sempre più cercando di convincersi dell'estrema confidenza cui già con quella donna era arrivato, avanzò una mano trepida come una gallinella verso il seno, grande e un po' abbandonato alla sua pesantezza, e con un affannoso brancolare cercava di spiegarle la miseria e l'insostenibile felicità del suo stato, e il suo bisogno, non d'altro, ma che lei uscisse da quel suo riserbo.
La vedova reagì infatti, ma con un improvviso gesto di schermirsi e respingerlo. Bastò a rincantucciare Tomagra nel suo angolo, torcendosi le mani. Ma era, probabilmente, un falso allarme per una luce passata nel corridoio che aveva messo la vedova in timore d'un'improvvisa fine della galleria. Forse: oppure lui aveva passato il segno, aveva commesso qualche orribile scorrettezza verso di lei, già tanto generosa? No, non poteva esserci ormai nulla di proibito, tra loro: e il gesto di lei, anzi, era un segno che tutto ciò era vero, che lei accettava, partecipava. Tomagra s'avvicinò di nuovo. Certo in queste riflessioni si era perduto molto tempo, la galleria non sarebbe durata ancora a lungo, non era prudente farsi cogliere dalla luce improvvisa, già Tomagra attendeva il primo ingrigirsi della parete, ecco: più lui aspettava, più rischioso era il tentare, certo però la galleria era lunga, lui dagli altri suoi viaggi la ricordava lunghissima, certo se subito avesse approfittato avrebbe avuto molto tempo innanzi a sé, ora era meglio attendere la fine, ma perché non finiva mai, forse questa era stata l'ultima occasione per lui, ecco si diradava l'ombra, ora finiva.
S'era alle ultime stazioni d'un percorso provinciale. Il treno si svuotava; dei passeggeri dello scompartimento i più erano scesi, ecco anche gli ultimi calavano le valige, s'avviavano. Finì che rimasero soli nello scompartimento il soldato e la vedova, vicinissimi e discosti, a braccia conserte, muti, gli sguardi nel vuoto. Tomagra ebbe ancora bisogno di pensare: «Adesso che tutti i posti sono liberi, se volesse star tranquilla e comoda, se avesse noia di me, si sposterebbe...»
Qualcosa lo tratteneva e impauriva ancora, forse nel corridoio la presenza di un gruppo di fumatori, o una luce che s'era accesa perché veniva sera. Allora pensò di tirare le tendine verso il corridoio, come fa chi vuol dormire: s'alzò con passi elefanteschi, cominciò con lenta cura meticolosa a sciogliere le tendine, a tirarle, a riallacciarle. Quando si voltò la trovò sdraiata. Come volesse dormire: ma oltre ad aver gli occhi aperti e fissi, era calata giù tenendo intatta la sua matronale compostezza, con il maestoso cappello sempre calcato sulla testa appoggiata al bracciolo.
Tomagra era in piedi sopra a lei. Volle ancora, per proteggere questo suo simulacro di sonno, far buio anche al finestrino, e si protese sopra di lei, per slacciare la tendina. Ma non era che un modo di muovere i suoi goffi gesti sopra la vedova impassibile. Allora smise di tormentare quell'asola di tendina e capì che doveva far altro, dimostrarle tutta la propria improrogabile condizione di desiderio, non fosse che per spiegarle l'equivoco in cui lei era certo caduta, come a dirle: "Vede, lei è stata condiscendente con me perché lei crede in un nostro remoto bisogno d'affetto, di noi soli e poveri soldati, ma ecco invece io quello che sono, ecco come ho ricevuto la sua cortesia, ecco a che punto d'impossibile ambizione sono, lei vede qui, arrivato".
E poiché ormai era chiaro che nulla riusciva a meravigliare la vedova, anzi ogni cosa pareva in qualche modo da lei prevista, allora al fante Tomagra non restava che far sì che non ci fossero più dubbi possibili, e che finalmente lo spasimo della sua follia riuscisse a cogliere anche chi n'era muto oggetto, lei.
Quando Tomagra s'alzò e sotto di lui la vedova restava con lo sguardo chiaro e severo (aveva gli occhi azzurri), col cappello guarnito di veli sempre calcato in capo, e il treno non smetteva quel suo altissimo fischio per le campagne, e fuori continuavano quei filari di vigne interminabili, e la pioggia che per tutto il viaggio aveva rigato instancabile i vetri riprendeva con nuova violenza, egli ebbe ancora un moto di paura d'avere, lui fante Tomagra, osato tanto.
Ogni volta che apriva gli occhi si sentiva addosso tutta quella luce gialla e acida dalle grandi lampade della biglietteria. E s'involgeva gli occhi nel bavero tirato della giacca, in cerca di buio e di caldo. Coricandosi non s'era accorto di come gelide e dure erano le lastre di pietra del pavimento: ora lame di freddo salivano a infiltrarglisi di sotto al vestito e per i buchi delle scarpe, e la poca carne dei fianchi gli doleva, pigiata tra le ossa e la pietra.
Il posto però se l'era scelto bene, in quell'angolo a ridosso alla scalinata, riparato e non di passaggio: tant'è vero che dopo un po' ch'era lì, arrivarono quattro gambe di donna alte sopra la sua testa e dissero: - Ehi, quello ci ha preso il posto.
L'uomo sentiva ma non era sveglio: sbavava da un angolo della bocca sul cartone scorticato della piccola valigia, il suo cuscino, e i capelli s'erano messi a dormire per conto loro, seguitando la linea orizzontale del corpo.
- Ben, - disse quella voce di prima, da sopra i ginocchi terrosi e la campana spiovente della gonna. - Si tolga. Almeno prepariamo il letto.
E uno di quei piedi, piede di donna in scarponi, lo assaggiò ai fianchi, come un muso che annusi. L'uomo si rizzò sui gomiti, annaspando nella luce gialla con palpebre smarrite e irritate, e i capelli che non s'eran accorti di niente tutti dritti. Poi ripiombò giù come volesse dare una testata dentro la valigia.
Le donne avevano tolto i sacchi di testa. L'uomo che veniva dietro posò le coperte arrotolate e cominciarono a disporsi. - Ehi, - disse la più vecchia al coricato, - alzati, almeno mettiamo anche te sotto -. Macché: dormiva.
- Deve avercene una carica, - disse la più giovane, una tutt'ossi con parti grasse quasi appoggiate alla sua magrezza: seni, natiche, che le giravano su e giù sotto la vestina, mentre lei si piegava a stendere le coperte, e a rincalzarle sotto i sacchi di farina.
Erano tre della borsanera e venivano giù coi sacchi pieni e le latte vuote. Gente che s'era fatta le ossa a dormire sul duro, per le stazioni e viaggiando sui «bestiame», però aveva imparato a organizzarsi e viaggiava con le coperte, da mettere sotto per il morbido e sopra per il caldo, e i sacchi e le latte per cuscino.
La più vecchia cercava di passare un lembo di coperta sotto all'addormentato, ma dovette tenerlo sollevato un po' alla volta perché non si muoveva. - Deve proprio avercene una carica, - fece la vecchia. - Forse è di quelli dell'emigrazione.
Intanto l'uomo ch'era con loro, un magro con le cerniere-lampo, s'era già ficcato tra una coperta e l'altra e tirato il purillo sugli occhi. - Alé. Vieni sotto: non sei pronta? - disse alle natiche della più giovane ancora china a rincalzare i sacchi per cuscino. Era sua moglie, la più giovane, ma quasi conoscevano più i pavimenti delle sale d'aspetto che il loro letto matrimoniale. Si misero sotto anche le donne, e la più giovane e il marito si strofinarono un po' fianco a fianco facendo un rumore di brividi, mentre la più vecchia rincalzava quel meschino d'addormentato. Forse la più vecchia non era tanto vecchia, ma era come scalcagnata dalla vita che faceva, sempre con carichi di farina e d'olio sulla testa, su e giù per quei treni: e portava un vestito che sembrava un sacco e i capelli che andavano in tutti i versi.
All'uomo addormentato scivolava la testa dalla valigia, ch'era troppo alta e gli faceva tenere il collo per storto; lei provò a sistemarlo meglio, ma a quello per poco non cadeva la testa in terra: così lei gli fece posare la testa su una sua spalla e l'uomo chiuse le labbra, inghiottì, s'accomodò in giù sul più morbido e riprese a sbavare, adesso in seno a lei.
Erano lì che facevano per dormire, quando arrivarono tre di Bassitalia. Erano un padre con i baffi neri e due figlie brune e grassotte, tutt'e tre piccoli di statura, con delle ceste di vimini e gli occhi schiacciati dal sonno in mezzo a tutta quella luce. Sembrava che le figlie volessero andare da una parte e lui dall'altra e così litigavano, senza guardarsi in faccia e quasi senza parlare, a furia di brevi frasi addentate, e un fermarsi e avanzare a strattoni. Scoprirono il posto già occupato da quei quattro e rimasero lì sempre più smarriti, finché non li raggiunsero due giovanotti in mollettiere e con le mantelline a tracolla.
Subito i due misero in mezzo i bassitalia, per convincerli a mettere tutte le coperte assieme e sistemarsi tutt'uno con quei quattro coricati. I giovanotti erano due venezia che emigravano in Francia, e fecero alzare i borsanera e ridisporre tutte le coperte in modo da starci quanti erano. Si capiva che era tutta una manovra per toccare seni e natiche a quelle due ragazzotte mezz'addormentate, ma alla fine erano tutti a posto, compresa la più vecchia dei borsanera che non s'era mossa perché aveva quella testa d'uomo addormentato che le dormiva in un seno. I due venezia naturalmente s'erano presi in mezzo le ragazze, lasciando da parte il bassitalia; ma, armeggiando sotto quelle coperte e mantelline, riuscivano a arrivare con le mani anche alle altre donne.
Già qualcuno russava, ma il bassitalia non riusciva a dormire, pur con tutto il sonno che gli pesava addosso. Il giallo acido di quella luce lo perseguitava fin sotto le palpebre, fin sotto la mano che gli tappava gli occhi; e il grido disumano degli altoparlanti:... accelerato... binario... partenza... lo teneva in continua inquietudine. Poi aveva bisogno d'orinare, ma non sapeva dove andare e aveva paura di perdersi in quella stazione. Finì per decidersi a svegliare uno e prese a scuoterlo: era quel disgraziato che dormiva lì fin da prima.
- La latrina, compare, la latrina, - diceva, e lo tirava per un gomito, da seduto in mezzo a quella distesa di corpi avvoltolati.
L'addormentato finì per alzarsi a sedere di scatto e spalancò i rossi occhi nebbiosi e la bocca gommosa su quella faccia chinata su di lui, quella piccola faccia da gatto, grinzosa e coi baffi neri.
- La latrina, compare... - diceva il bassitalia.
L'altro restava attonito, si guardava intorno con spavento. Rimasero tutt'e due a guardarsi a boccaperta, lui e il bassitalia. Quello sempre addormentato non capiva niente: scoprì la faccia di quella donna, per terra sotto di lui, e la fissava pieno di terrore. Forse era lì lì per dare un urlo. Poi tutt'a un tratto riaffondò la testa nel seno della donna e ripiombò nel sonno. Il bassitalia s'alzò calpestando due o tre corpi, e prese a muovere passi incerti per quel grande atrio luminoso e freddo. Di là delle vetrate si vedeva il buio limpido della notte e paesaggi di ferro, geometrici. Vide un brunetto più piccolo di lui con la guappa e l'abito gualcito che s'avvicinava con aria distratta.
- La latrina, compare, - chiese il bassitalia, supplichevole.
- Americane, svizzere, - fece l'altro che non aveva capito, facendo spuntare un pacchetto.
Era Belmoretto che sbarcava il lunario intorno le stazioni e non aveva una casa né un letto sulla faccia della terra e ogni tanto pigliava un treno e cambiava città, dove lo portavano i suoi incerti commerci di tabacco e gomma da masticare. La notte, se finiva per aggregarsi a qualche gruppo di gente che dormiva nelle stazioni aspettando le coincidenze, riusciva a sdraiarsi qualche ora sotto una coperta, se no faceva mattino girando, a meno che non incappasse in qualche vecchio invertito che se lo portava a casa e gli faceva fare il bagno, e gli dava da mangiare e da dormire con sé. Belmoretto era un bassitalia lui pure, e fu molto gentile col vecchietto dai baffi neri; lo portò alla latrina e aspettò che avesse finito di orinare per riaccompagnarlo. Gli diede da fumare e insieme fumavano e guardavano con gli occhi sabbiosi di sonno partire i treni e giù nell'atrio il mucchio di quelli che dormivano per terra.
- Si dorme come cani, - disse il bassitalia. - Sei giorni e sei notti che non vedo un letto.
- Un letto, - disse Belmoretto, - delle volte me lo sogno, un letto. Un bel letto bianco tutto per me.
Il bassitalia se ne tornò a dormire. Alzò una coperta per farsi largo e vide la mano d'un venezia infilata tra le gambe di sua figlia. Ci ficcò una mano anche lui per cacciarlo via e la carne di sua figlia ebbe un movimento molle e il venezia credeva fosse l'amico che volesse tastare un po' lui e lo spinse via con un pugno. Il bassitalia alzò il pugno su di lui bestemmiando. Gli altri gridarono che non si poteva dormire e il bassitalia li scavalcò coi ginocchi per tornare al suo posto e si mise sotto la coperta, mogio. Aveva freddo e si rincantucciò tutto: sentiva ancora intorno alla sua mano il caldo che c'era sotto le sottane di sua figlia. E gli venne voglia di piangere.
In quella tutti sentirono un corpo estraneo che s'intrufolava in mezzo a loro, come un cane che scavasse sotto le coperte. Qualche donna gridò. Subito ci fu un affannarsi a tirar via le coperte per capire cos'era. E in mezzo a loro scopersero Belmoretto che già russava aggomitolato come un feto e senza scarpe, con la testa sotto una sottana e i piedi infilati in un'altra. Svegliato a pugni nella schiena, - Scusate, - disse, - non volevo disturbare.
Ma ormai tutti erano svegli e sacramentavano, tranne quel primo, che sbavava.
- Qui ci si rompe le ossa, qui ci si gela la schiena, - dicevano. - Qui bisognerebbe spaccare quella lampada, tagliare il filo a quell'altoparlante.
- Se volete v'insegno come farvi il materasso, - disse Belmoretto.
- Materasso, - ripetevano gli altri. - Materasso.
Ma già Belmoretto aveva fatto sgombrare un po' di coperte e s'era messo a pieghettarle a fisarmonica con quel sistema che chiunque è stato in prigione conosce. Gli dissero di smettere, tanto le coperte non bastavano e qualcuno sarebbe restato senza del tutto. Allora parlarono dell'inconveniente che senza qualcosa sotto la testa non si poteva dormire e non tutti avevano qualcosa, perché i canestri dei bassitalia non servivano. Allora Belmoretto architettò tutt'un sistema, in modo che ogni uomo posasse la testa su una natica o una coscia di donna; era una cosa molto difficile per via delle coperte, ma alla fine tutti furono a posto e ne risultarono tante nuove combinazioni. Però dopo un po' tutto fu di nuovo all'aria perché non riuscivano a star fermi e allora Belmoretto trovò modo di vendere delle Nazionali a tutti e si misero a fumare e a raccontare di quante notti era che non dormivano.
- Noi già venti giorni che viaggiamo, - dissero i venezia, - tre volte che tentiamo di passare questa fottuta frontiera e ci ributtano indietro. In Francia il primo letto che vediamo è il nostro e ci dormiamo quarantott'ore filate.
- Un letto, - disse Belmoretto, - con le lenzuola di bucato e il materasso di piume da affondarci. Un letto stretto e caldo, da starci solo io.
- Che dire di noi che facciamo sempre questa vita? - disse il borsanera. - Arrivati a casa si passa una notte in letto e poi via di nuovo sui treni.
- Averci un letto di bucato, caldo, - disse Belmoretto. - Nudo, c'entrerei dentro, nudo.
- Sei notti che non ci spogliamo, - dissero le bassitalia, - che non cambiamo biancheria. Sei notti che si dorme come cani.
- Io entrerei in una casa come un ladro, - disse un venezia, - ma non per rubare. Per ficcarmi in un letto e dormirci fino al mattino.
- Oppure rubarci un letto e portarlo qui e dormirci, - disse l'altro.
A Belmoretto veniva un'idea. - Aspettate, - disse, e se ne andò.
Girò un po' sotto i portici finché non incontrò Maria la Matta. Maria la Matta se passava la notte senza trovare un cliente saltava il pasto l'indomani, perciò non s'arrendeva nemmeno alle ore piccole e continuava su e giù per quei marciapiedi fino all'alba, coi capelli rossi stopposi e i polpacci a fiasco. Belmoretto era molto amico suo.
Nell'accampamento della stazione continuavano a discutere di sonno e di letti e del dormire da cani che facevano, e aspettavano che si schiarisse il buio alle vetrate. Non eran passati dieci minuti e rieccoti Belmoretto, che arriva con un materasso arrotolato sulle spalle.
- Sotto, - disse, stendendolo per terra, - turni di mezz'ora, cinquanta lire, ci possono stare due per volta. Sotto, cosa sono venticinque lire a testa?
Aveva noleggiato un materasso da Maria la Matta che ne aveva due nel letto e adesso lo subaffittava a mezz'ore. Altri viaggiatori assonnati che aspettavano le coincidenze si avvicinarono, interessati.
- Sotto, - diceva Belmoretto. - Penso io alla sveglia. Ci mettiamo una coperta sopra e vualà che nessuno vi vede e potete farci anche i figli. Sotto.
Un venezia provò per primo, insieme a una delle ragazze bassitalia. La più vecchia dei borsanera prenotò il secondo turno per lei e quel povero addormentato che aveva addosso. Belmoretto già aveva tirato fuori un taccuino e segnava le ordinazioni, tutto contento.
All'alba avrebbe riportato il materasso a Maria la Matta e sarebbero stati a far capriole sul letto fino a giorno fatto. Poi, finalmente, si sarebbero addormentati.
Il freddo arrivò nella città una mattina di novembre, con un sole bugiardo sospeso in un cielo ipocritamente tranquillo e sgombro, e si divise per le vie lunghe e dritte come in tante lame, fece correre i gatti via dalle grondaie a rintanarsi nelle cucine ancora spente. La gente che s'alzava tardi e non apriva le finestre uscì con i soprabiti leggeri ripetendo: - Quest'anno l'inverno tarda, - e rabbrividì respirando aria gelata. Poi pensò alla provvista di carbone e legna fatta già dall'estate e si congratulò della propria previdenza.
Per i poveri fu un brutto giorno, perché non potevano più rimandare i problemi che avevano accantonato fino allora: il riscaldamento, il vestiario. Ai giardini, adocchiando i magri platani, si videro girare ragazzi spilungoni che scansavano le guardie, e nascondevano seghe dentate sotto i cappotti rammendati. Sotto al manifesto d'un'opera pia che annunciava la distribuzione di maglie e mutande invernali c'era un capannello di gente che leggeva.
Gli assistiti di una certa parrocchia dovevano andare a ritirare la roba a casa di Don Grillo. Stava Don Grillo in una vecchia casa dalle strette scale senza tromba: la porta del suo appartamento dava addirittura sui gradini, con un ciglio di pianerottolo appena accennato. E su questi gradini nei giorni di distribuzione si mettevano in coda i poveri, uno dopo l'altro bussavano alla porta chiusa e consegnavano a una stempiata e lacrimosa perpetua certificati e tagliandi, e sulla scala attendevano che la perpetua tornasse col misero fagotto. Dentro si scorgeva una stanza dai mobili tarlati e antichi e Don Grillo enorme e con la voce cavernosa e ridanciana che, seduto dietro un tavolo ingombro di fagotti, stava segnando tutto nei registri.
La coda si dipanava talvolta giù per i gomiti delle scale: vedove decadute che non uscivano mai dalle loro soffitte, mendicanti che tossivano brutto, tipi polverosi venuti d'in campagna che scalpicciavano sui gradini con le suole chiodate, giovanotti magri e spettinati - emigrati chissà donde - con sandali d'inverno e impermeabili d'estate. Alle volte questa lenta e deforme scia si prolungava giù fin oltre il mezzanino, dove s'apriva la porta a vetri della pellicceria «Fabrizia». E le signore eleganti che andavano da Fabrizia per farsi mettere in ordine il visone o l'astrakan dovevano passare rasente alla ringhiera per non sfiorare gli straccioni.
Il giorno che da Don Grillo erano in distribuzione flanelle e mutande, venne a mettersi in coda un uomo nudo. Era un vecchio facchino, alto e robusto, con una barbaccia bianca screziata di ciocche ancora bionde. Indosso aveva un cappottone militare e sotto niente. Era tutto abbottonato e imbaccuccato, ma gli stinchi erano nudi e finivano in un paio di scarponi senza nemmeno calze. La gente guardava giù e restava a bocca aperta: e lui rideva e li pigliava in giro. Aveva due grandi ilari occhi azzurri, sotto la frangia di capelli bianchi che gli scendeva in fronte, e una larga faccia vinosa e contenta.
Si chiamava Barbagallo e gli avevano rubato i vestiti sul fiume quell'estate mentre lavorava a spalar ghiaia. Fin allora aveva tirato avanti con pochi stracci, e ogni tanto finiva in prigione o all'ospizio dei vecchi, ma dalla prigione dopo un po' lo rilasciavano, dall'ospizio scappava e girovagava per la città e i paesi oziando o sfacchinando a ore qua e là. Il non aver vestiti poteva essere una buona scusa per chieder l'elemosina o per farsi mettere in prigione quando non aveva di meglio dove andare. Il freddo quel mattino l'aveva deciso a farsi dare un abito, e perciò girava nudo con solo quel cappottone, spaventando le ragazze e facendosi fermare dalle guardie a ogni crocicchio, mentre faceva la spola dall'una all'altra opera pia.
Nella coda per le scale quando arrivò non si parlò più che di lui. E lui a sbracciarsi e a contarla e a tentar tutti i trucchi per passare avanti.
- Sì, sì, sono nudo! Mi vedete? Mica solo le gambe! Volete mi sbottoni? Alé, o mi fate passare avanti o mi sbottono! Macché freddo! Mai stato tanto bene! Vuol toccare, madama, se son caldo? Solo mutande dà il prete? E io che me ne faccio? Le piglio e vado a vendermele!
Finì per sedersi in coda, sul gradino d'un pianerottolo che era proprio quello della pellicceria Fabrizia. Andavano e venivano signore, sfoggiando per i primi giorni le pellicce. - Ah! - gridavano, vedendo le gambe nude del vecchio seduto.
- Non chiami le guardie, madama, m'han già preso e mandato qui a vedere se mi vestono. E poi non mi si vede niente, non faccia tante storie.
Le signore passavano in fretta, e Barbagallo si sentiva sfiorato dalle morbide falde profumate di naftalina e di mughetto. - Bel pelo, madama, niente da dire, farà caldo lì sotto.
Ogni signora che passava lui allungava la mano e le carezzava la pelliccia. - Aiuto! - gridavano. Lui ci strofinava contro la guancia, come un gatto.
Da Fabrizia si teneva conciliabolo; nessuna osava più uscire. - Dobbiamo chiamare le guardie? - si chiedevano. - Ma se l'hanno mandato qui perché si vesta? - Ogni tanto aprivano uno spiraglio: - É ancora lì? - Una volta lui mise la testa barbuta nello spiraglio, sempre da seduto: - Uh! - Per poco non svennero.
Alla fine Barbagallo si decise: - Andiamo a parlamentare -. S'alzò e suonò da Fabrizia. Gli aprirono due lavoranti, una pallida tutta ginocchi, e una ragazzina con le trecce nere. - Chiamatemi le madame.
-Via! - fece la pallida. Ma Barbagallo non lasciava chiudere.
- Va' tu e chiamale, - disse all'altra. Quella si girò e andò. - Brava, - disse Barbagallo.
La padrona spuntò con le clienti. - Quanto mi date se non mi sbottono? - fece il facchino.
- Cosa?
- Già, poche storie -. Con una mano cominciò a sbottonarsi dal collo e dall'altra la teneva tesa. Le signore presero a cercare spiccioli nella borsetta e a darglieli. Una matrona tutta carica di gioielli sembrava non trovasse spiccioli e lo osservava coi grassi occhi bistrati. Barbagallo smise di sbottonarsi. - Allora: quanto mi dà se mi sbottono?
- Ah, ah, ah! - scoppiò la lavorante con le trecce.
- Linda! - gridò la padrona.
Barbagallo intascò i soldi e uscì. - Ciao, Linda, - disse.
Nella coda s'era sparsa la voce che non c'era abbastanza roba per tutti.
- Prima a me che son nudo! - fece Barbagallo e riuscì a mettersi in testa.
Sulla porta la perpetua giunse le mani: - Senza niente sotto! Come si fa! Aspetti, no, non entri!
- Lasciami passare, governante, o ti faccio tentare dal peccato. Dov'è il reverendo?
Entrò nell'appartamento del prete, tra sacri cuori sanguinanti in cornici barocche, canterani altissimi e crocifissi spiegati per le pareti come neri uccelli. Don Grillo s'alzò alla scrivania e cominciò una gran risata:
- Oh, oh, oh! E chi v'ha conciato in questo modo? Oh, oh, oh!
- Dica, padre, oggi è il giorno delle flanelle ma io son qui per pantaloni. Ce n'ha?
Il prete s'era ributtato nella sua poltrona dall'alto schienale e rideva a pappagorgia e pancia in aria: - No, no, oh, oh, oh, no che non ce n'ho...
- Non le chiedo mica un paio dei suoi... Vuol dire che mi fermo qui finché lei non telefona al vescovo e non se ne fa portare un paio.
- Ecco, ecco, figliolo, all'Arcivescovado, andate all'Arcivescovado, oh, oh, oh, vi do io un biglietto...
- Un biglietto. E le flanelle?
- Ecco, ecco, oh, oh, oh, vediamo un po', figliolo.
E cominciò a squadernare combinazioni di maglie e mutande lunghe, ma non trovava una misura abbastanza grande per Barbagallo. Quand'ebbero scovato la combinazione più grande che c'era, Barbagallo disse: - Adesso me la metto -. La perpetua fece in tempo a scappare sul pianerottolo prima che lui si fosse tolto il pastrano.
Rimasto nudo, Barbagallo fece un po' di flessioni, tanto per riscaldarsi, poi cominciò a infilarsi la biancheria. Don Grillo non la smetteva più di ridere, a vedere quella testa da garibaldi stretto dal collo ai polsi e alle caviglie in maglia e mutande attillatissime, con gli scarponi ai piedi.
- Iiih!! - gridò Barbagallo e si rincantucciò come avesse preso la scossa.
- Che avete, che avete, figliolo?
- Mi pizzica, mi pizzica dappertutto... Che accidenti di maglia mi ha dato, reverendo? Mi prude tutto il corpo...!
- Via, via, è nuova, si sa, è nuova, poi ci fate l'abitudine.
- Ahi, io ho la pelle delicata, adesso m'ero abituato a stare nudo... Ahi come mi prude -. E si contorceva per grattarsi la schiena.
- Via, via, basta lavarla una volta e diventa morbida come seta... Adesso andate all'indirizzo che v'ho dato e vedranno di darvi un abito, via -. E lo spingeva verso la porta facendogli rimettere il cappotto.
Barbagallo non faceva più resistenza, ormai: era un vinto. Gli chiusero la porta alle spalle. Prese a scendere chino, lamentandosi, palpandosi, e tutti quelli ancora in coda per le scale a chiedergli: - Che v'hanno fatto! V'hanno picchiato? Che coraggio! Un prete: picchiare i vecchi! Che belle mutande, però! - e gli guardarono gli stinchi inguainati nella flanella bianca.
Barbagallo sembrava invecchiato di dieci anni, gli occhi azzurri gonfi di lacrime. Se ne andava. Passò davanti alla porta della pellicciaia. A un tratto si girò, smise di lamentarsi, bussò.
La lavorante con le trecce fece capolino all'uscio. - Ma... - disse.
- Guarda, - disse Barbagallo con un sorriso sulla faccia ancora piagnucolosa, e s'indicò le mutande bianche alle caviglie.
E la ragazza disse: - Oh...
Lui era già entrato. - Chiama la madama, su! La ragazza andò. Barbagallo con un salto si nascose in una stanza laterale e ci si chiuse a chiave.
Venne la signora Fabrizia, non lo vide e tornò di là scuotendo il capo: - Perché i matti non li tengono chiusi, io non lo so...
Appena girata la chiave nella toppa, Barbagallo si strappò il cappotto di dosso, la maglia, le scarpe, le mutande, e respirò beato, finalmente nudo. Si vide riflesso in una grande specchiera, gonfiò i muscoli, fece le flessioni. Non c'era riscaldamento e tirava un freddo cane, ma lui era proprio soddisfatto. Allora cominciò a guardarsi intorno.
Era andato a chiudersi nel magazzino di Fabrizia. Appese a un lungo attaccapanni c'erano tutte le pellicce in fila. Gli occhi del vecchio facchino brillarono di gioia. Pellicce! Cominciò a passare con la mano dall'una all'altra, come suonasse un'arpa; poi ci si strofinò con una spalla, con la faccia. C'erano visoni grigi e sornioni, astrakan d'abbandonata morbidezza, volpi argentate come nuvole erbose, petit- gris e martore tenuissime e sfuggenti, bruni castori solidi e concilianti, lapin bonari e dignitosi, capretti bianchi pezzati dal secco fruscìo, leopardi dalla carezza abbrividente. Barbagallo s'accorse che stava sbattendo i denti dal freddo. Allora prese un giubbetto d'agnellone e se lo misurò: gli andava a pennello. Con una volpe si cinse i fianchi, girando la fulva coda come perizoma. Poi s'intabarrò in una pelliccia di dig-dig che doveva essere fatta per una donna cannone, tanto morbidamente riusciva a avvilupparlo. Trovò anche un paio di stivaletti foderati di castoro, e poi un bel colbacco: stava proprio bene, ancora il manicotto ed ecco, è a posto. Si crogiolò davanti allo specchio per un pezzo: non riusciva più a distinguere cos'era barba e cos'era pelo d'animale.
L'attaccapanni era ancora gremito di pellicce. Barbagallo le buttò in terra una ad una finché non ebbe sotto di sé un letto ampio e soffice da sprofondarci dentro. Allora si distese e si fece cascare addosso tutte le pellicce che restavano, a valanga. C'era un caldo che era un peccato addormentarsi tant'era delizioso crogiolarcisi, ma il vecchio facchino resistette poco e sprofondò in un sereno sonno senza sogni.
Si svegliò e vide notte alla finestra. Tutto intorno, silenzio. Certo la pellicceria era chiusa e chissà come lui sarebbe mai potuto uscire. Tese l'orecchio: un colpo di tosse, gli era parso, nella stanza accanto. Dallo spiraglio filtrava una luce.
S'alzò, bardato di visoni e volpi e antilopi e colbacchi, e aperse la porta lentamente. Alla luce d'una lampada, la lavorante con le trecce nere stava cucendo chinata a un tavolino. Dato il valore della merce in magazzino, la signora Fabrizia faceva restare una ragazza a dormire in un lettino nel laboratorio, perché potesse dar l'allarme in caso di furto.
- Linda, - disse Barbagallo. La ragazza spalancò gli occhi e vide nella penombra quel gigantesco orso umano con le braccia conserte nel manicotto d'astrakan. Disse: -...Bellissimo...
Barbagallo fece qualche passo avanti e indietro, pavoneggiandosi come un'indossatrice.
Linda disse: -... Ma ora devo chiamare la polizia.
- La polizia! - Barbagallo se l'ebbe a male. - Ma io non rubo mica. Cosa me ne faccio? Non posso certo girare così per le strade. Sono venuto qui solo per togliermi la maglia che mi prude.
Si misero d'accordo che lui avrebbe passato lì la notte e sarebbe partito di prima mattina. Anzi, Linda sapeva il sistema per lavare la roba in modo che non prudesse e gliel'avrebbe lavata.
Barbagallo l'aiutò a strizzarla e a mettere la corda per stenderla vicino a una stufetta elettrica. Linda aveva delle mele ranette e ne mangiarono.
Poi Barbagallo disse: - Vediamo un po' tu come stai con queste pellicce -. E gliele fece provare tutte, in tutte le combinazioni, con le trecce e con i capelli sciolti, e si scambiarono le loro impressioni sulla morbidezza dei vari tipi sopra la pelle nuda.
Alla fine, costruirono una capanna tutta di pellicce, grande da starci in due coricati e ci andarono dentro a dormire.
Quando Linda si svegliò lui era già alzato e s'infilava la maglia e le mutande. Dalla finestra entrava l'alba.
- É già asciutta la roba?
- Un po' umida, ma io devo partire.
- Prude ancora?
- Macché, sto come un papa.
Aiutò Linda a rimettere in ordine tutto il magazzino, indossò il cappottone militare e la salutò sull'uscio.
Linda stette a guardarlo mentre s'allontanava, con la striscia bianca delle mutande tra il cappotto e gli scarponi, e la fiera chioma all'aria fredda dell'alba.
Barbagallo non aveva intenzione d'andare all'Arcivescovado per il vestito: gli era venuta l'idea di girare per le piazze dei paesi in combinazione di maglia, a fare degli esercizi di forza.
Quella mattina il giudice Onofrio Clerici s'accorse d'un'aria diversa, nell'andare e venire delle persone. Traversava ogni giorno la città su una smilza carrozza, da casa al Palazzo di Giustizia: e giù la gente ingombrava i marciapiedi, con quel logoro scansarsi di spalle spioventi, con quegli ingorghi attorno alle nere venditrici di caldarroste, con quei gridi di ciechi: lotteria... milioni... e un battere sordo di quaderni nelle cartelle quadre degli scolari e uno sporgere dalle sporte di verze e sedani rosi da lumache.
Oggi sembrava che qualcosa di cambiato muovesse quella gente minuta: dallo sbieco delle palpebre apparivano freddi triangoli di bianco d'occhio, e tra le labbra denti. E i cappotti e gli scialli segnavano più netti angoluti contorni sugli spioventi delle spalle; e il margine dei menti sporgeva sopra gli orli dei maglioni e sopra i baveri; e il giudice Onofrio Clerici sentiva crescersi addosso un senso di disagio.
Già da settimane i segni col gesso sui muri di casa sua andavano infittendosi e ingrandendo, segni di forche e uomini impiccati appesi a forche, e gli uomini impiccati avevano sempre il berretto alto da giudice, cilindrico e in cima largo con un fiocco rotondo. Da tempo il giudice Onofrio Clerici s'era accorto che la gente lo odiava e rumoreggiava nell'aula alla sentenza, e le vedove nelle testimonianze gridavano più contro a lui che alla gabbia; ma lui era sicuro del fatto suo, e anche lui odiava loro, questa gentetta logora, non buona a rispondere a tono nelle testimonianze, non buona a sedere rispettosa nel pubblico, questa gentetta sempre carica di figli e di debiti e d'idee storte: gli italiani.
Da tempo il giudice Onofrio Clerici aveva capito chi sono gli italiani: donne sempre incinte con in braccio bambini con le croste, giovinotti dalle guance bluastre che se non c'è la guerra son buoni solo a fare i disoccupati e a vendere tabacco alle stazioni; vecchi con l'asma e l'ernia e mani tanto piene di calli da non saper reggere la penna per firmare il verbale: una razza di malcontenti, piagnucoloni e attaccabrighe, che a non tenerli a freno vorrebbero tutto per sé e s'installerebbero dappertutto trascinando i loro marmocchi crostosi e le loro ernie, e calpestando gusci di caldarroste sui pavimenti.
Per fortuna c'erano loro, la razza delle persone ammodo, una razza dalla pelle liscia e floscia, dai peli nel naso e nelle orecchie, dalle natiche stabili come fondamenta sulle poltrone imbottite, una razza tintinnante di onorificenze, decorazioni, collanine, occhiali a stanghetta, monocoli, apparecchi acustici, dentiere; una razza cresciuta per i secoli sulle poltrone barocche delle cancellerie d'antichi reami; una razza che sa fare le leggi e applicarle e farle rispettare nella misura che gli fa comodo; una razza legata da una segreta intesa, da una scoperta comune: che gli italiani sono una gentucola schifosa e in Italia si starebbe meglio se gli Italiani non ci fossero, o almeno se non si facessero tanto sentire.
Il giudice Onofrio Clerici arrivò al Palazzo di Giustizia, che era vecchio e mezzo smantellato dai passati bombardamenti, sostenuto da puntellature di travi marcite, scrostato negli intonachi e diroccato nei fregi barocchi del frontone. Una folla s'accalcava al portone chiuso, come sempre ai processi, tenuta a freno da guardie. Era venuto in uso di riservare lo spazio del pubblico a parenti e amici dell'imputato e a persone comunque fidate e rispettose; pure, ogni volta, qualcuno della folla riusciva a intrufolarsi nell'aula e a trovare un posto sulle panche in fondo, disturbando l'udienza con proteste e zittii. Gli altri restavano fuori fermi a far baccano e proteste e minacce, e alcuni anche alzavano cartelli; e il loro rumoreggiare arrivava a tratti nell'aula, innervosendo il giudice Onofrio Clerici e confermandolo in quel suo odio verso questi italiani così petulanti e invadenti nelle cose di cui non s'intendono.
Quel giorno però la folla era insolitamente zitta e composta, e non si levò da essa quel mormorio ostile vedendo il giudice Onofrio Clerici scendere dalla schiodata carrozza ed entrare nel Palazzo di Giustizia per una porticina laterale.
Dentro il Palazzo di Giustizia il senso di disagio si calmò un poco nel cuore del giudice: tutti là erano persone amiche, giudici e procuratori e avvocati, gente della razza per bene, dal sorriso inghiottito agli angoli delle labbra e con un battito ai lati della gola come branchie di rana. Erano gente pacata e ormai tranquilla: al governo e in tutte le alte cariche dello stato c'erano gente come loro, dalle palpebre calate e dalle gole di rana, e a poco a poco i petulanti italiani avrebbero rimesso la testa a segno e si sarebbero rassegnati alle croste e alle ernie che sopportavano ormai da secoli.
Aspettando l'inizio dell'udienza, mentre la corte si intabarrava nelle robe nere, un avvocato pieno di porri in faccia aveva uscito di tasca un giornale tutto contro gli italiani, e mostrava con grandi risa agli altri uomini di legge grotteschi disegni in cui gli italiani erano rappresentati come persone goffe e mostruose, coi berretti a visiera e ridicoli randelli. Uno solo di loro non rideva ai disegni: era il nuovo cancelliere, un vecchino con la testa a pigna, dall'apparenza mite e rispettosa: i magistrati uno alla volta giravano gli occhi congestionati dal ridere sulla faccia triste e rugosa di lui e il riso si smorzava in quelle loro gole di rana. «Non bisogna fidarsi di quel tipo», pensò il giudice Onofrio Clerici.
Poi la corte entrò per il processo. I processi che il giudice Onofrio Clerici presiedeva in quei tempi non erano i soliti processi contro quei quattro morti di fame che facevano i furti con scasso. Erano processi contro gente che aveva fatto arrestare e fucilare gli italiani nei tempi di una guerra che c'era stata, e il giudice Onofrio Clerici a sentire raccontare i loro casi s'era convinto che eran gente rispettabile, gente che seguiva le proprie idee, gente che ce ne sarebbe voluta ancora, per tenere a bada questi goffi italiani, sempre smunti e logori, sempre con la fame nelle ossa e nuovi piagnistei da tirar fuori.
Ma il giudice Onofrio Clerici aveva in mano le leggi, le leggi fatte sempre da loro, da loro uomini con le gole di rana, anche quando sembravano fatte per conto di quei poveri diavoli italiani; sapeva che le leggi si possono rivoltare come si vogliono e far dir bianco al nero e nero al bianco. Così assolveva tutti e la folla dopo i processi restava nella piazza a scalmanarsi fino a tardi e donne in lutto piangevano con alte grida i loro uomini impiccati.
Prendendo posto al suo seggio il giudice Onofrio Clerici esaminò il pubblico: sembrava tutta gente fidata; gente dai denti lunghi e sporgenti, dai colletti inamidati che segavano le collottole, dalle sopracciglia posate in cima ai nasi come uccellacci, e signore dagli ossuti colli gialli che sostenevano cappelli guerniti di velette. Ma approfondendo lo sguardo il giudice notò che tutta la ultima fila di panche era occupata da una gentucola che s'era intrufolata a dispetto delle disposizioni: pallide ragazze con le trecce, mutilati col mento poggiato alla stampella, uomini con gli occhi celesti circondati da rughe, anziani con gli occhiali aggiustati con spago, vecchiette imbacuccate in scialli. Quest'ultima fila di panche era un po' discosta dalla penultima, e quegli intrusi stavano seduti immobili a braccia conserte e guardavano tutti in faccia lui, giudice.
Quella stretta di disagio si faceva ancora più fitta intorno al cuore del giudice Onofrio Clerici. Due guardie, c'erano, ai lati del banco della corte, messe certo lì per proteggerli da eventuali proteste di quei disperati: ma avevano una faccia diversa da quella delle guardie solite, una faccia pallida e malinconica, con ciocche di capelli biondi schiacciate dall'orlo dei cheppì. E poi, quel cancelliere che sembrava scrivesse per conto suo, sempre chino a quel tavolo.
L'imputato era già nella gabbia, impassibile, con un vestito lindo e ben stirato. Aveva i capelli d'un grigio opaco ravviati con cura che cominciavano bassi sopra gli occhi e sugli zigomi; e pupille chiarissime che sembravano spente nell'occhiello un po' arrossato delle palpebre senza ciglia né sopracciglia; le labbra erano tumide, ma dello stesso colore della pelle; a schiuderle mostrava gli incisivi grossi e quadrati. Sotto la pelle rasata la barba aveva lasciato un'ombra come di marmo. Le mani, aggrappate con gesto calmo alle sbarre, avevano dita grosse e piatte come timbri.
Cominciò l'udienza. I testimoni erano la solita gentetta piena di piagnistei: gridavano, specie le donne, puntando il braccio contro la gabbia: - É lui... l'ho visto io con questi occhi... ha detto: ora avete il fatto vostro, banditi... figlio unico, il mio Gianni... così ha detto: non vuoi parlare, ebbene ecco, cane...
Gente che non sa fare delle deposizioni come si deve, pensava il giudice Onofrio Clerici, gente disordinata, indisciplinata e irrispettosa: in fin dei conti quell'uomo nella gabbia era stato un loro superiore e loro non l'avevano ubbidito. Ora dava a loro una lezione di contegno, impassibile in quella gabbia, guardandoli con quelle pupille incolori, senza negare, con una leggera aria di noia.
Il giudice Onofrio Clerici invidiava la sua calma. Quel senso di disagio gli andava aumentando. Fuori, dei colpi di martello di operai che lavoravano nel cortile del Palazzo di Giustizia lo tenevano nervoso. Certo lavoravano a puntellare il sempre traballante edifizio: dalle alte finestre chiesastiche dell'aula si vedevano assi e tavole trasportate da braccia nude. «Chissà perché lavorano mentre qui si fa udienza?» si chiedeva il giudice Onofrio Clerici, e più volte fu sul punto di mandare l'usciere a dire che smettessero, ma ogni volta qualcosa lo tratteneva.
Attraverso le testimonianze si stava ricostruendo la scena del più importante capo d'accusa: una uccisione di uomini e donne e vecchi sulla piazza d'un paese dato poi alle fiamme. A poco a poco la visione del cumulo di cadaveri in mezzo alla piazza appariva chiara agli occhi del giudice Onofrio Clerici; ed egli interrogava con meticolosità e rigore per ricostruire la scena nei suoi particolari più minuti. I morti erano stati nella piazza un giorno e la notte, senza che nessuno potesse avvicinarli; Onofrio Clerici pensava a quei gialli corpi ossuti nel lurido dei loro stracci inzuppati di sangue grumoso, con grosse mosche nere che si posavano sulle labbra, sulle narici. Il pubblico dell'ultima fila continuava a tenersi calmo, chissà mai perché; e il giudice Onofrio Clerici per vincere la soggezione che essi gli incutevano provò a immaginare loro, uccisi e accatastati, con gli occhi aperti come buchi e vermi di sangue sotto le narici.
- Allora lui s'avvicinò ai nostri morti, - disse un vecchio testimone, barbuto e curvo, - io lo vidi: e si fermò davanti a loro; e proprio così fece ai nostri morti come io ho schifo di fare a lui: sputò.
Il giudice Onofrio Clerici vedeva quei morti italiani già gialli, ombelichi lividi scoperti, sottane rialzate su gambe ossute, e sentiva la saliva salire pure alle sue labbra. Guardò le labbra dell'imputato, sporgenti e pallide: lo spuntare d'una perla di saliva sarebbe stato bellissimo in mezzo a quelle labbra, quasi se ne sentiva un segreto bisogno. Ecco, al ricordo, l'imputato schiudeva le labbra, ecco sopra i denti incisivi grossi e quadri una leggera schiuma, appariva; oh come il giudice Onofrio Clerici comprendeva lo schifo dell'imputato, quello schifo che l'aveva portato a sputare addosso ai morti.
Il difensore faceva la sua arringa: era quell'ometto basso e panciuto, pieno di porri in faccia che si divertiva tanto alle vignette contro la povera gente. Vantò i meriti dell'imputato, la sua attività di funzionario zelante, tutto dedito alla tutela dell'ordine: considerate tutte le attenuanti chiese il minimo degli anni di pena.
Il giudice Onofrio Clerici non sapeva dove guardare durante l'arringa. Se posava gli occhi sul pubblico subito era innervosito dallo sguardo di quegli italiani del fondo, a occhi interminabilmente aperti su di lui. E quel martellare e quel trasportar di tavole, che non smetteva mai, là fuori... Ora, di là dalle finestre, si vedeva una corda, e due mani che la svoltolavano, come per vedere quant'era lunga. A che mai poteva servire, quella corda?
Parlava il Pubblico Ministero, adesso. Era un uomo di lunghe ossa, che s'appoggiava sugli spigoli sporgenti delle anche, e divaricava mascelle canine traversate da tendini di bava. Cominciò a dire della necessità di far giustizia dei tanti crimini commessi in quei tempi, e di punire i veri colpevoli; poi aggiunse che l'imputato non era certo uno di questi e che non poteva fare di meno di quel che aveva fatto. Terminò chiedendo la metà della pena richiesta dal difensore.
Il pubblico delle prime file applaudì, con uno strano rumore d'ossa e insieme di sculacciate. Il giudice Onofrio Clerici pensava: ora quelli là in fondo grideranno. Ma restavano sempre immobili e intenti, non si capiva cosa avessero.
La corte si ritirò per deliberare nella saletta attigua. Da una finestra della saletta si vedeva bene il cortile e finalmente il giudice Onofrio Clerici poté capire quale lavoro avessero fatto là fuori con quelle travi e quella corda. Una forca: avevano costruito una forca proprio in mezzo al cortile; ormai era finita e stava lì magra e nera con il nodo scorsoio penzoloni; gli operai se n'erano andati.
«Stupidi e ignoranti, - pensò il giudice Onofrio, - credono che l'imputato sia condannato a morte, perciò han costruito una forca. Ma gliela farò vedere io!» E per dar loro una lezione propose alla corte, per mezzo di cavilli giuridici che solo lui conosceva, che l'imputato fosse assolto. La corte approvò all'unanimità la sua proposta.
Alla lettura della sentenza il più emozionato era il giudice. Nessuno batté ciglio, né l'imputato con le sue dita a timbro strette alle sbarre, né il pubblico per bene, né gli intrusi. Quelle ragazze pallide e trecciute, quei mutilati, quelle vecchie in scialle, stavano in piedi, a testa alta, con un coro di sguardi fiammeggianti.
S'avvicinò il cancelliere per far firmare la sentenza al giudice; sembrava, dall'umile tristezza con cui gli sottoponeva i fogli, che portasse a firmare una condanna a morte. I fogli: perché sotto il primo, ecco, ce n'era un secondo di cui il cancelliere scoprì solo il margine di fondo facendo scorrere l'altro sopra. E il giudice firmò anche questo. Aveva addosso gli sguardi fiammeggianti dagli occhiali con lo spago, dai celesti occhi rugosi. Sudava, il giudice.
Ecco, ora il cancelliere faceva scorrere via il primo foglio, e via e via: sotto, sul secondo foglio, il giudice Onofrio Clerici lesse: Onofrio Clerici, giudice, reo d'aver insultato e deriso per lungo tempo noialtri poveri italiani, è condannato a morire impiccato come un cane. Sotto, lui aveva firmato.
Le due guardie dal triste viso biondo gli erano venute ai lati. Non lo toccarono, però.
- Giudice Onofrio Clerici, - dissero. - Vieni con noi.
Il giudice Onofrio Clerici si voltò. Le guardie, una da una parte una dall'altra, senza toccarlo lo condussero per una porticina, nel cortile deserto, ai piedi della forca.
- Sali su quella forca, - dissero.
Ma non lo spingevano. - Sali, - dissero. Onofrio Clerici salì.
- Metti la testa nel nodo, - dissero.
Il giudice infilò la testa nel cappio scorsoio. Quelli quasi non lo guardavano.
- Dài un calcio allo sgabello, adesso, - dissero, e se ne andarono.
Il giudice Onofrio Clerici buttò giù lo sgabello e sentì la corda serrarglisi al collo, la gola chiuderglisi come un pugno, schiantargli le ossa. E gli occhi, come grandi lumache nere, gli uscivano dal guscio delle orbite, quasi la luce che cercavano potesse convertirsi in aria, e intanto il buio s'andava addensando ai pilastri del cortile deserto; deserto perché quella gentucola italiana non era nemmeno venuta a vederlo morire.
Da qualche tempo erano cominciati nella città i rastrellamenti delle armi nascoste. I poliziotti montavano sulle camionette con in testa i caschi di cuoio che davano loro fisionomie uniformi e disumane, e via per i quartieri poveri a suon di sirena verso qualche casa di manovale o d'operaio, a scompigliare biancheria nei cassettoni e a smontar tubi di stufe. Una struggente angoscia s'impadroniva in quei giorni dell'animo dell'agente Baravino.
Baravino era un disoccupato che da poco tempo s'era arruolato nella polizia. Da poco tempo quindi egli aveva saputo d'un segreto che esisteva in fondo a quella città apparentemente placida e operosa: dietro le mura di cemento che s'allineavano lungo le vie, in recinti appartati, in scantinati oscuri, una foresta d'armi lucide e minacciose giaceva guardinga come aculei d'istrice. Si parlava di giacimenti di mitragliatrici, di miniere sotterranee di proiettili; c'era, si diceva, chi dietro una porta murata teneva un cannone intero in una stanza. Come tracce metallifere che indicano l'approssimarsi d'una regione mineraria, nelle case della città si riscontravano pistole cucite dentro i materassi, fucili inchiodati sotto gli impiantiti. L'agente Baravino si sentiva a disagio in mezzo alla sua gente; ogni tombino, ogni catasta di rottami gli sembrava custodisse incomprensibili minacce; spesso pensava al cannone nascosto e gli accadeva d'immaginarlo nel salotto buono dov'era entrato una volta da bambino, nella casa dove sua madre faceva i servizi: una di quelle stanze che rimangono chiuse anni ed anni. Vedeva il cannone tra i divani di velluto stinto guerniti di pizzo, con le ruote fangose sul tappeto e l'affusto che toccava il lampadario; grande che riempiva tutto il salotto e scorticava la vernice al pianoforte.
Una sera la polizia fece una corsa nei quartieri operai e circondò tutta una casa. Era un grande edificio dall'aria sfatta, come se il sostenere tanta umanità assiepata ne avesse deformato i piani e i muri, avesse ridotto anch'essi ad una vecchia carne porosa, callosa ed incrostata.
Intorno al cortile ingombro di barili d'immondizie correvano a ogni piano le ringhiere dei ballatoi di ferro rugginose e storte; ed a queste ringhiere, e a spaghi tirati dall'una all'altra, panni appesi e stracci, e lungo i ballatoi porte-finestre con legni al posto di vetri, traversati dai neri tubi delle stufe, e al termine dei ballatoi, uno sopra l'altro come in scrostate torri, le baracche dei cessi, tutto così un piano sopra l'altro, intervallati dalle finestrelle dei mezzanini rumorose di macchine da cucire e vaporose di minestra, fino in cima, alle inferriate delle soffitte, alle gronde sbilenche, ai cenciosi abbaini aperti come forni.
Un labirinto di logore scale traversava dalle cantine al tetto il corpo della vecchia casa, come nere vene dalle ramificazioni innumerevoli, e sulle scale, sparpagliate come a caso, s'aprivano le porte dei mezzanini e dei promiscui appartamenti. Gli agenti salivano senza riuscire a cambiare il suono lugubre dei propri passi, e cercavano di decifrare i nomi segnati sulle porte, e giravano giravano in fila indiana per quei sonanti ballatoi, tra un far capolino di bambini e donne spettinate.
Baravino era in mezzo a loro, indistinguibile da loro sotto il casco di automa che gettava una cruda ombra sui suoi nuvolosi occhi celesti; ma il suo animo era in preda a confusi turbamenti. Dei loro nemici, gli era stato detto, nemici di loro poliziotti e gente d'ordine, si nascondevano dentro quella casa. L'agente Baravino guardava con sgomento dagli usci socchiusi nelle stanze: in ogni armadio, dietro qualsiasi stipite potevano celarsi armi terribili; perché ogni inquilino, ogni donnetta li guardava con pena mista ad ansia? Se qualcuno tra loro era il nemico, perché non avrebbero potuto esserlo tutti? Dietro i muri delle scale le immondizie buttate nei condotti verticali cadevano con tonfi; non potevano essere le armi di cui ci s'affrettava a sbarazzarsi?
Scesero in una stanza bassa, dove una famigliola stava cenando a un desco a quadrettoni rossi. I bambini gridarono. Solo il più piccolo, che mangiava sulle ginocchia del babbo, li guardò zitto, con occhi neri e ostili. - Ordine di perquisire la casa, - disse il brigadiere accennando un attenti e facendo sobbalzare i cordoncini colorati sul suo petto. - Madonna! A noi povera gente! A noi onesti tutta la vita! - disse una donna anziana, con le mani al cuore. Il babbo era in maglietta, una faccia larga e chiara, punteggiata di barba dura a radere; imboccava il piccino a cucchiaiate. Prima li guardò con un'occhiata traversa e forse ironica; poi scrollò le spalle e badò al bimbo.
La stanza era piena di poliziotti che non ci si poteva rigirare. Il brigadiere dava ordini inutili e impicciava invece di dirigere. Con sgomento Baravino guardava ogni mobile, ogni stipo. Quell'uomo in maglietta, ecco, era il nemico: e certo se non l'era stato fino a quel momento, ormai lo era diventato, irreparabilmente, a vedersi rovesciare i cassetti e sradicare dai muri i quadri delle madonne e dei parenti morti. E se era loro nemico, ecco, la sua casa era piena d'insidie: nel canterano ogni cassetto poteva contenere mitragliatrici smontate tutte in ordine; se apriva gli sportelli della credenza baionette inastate di fucili potevano puntarglisi sul petto; sotto le giacche appese nell'attaccapanni forse penzolavano nastri di proiettili dorati; ogni casseruola, ogni tegame covava una guardinga bomba a mano.
Baravino muoveva impacciato le lunghe esili braccia. Tintinnò un cassetto: pugnali? No: posate. Rimbombò una cartella: bombe? Libri. La camera da letto era ingombra da non potersi attraversare: due letti matrimoniali, tre brandine, due pagliericci abbandonati in terra. E, all'altro estremo della stanza, seduto in un lettino, c'era un bambino con il mal di denti che si mise a piangere. L'agente già voleva aprirsi un varco tra quei letti per rassicurarlo; ma se fosse stato poi di sentinella a un arsenale mascherato, se sotto a ogni giaciglio fosse nascosto un fusto di mortaio?
Gira gira, Baravino non frugava in nessun posto. Provò a aprire una porta: resisteva. Forse il cannone! Se l'immaginava nel salotto buono di quella casa del suo paese, con un vaso di rose artificiali che spuntava dalla bocca da fuoco, un passamano di pizzo sugli scudi, e statuine di ceramica posate con innocenza sui congegni. La porta cedé a un tratto: non era un salotto ma un ripostiglio, con sedie spagliate e casse. Tutta dinamite? Ecco! Per terra Baravino vide il segno di due ruote; qualcosa a ruote era stato trainato fuori dalla stanza via per uno stretto corridoio. Baravino seguì l'orma. Era il nonno che spingeva via la carrozzella più presto che poteva. Perché scappava quel vecchietto? Forse quella coperta sulle gambe gli serviva per nascondere un'accetta! Io gli passo vicino e il vecchio mi spacca in due la testa con un colpo! Andava al gabinetto, invece. Che fosse là il segreto? Baravino corse sul ballatoio ma s'aperse la porta del gabbiotto, e ne uscì una bambina con un fiocco rosso e un gatto tra le braccia.
Baravino pensò che doveva farsi amici i bambini, e far loro domande. Avanzò una mano per carezzare il gatto. - Bello, micio, - disse. Il gatto scattò via quasi contro di lui; era un gatto grigio e magro, di pelo corto e tutto tendini. Digrignava i denti e si muoveva a balzi come un cane. - Bello, micio, provò ad accarezzarlo Baravino, come se il problema per lui fosse tutto nel farsi amico di quel gatto. Ma il gatto scartò obliquo, e fuggì ogni tanto girandosi con malevole occhiate.
Baravino spiccava balzi per il ballatoio, rincorrendolo. - Micio, bello, micio, - diceva. Entrò in una stanza dove due ragazze lavoravano chine alle macchine da cucire. Per terra c'erano mucchi di ritagli. - Armi? - chiese l'agente e sparpagliò le stoffe con il piede rimanendo impastoiato e drappeggiato di rosa e lilla. Le ragazze risero.
Girò un andito e una rampa di scale; il gatto pareva alle volte lo aspettasse, poi quando s'era fatto più vicino saltava via a zampe pari e rigide. Uscì su un altro ballatoio: era ostruito da una bicicletta a ruote all'aria; un omino in tuta cercava un buco in un pneumatico immergendolo in un catino d'acqua. Il gatto era già dall'altra parte. - Permesso, fece l'agente. - C'è, - disse l'omino, e l'invitò a guardare: dalla gomma nell'acqua si levavano mille bollicine. - Permesso? - Che fosse stato tutto preparato per sbarrargli la via, o per buttarlo giù dalla ringhiera?
Passò. In una stanza c'era solo una branda e un giovanotto supino a torso nudo che fumava con le mani sotto la testa riccia. Aria sospetta. - Scusi, ha visto un gatto? - Era una buona scusa per perquisire sotto il letto. Baravino allungò una mano e si prese una beccata. Saltò fuori una gallina, allevata in casa di nascosto nonostante i decreti del comune. Il giovanotto a torso nudo non aveva mosso ciglio: continuava a fumare coricato.
Traversato un pianerottolo l'agente si trovò nel laboratorio d'un occhialuto cappellaio. - Perquisire... ordine... - disse Baravino e una pila di cappelli: lobbie, pagliette, tube, cadde e si sparpagliò sul pavimento. Il gatto saltò fuori da una tenda, giocò rapidamente coi cappelli e fuggì via. Baravino non sapeva più se ce l'aveva con quel gatto o se voleva solo diventargli amico.
In mezzo a una cucina c'era un vecchietto col berretto da postino e i calzoni rimboccati che faceva il bagno ai piedi. Appena visto l'agente, sogghignando gli fece cenno verso un'altra stanza. Baravino s'affacciò. - Aiuto, - gridò una grassa signora quasi nuda. Baravino, pudico, disse: - Scusi -. Il postino sogghignava, le mani sui ginocchi. Baravino riattraversò la cucina e andò in terrazzo.
Il terrazzo era tutto pavesato di panni stesi ad asciugare. L'agente camminava tra corridoi ciechi e bianchi, in un labirinto di lenzuola; il gatto ogni tanto appariva strisciando sotto un lembo e scompariva appiattito sotto un altro. A Baravino prese a un tratto il timore d'essersi perduto; forse era rimasto tagliato fuori, i suoi commilitoni avevano sgombrato l'edificio, e lui era prigioniero di quella gente giustamente offesa, prigioniero di quei bianchi panni stesi. Trovò un varco, alla fine, e riuscì ad affacciarsi ad un muretto. Sotto, s'apriva il pozzo del cortile con le luci che cominciavano ad accendersi intorno ai ballatoi di ferro. E lungo le ringhiere, su e giù per le scale, Baravino vide, non sapeva se con sollievo od ansia, il formicolio dei poliziotti e sentiva i comandi, i gridi di spavento, le proteste.
Il gatto s'era seduto sul muretto al suo fianco e muoveva la coda guardando in giù con aria indifferente. Ma quando lui si mosse saltò via: una scaletta portava a un abbaino, e il gatto vi sparì. L'agente lo seguì: non aveva più paura. L'abbaino era quasi vuoto: fuori la luna cominciava a prender lucentezza sulle nere case. Baravino s'era tolto il casco: il suo viso era tornato umano, esile viso di ragazzo biondo.
- Non un passo di più, - disse una voce, - sei sotto il tiro della mia pistola.
Sullo scalino della grande finestra c'era accoccolata una ragazza coi capelli lunghi sulle spalle, dipinta, con le calze di seta e senza scarpe, che con voce raffreddata compitava alle ultime luci della sera su di un giornale tutto fatto di figure e di poche frasi in stampatello.
- Pistola? - disse Baravino e le prese un polso come per aprirle il pugno. Appena lei mosse il braccio il golfino le si aprì sul petto e il gatto raggomitolato a palla ne saltò fuori in aria, contro di lui, agente Baravino, digrignando i denti. Ma l'agente capì ch'era ormai un gioco.
Fuggì sui tetti, il gatto, e Baravino affacciato alla bassa ringhiera lo contemplava mentre correva libero e sicuro sulle tegole.
- E Mary vide presso il suo letto, - continuava a leggere la ragazza, - il baronetto in frac con l'arma puntata.
Intorno s'accendevano le luci nelle case operaie alte e solitarie come torri. L'agente Baravino vedeva l'enorme città sotto di sé: costruzioni di ferro geometriche s'alzavano dentro i recinti delle fabbriche, rami di nuvole si muovevano sui fusti delle ciminiere traversando il cielo.
- Volete le mie perle, Sir Enrico? - compitava ostinata quella intasata voce. - No, voglio te, Mary.
A un alzarsi di vento Baravino vide contro di sé quella intricata distesa di cemento e ferro; da mille nascondigli l'istrice rialzava i suoi aculei. Era solo in terra nemica, ormai.
- Ho la ricchezza e l'eleganza, abito in un lussuoso palazzo, ho la servitù e gioielli, cosa posso chiedere di più dalla vita? - proseguiva la ragazza con i neri capelli che le piovevano sul foglio istoriato di donne serpigne e uomini dal lucido sorriso.
Baravino sentì il trillo dei fischietti e il rombo dei motori: la polizia abbandonava l'edificio. Avrebbe voluto fuggire sotto le catene di nuvole del cielo, seppellire la sua pistola in una grande buca scavata nella terra.
Alla villa del finanziere Pomponio gli invitati prendevano il caffè sulla veranda. C'era il generale Amalasunta che spiegava la terza guerra mondiale con le tazzine e i cucchiaini, e la signora Pomponio diceva - Spaventoso! - sorridendo, da quella donna di sangue freddo che era.
Solo la signora Amalasunta faceva un po' la costernata e poteva permetterselo dato che suo marito era tanto coraggioso da volere subito la guerra totale su quattro fronti. - Speriamo che non duri tanto... - lei diceva.
Ma il giornalista Strabonio era scettico: - Eh, eh, tutto previsto, - diceva. - Ricorda, eccellenza, quel mio articolo, già l'anno passato...
- Eh, eh, - annuiva Pomponio che se ne ricordava perché quell'articolo Strabonio l'aveva scritto dopo un colloquio con lui.
- Con questo non si deve escludere... - disse l'onorevole Uccellini che non era riuscito a dimostrare chiaramente la missione pacificatrice del Papato prima, durante e dopo l'immancabile conflitto.
- Ma sì, ma sì, onorevole... - fecero gli altri con tono conciliante. La moglie dell'onorevole era l'amante di Pomponio e non gli si potevano dare tanti dispiaceri.
Il mare si vedeva negli intervalli della tenda a righe, strofinarsi contro la spiaggia come un tranquillo gatto inconsapevole, arcuandosi alle passate della brezza.
Entrò un cameriere e chiese se volevano dei frutti di mare. Era venuto un vecchio, disse, con una cesta di ricci e di patelle. La discussione dal pericolo di guerra passò al pericolo di tifo, il generale citò gli episodi africani, Strabonio citò degli episodi letterari, l'onorevole dava ragione a tutti. Pomponio, che se ne intendeva, disse che facessero venire lì il vecchio con la roba e avrebbe scelto lui.
Il vecchio si chiamava Bacì Degli Scogli; fece delle storie con il cameriere perché non voleva che toccasse le ceste. Le ceste erano due, mezzo sfasciate e ammuffite: una la reggeva contro un fianco e appena entrato la lasciò cadere a terra; l'altra, ch'egli teneva su una spalla, stando tutto contorto, doveva essere pesantissima ed egli la posò a terra con molta attenzione. Era chiusa da un pezzo di sacco legato intorno.
La testa di Bacì era coperta da una lanugine bianca, senza differenza di capelli e barba. La poca pelle nuda era rossa come se da anni il sole non riuscisse ad abbronzarla ma solo a bollirla e scorticarla; e gli occhi erano sanguigni come se fin la cispa gli si fosse trasformata in sale. Aveva un corpo basso, da ragazzo, con membra nodose che sporgevano dagli strappi del vestito vetusto, indossato sulla pelle, senza neanche camicia. Le scarpe doveva averle pescate in mare, tanto sformate, spaiate, incartapecorite erano. E da tutta la sua persona s'alzava un forte odore d'alghe marce. Le signore dissero: - Che caratteristico.
Bacì Degli Scogli, scoperta la cesta leggera, andava mostrando i ricci ammucchiati in un digrignare d'aculei neri e lucidi. Con quelle sue mani vizze, tutte punti neri di spine conficcate, maneggiava i ricci come fossero conigli da prender per le orecchie, e li rivoltava e mostrava la polpa rossa e molle. Sotto i ricci c'era un ripiano di sacco e sotto ancora le patelle, coi piatti corpi zonati giallo-bruni sotto i gusci barbuti e lichenosi.
Pomponio esaminava ed annusava: - Non sboccano mica delle fogne, dalle vostre parti, no?
Bacì sorrise nella sua lanugine: - Eh, no, io sto sulla punta, le fogne le avete voi qui, dove fate i bagni...
Gli invitati cambiarono discorso. Comprarono dei ricci, delle patelle e incaricarono Bacì di fornirne loro ancora nei giorni venturi. Anzi, gli diedero ciascuno il proprio biglietto da visita, in modo ch'egli potesse fare il giro delle loro ville.
- E che ci avete in quell'altra cesta? - chiesero.
- Eh, - il vecchio ammiccò, - una bestia grossa. Una bestia che non vendo.
- Che ve ne fate allora? La mangiate?
- Mangiarla! É una bestia di ferro... Bisogna che trovi il suo padrone, per ridargliela. Che se la sbrighi un po' lui, dico bene?
Gli altri non capivano.
- Sapete, - lui spiegò, - la roba che il mare porta a riva, io la divido. Da una parte le latte, dall'altra le scarpe, le ossa da un'altra ancora. Ed ecco che mi arriva quest'accidente. Dove lo metto? Lo vedo al largo che viene avanti, mezzo sott'acqua e mezzo sopra, verde d'alghe e rugginoso. Perché li mettono in mare questi accidenti, io non capisco. Vi piacerebbe, trovarli sotto il letto? o in un armadio? Io l'ho preso e adesso cerco chi è che ce li mette e gli dico: tienilo un po' tu, fa' il favore!
E così dicendo aveva avvicinato con cautela la cesta, aveva slegato il coperchio di sacco e aveva scoperto un grosso, mostruoso, ferreo oggetto. Le signore dapprima non capirono, ma diedero in un grido quando il generale Amalasunta esclamò: - Una mina! - La signora Pomponio andò in deliquio.
Ci fu una gran confusione, chi si affannava a far vento alla signora, chi assicurava: - Certo è inoffensiva, da tanti anni così, alla deriva... - chi diceva: - Bisogna portarla via, bisogna arrestare quel vecchio -. Ma il vecchio intanto era sparito, con la terribile cesta.
Il padrone di casa chiamò la servitù: - L'avete visto? Dov'è andato? - Nessuno poteva assicurare fosse uscito. - Cercate per tutta la casa: aprite gli armadi, i comodini, vuotate la cantina!
- Si salvi chi può, - gridò Amalasunta improvvisamente impallidito. - Questa casa è in pericolo, via tutti!
- Perché proprio la mia? - protestò Pomponio. - E la sua, generale, pensi alla sua!
- Bisognerà che vada a sorvegliare casa mia... - disse Strabonio che s'era ricordato di certi suoi articoli di una volta e di adesso.
- Pietro! - gridava la signora Pomponio, rinvenuta, gettandosi al collo del marito.
- Pierino! - gridava la signora Uccellini, gettandosi anch'essa al collo di Pomponio e scontrandosi con la legittima consorte.
- Luisa! - osservò l'onorevole Uccellini. - Andiamo a casa!
- Non crederà mica che casa sua sia più sicura? - gli dissero. - Con la politica che fa il suo partito, lei è più in pericolo di noi!
Uccellini ebbe un lampo di genio: - Chiamiamo la polizia!
La polizia si scatenò per la cittadina rivierasca, alla ricerca del vecchio con la mina. Le ville del finanziere Pomponio, del generale Amalasunta, del giornalista Strabonio e dell'onorevole Uccellini ed altre ancora furono piantonate da picchetti armati, e reparti di sminatori del Genio le ispezionarono dalla cantina alle soffitte. I commensali di villa Pomponio si disposero a bivaccare all'aperto quella notte.
Intanto un contrabbandiere chiamato Grimpante, che grazie alle sue amicizie riusciva sempre a sapere tutto, s'era messo per conto suo sulle piste di Bacì Degli Scogli. Grimpante era un omaccione con un berrettino marinaro di tela bianca; gli affari loschi che si svolgevano sul mare e sulla riva passavano tutti per le sue mani. Fu facile a Grimpante, fatto il giro di qualche osteria del quartiere delle Case Vecchie, d'imbattersi in Bacì che usciva brillo con la misteriosa cesta in spalla.
Lo invitò a bere all'Osteria dell'Orecchia Mozzata, e versando da bere cominciò a spiegargli la sua idea.
- É inutile che restituisci la mina al proprietario, - diceva, - tanto lui appena può la rimette dove l'hai trovata. Invece, se dài retta a me, ci prendiamo tanti di quei pesci da invadere i mercati di tutta la riviera e farci milionari in pochi giorni.
Bisogna sapere che un monello chiamato Zefferino, solito a ficcare il naso dappertutto, aveva seguito i due nell'Osteria dell'Orecchia Mozzata e s'era nascosto sotto il tavolo. E capito a volo quel che intendeva Grimpante scappò via e corse a passar la voce tra i poveri delle Case Vecchie.
- Ehi, volete farvi il fritto, oggi?
Dalle finestre strette e sbilenche s'affacciavano donne magre e spettinate con bambini al petto, vecchi con il cornetto acustico, comari che pelavano radicchi, giovani disoccupati che si facevano la barba.
- E come? E come?
- Zitti zitti, venite con me, - disse Zefferino.
Grimpante che aveva fatto un salto a casa sua, tornò con una custodia da violino e s'incamminò col vecchio Bacì. Presero la strada che fiancheggiava il mare. Dietro, in punta di piedi, venivano i poveri delle Case Vecchie. Le donne ancora in grembiale, con le padelle a spall'arm, i vecchi paralitici nelle carrozzelle, i mutilati con le stampelle, e una torma di ragazzini tutt'intorno al branco.
Giunti sugli scogli della punta, la mina fu abbandonata in mare, a una corrente che la portava verso il largo. Grimpante aveva tirato fuori dalla custodia di violino uno di quegli arnesi ammazzacristiani che sparano a raffica e l'aveva piazzato dietro un riparo di scogli. Quando la mina gli fu a tiro cominciò a sparacchiare: i colpi sull'acqua segnavano una scia di piccoli zampilli. I poveri, ventre a terra sullo stradone litoraneo, si turarono gli orecchi.
Tutt'a un tratto una grande colonna d'acqua s'alzò nel mare dal punto dove prima era la mina. Il fragore fu enorme: i vetri delle ville andarono in frantumi. L'ondata arrivò fin allo stradone. Appena le acque si quetarono cominciarono a venire a galla le pance bianche dei pesci. Grimpante e Bacì stavano mettendo mano a una gran rete, quando furono travolti dalla folla che correva verso il mare.
I poveri si misero in acqua vestiti, chi con le scarpe in mano e i calzoni rimboccati, chi con le scarpe e tutto, le donne con le sottane galleggianti a cerchio: e tutti giù ad acchiappare i pesci morti. Chi li pescava con le mani, chi col cappello, chi con le scarpe, chi li metteva in tasca, chi nella borsetta. I ragazzi erano i più veloci ma non s'azzuffavano: tutti erano d'accordo di dividerli in parti uguali. Anzi, badavano ad aiutare i vecchi che ogni tanto scivolavano sott'acqua e uscivano con la barba piena d'alghe e granchiolini. Le più fortunate erano le beghine che procedevano a due a due coi loro veli tesi a fior d'acqua e rastrellavano tutto il mare. Le belle ragazze ogni tanto gridavano: - Ih... ih... perché un pesce morto saliva loro sotto le sottane, e i giovanotti giù a cercare di pescarlo.
Sulla riva cominciarono ad accendersi fuochi d'alghe secche e comparvero le padelle. Ognuno tirò fuori di tasca un boccettino d'olio e si cominciò a sentire odor di fritto. Grimpante se l'era svignata perché la polizia non lo acciuffasse con quell'arrotavivi per le mani. Bacì Degli Scogli invece se ne stava in mezzo agli altri, con pesci, granchi e gamberi che gli spuntavano da tutti gli strappi del vestito, e si mangiava una triglia cruda dalla contentezza.
|
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2024